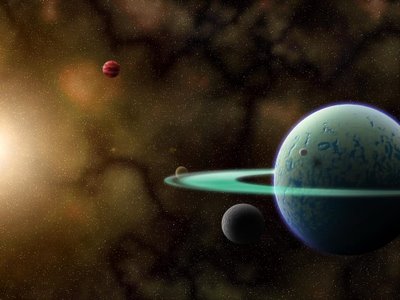In un momento di grande confusione tra cattolici, non solo tra cristiani, cerco di inserirmi nella comunicazione con questo strumento per dare voce alla mia fedeltà alla Chiesa e al Papa. "Credo nella Chiesa Cattolica credo alla Chiesa Cattolica" (Don Mario Occhiena)
sabato 12 agosto 2006
Il sacrificio di Cristo ed il suo significato nella narrazione allegorica di C.S.Lewis
Il sacrificio di Cristo ed il suo significato nella narrazione allegorica di C.S.Lewis, ora sugli schermi nella versione cinematografica di Andrew Adamson Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio
di Andrea Lonardo
Tratto dal sito della parrocchia di Santa Melania
Riguardo all'altro nome di Aslan, vorrei davvero che fossi tu ad indovinare. C'è mai stato qualcuno in questo nostro mondo che: 1) giunse nello stesso periodo di Babbo Natale; 2) disse di essere il figlio del Grande Imperatore; 3) per la colpa di qualcun altro diede se stesso a degli uomini cattivi che lo derisero e lo uccisero; 4) tornò in vita; 5) viene alle volte chiamato l'Agnello (vedi la conclusione del Veliero)? Davvero non sai il Suo nome in questo mondo? Pensaci su e fammi sapere la tua risposta!
Così C.S.Lewis, autore dei tre volumi de Le cronache di Narnia da un episodio dei quali è tratto il film di A.Adamson in questi giorni sugli schermi, rispondeva ad Hila, una bambina americana lettrice delle sue fiabe (1) . La decisione di dare vita ad una allegoria di Cristo, nella sua creazione di fantasia, è evidente. Il leone Aslan è figura di Cristo che vince il gelo e la morte del mondo offrendo se stesso alla morte per la salvezza di uno dei bambini protagonisti della fiaba, Edmund, colpevole di tradimento, e risorge a vita nuova, per essere con i suoi nella battaglia finale contro la Strega Bianca e le forze maligne che la accompagnano.
Meno noto è che proprio la riflessione sul significato del sacrificio di Cristo, ripresentato dalla figura di Aslan, sia all'origine della conversione al cristianesimo dell'autore inglese.
Così egli stesso racconta ad Arthur Greeves la notte decisiva della sua vita - il 19 settembre 1931 - nella quale, fino alle 4.00 del mattino, si trovò a discutere con H.Dyson (2) e con J.R.R.Tolkien, l'autore de Il Signore degli anelli, della realtà della morte in croce di Cristo, finendo per esserne conquistato (3) :
Quello che mi ha trattenuto (perlomeno durante l'anno passato, all'incirca) non è stata tanto una difficoltà a credere, ma piuttosto a sapere cosa la dottrina volesse significare : non puoi credere a una cosa mentre ignori cosa questa sia . La mia difficoltà era la Dottrina della Redenzione nella sua interezza, in che modo la vita e morte di Cristo "avessero salvato"o "spalancato la salvezza"per il mondo. Capivo come una salvezza miracolosa potesse essere necessaria: uno può vedere dall'esperienza di tutti i giorni come il peccato (per esempio nel caso di un alcolizzato) possa portare l'uomo a un punto tale che egli sia destinato a raggiungere l'Inferno (la completa degradazione e miseria) in questa vita, a meno che un qualche aiuto o sforzo non semplicemente naturale prenda l'iniziativa. E potevo bene immaginare un mondo intero nella stessa condizione, e in maniera simile la necessità di un miracolo. Quello che non riuscivo a capire era come la vita e la morte di Qualcun Altro (chiunque questi fosse) duemila anni fa potesse aiutare noi adesso -se non nella misura in cui poteva esserci utile il suo esempio. E la questione dell'esempio, sebbene tanto vera e importante, non è il cristianesimo: proprio al centro del cristianesimo, nei Vangeli e in san Paolo, trovi qualcosa di completamente diverso e misterioso, espresso in quelle frasi di cui io mi sono fatto gioco così spesso ("propiziazione", "sacrificio", "il sangue dell'Agnello"), espressioni che riuscivo a interpretare solo in modi che mi parevano o sciocchi o scandalosi.
Ora, quello che Dyson e Tolkien mi hanno mostrato era questo: che se io incontro l'idea del sacrificio in un racconto pagano questa non mi crea alcun problema: anzi, che se mi trovo davanti un dio che si sacrifica, ne sono attratto e misteriosamente commosso: ancora, che l'idea del dio che muore e risorge (Balder, Adone, Bacco) mi colpisce così tanto a condizione che io la trovi ovunque tranne che nei Vangeli. La ragione è che nei racconti pagani io sono stato preparato a percepire il mito nella sua profondità e suggestione di significati oltre ogni mia capacità di comprensione, anche se poi nella freddezza della prosa io non riesco a dire "cosa significhi". Ora la storia di Cristo è semplicemente un mito vero: un mito che agisce su di noi come gli altri, ma con la tremenda differenza che questo è davvero avvenuto . [...]
Cioè, le storie pagane sono Dio che esprime Se stesso attraverso la mente dei poeti, facendo uso delle immagini che vi ha trovato, mentre il cristianesimo è Dio che esprime Se stesso attraverso quello che chiamiamo "realtà". Perciò è vero, non essendo una "descrizione"di Dio (cosa che una mente finita non potrebbe racchiudere) ma la via attraverso cui Dio sceglie di mostrarsi alle nostre facoltà. Le "dottrine"che tiriamo fuori dal vero mito sono certamente meno vere di questo: traducono in concetti e idee quello che Dio ha già espresso in un linguaggio più adeguato, la vera incarnazione, crocifissione e resurrezione. E'sufficiente tutto questo per credere al cristianesimo? In ogni caso adesso sono certo che: A) in un certo senso, questo è il metodo con cui il cristianesimo deve essere avvicinato, così come mi accosto agli altri miti; B) fattore più importante e ricco di significato, sono quasi certo che sia tutto accaduto per davvero.
Fino a quella notte Lewis si era sì accostato al cristianesimo, trovandolo l'unica visione "non noiosa" del mondo, ma non ne aveva ancora preso in seria considerazione la possibile verità (4) .
Il testo fantastico de Le cronache di Narnia, nell'episodio Il leone, la strega e l'armadio (5) , ci presenta la legge della giustizia, stabilita dal grande Imperatore - fuor di metafora, da Dio - per la quale chi ha fatto il male (in questo caso Edmund, uno dei quattro fratelli, che più volte per ottenere piccoli vantaggi o per aver salva la vita ha tradito i suoi fratelli) è responsabile delle conseguenze di morte che ha generato:
-Tu hai un traditore qui, Aslan -cominciò a dire la strega. Naturalmente tutti sapevano che alludeva a Edmund, ma il ragazzo, dopo tutto quello che aveva passato e dopo il colloquio della mattina con Aslan, non ci pensava più: guardava il grande leone senza curarsi di quel che diceva la Strega Bianca.
-Ebbene, quel traditore non ti ha recato nessuna offesa -obiettò Aslan.
-Hai dimenticato la Grande Magia?
-Diciamo che l'ho dimenticata -rispose gravemente il leone.
-Parlamene tu.
-Devo parlartene io? -chiese la strega con voce stridula. -
-Devo ripeterti quello che è scritto là, sulla Tavola di Pietra? Devo farti ricordare che proprio su quella tavola sono scritte le stesse cose che la spada ha inciso profondamente nella roccia infuocata della Collina Segreta? E anche quello che è inciso sullo scettro dell'imperatore d'Oltremare? Sai bene qual è l'incantesimo che l'imperatore ha gettato su Narnia fin dall'inizio dei tempi. Sai bene che ogni traditore mi appartiene, è mio per legge. Ogni tradimento mi dà diritto a un'uccisione!
-Ah, capisco! -esclamò il castoro, con tono ironico. -Quella là crede di essere la regina e invece funziona da boia per conto dell'imperatore d'Oltremare. Capisco... capisco...
-Buono, buono, mio caro castoro -disse Aslan, e fece sentire un ringhio soffocato.
-Quell'essere umano mi appartiene -continuò imperterrita la strega. -Ho diritto a confiscargli la vita, a prendermi il suo sangue.
-E vieni a prendertelo, allora! -esclamò il toro con la testa d'uomo: la sa voce assomigliava a un profondo muggito.
-Imbecille! -replicò la strega con un sorriso che era quasi una smorfia crudele. -Credi dunque che il tuo padrone possa togliermi i miei diritti con l'uso della forza? Lo sa bene, lui, cosa stabilisce la Grande Magia: se non avrò il sangue di quel traditore, Narnia sarà distrutta dall'acqua e dal fuoco! Questo dice la Grande Magia!
-E'vero -mormorò Aslan. -Non posso negarlo.
-Oh, Aslan! -esclamò Susan, e poi, avvicinando le labbra all'orecchio di Aslan, sussurrò: -Non possiamo permetterlo. Voglio dire che tu non lo permetterai, vero? Non si può far nulla per rompere l'incantesimo? Voglio dire, tu non puoi fare qualcosa contro la Grande Magia?
-Qualcosa contro quello che l'imperatore ha stabilito dall'inizio dei tempi? -chiese Aslan volgendo verso la fanciulla uno sguardo lievemente accigliato.
Aslan si ritira per un incontro a tu per tu con la Strega Bianca. Al termine del loro colloquio non spiega ai fratelli ed al suo esercito radunato ciò che avverrà, ma tutti avvertono che qualcosa di grande sta per accadere:
E la discussione tra il leone e la strega continuava. Finalmente si udì la voce di Aslan che disse:
-Tranquillizzatevi, va tutto bene. Ho sistemato la faccenda. La strega rinuncia ai suoi diritti sul sangue di vostro fratello. Allora si udì uno strano suono, come se tutti, che fino a quel momento non avevano osato neanche respirare, ora tirassero insieme un gran sospiro di sollievo. La Strega Bianca se ne stava andando: aveva sul volto un'espressione di gioia feroce. A un certo punto si fermò e voltandosi disse:
-E come faccio a essere certa che manterrai la promessa?
-Raaauuug -ruggì il leone, e fece l'atto di alzarsi dal trono dove stava seduto. La Strega Bianca restò a guardarlo un attimo, sbalordita. Poi Aslan spalancò maggiormente la bocca, lei si raccolse la gonna tra le mani e fuggì a gambe levate.
Solo le due sorelline seguono il leone, nella notte, fino al luogo nel quale si rivela il segreto del colloquio fra Aslan e la Strega Bianca. Susan e Lucy, vedendo il leone che si fa legare e porre sull'altare, sulla Tavola di pietra, senza reagire, capiscono che Aslan ha offerto la sua vita in cambio di quella di Edmund. Le due bambine assistono così alla sua terribile morte, offerta in sacrificio:
Eppure, se il leone avesse voluto, una sola zampata poteva significare la morte dei suoi assalitori. Non reagì, invece, neanche quando i suoi nemici cominciarono a stringere i nodi, tirando le corde così forte che esse sembravano sul punto di segargli la pelle; poi lo trascinarono verso la Tavola di Pietra.
-Basta, ora -comandò la strega. -Dobbiamo sistemargli la criniera, prima di tutto!
Dalla folla dei suoi seguaci si levò un altro coro di risatacce volgari. Un orco si fece avanti: teneva in mano un paio di forbici e, zac-zac-zac, cominciò a tagliare ampie ciocche di peli dorati.
Quand'ebbe finito, e sul terreno si ammassava il resto della lunga criniera, l'orco si tirò da parte.
Le due ragazzine poterono allora vedere, sempre nascoste tra i cespugli, che il povero Aslan sembrava ben diverso da prima. Anche i nemici si accorsero della differenza.
-Be', dopo tutto non è che un gattone! -gridò uno.
-E noi avevamo tanta paura di quello là! -esclamò un altro. Tutti si misero a sbeffeggiarlo con frasi idiote, come: "Micio, micio... quanti topolini hai acchiappato oggi?"oppure: "Vuoi un po'di latte nel piattino, micetto?"
-Oh... come possono fare una cosa simile! -mormorò Lucy mentre le lacrime le rigavano il volto. - Sono dei bruti, delle belve! Ora che avevano superato il primo momento di sorpresa, Lucy e Susan si accorgevano che, così tosato, Aslan sembrava anche più bello, più coraggioso, più paziente che mai.
Se tutti deridono l'impotenza di Aslan che non si ribella, non così avviene per Susan e Lucy. Vedendolo morire così, le bambine comprendono di trovarsi dinanzi ad un evento che supera tutto ciò che finora hanno visto in vita (6) .
-Vigliacchi! Vigliacchi! -singhiozzava Susan. -Hanno paura di lui anche adesso! Quando questa operazione fu compiuta (e Aslan era un unico ammasso di corde!) sulla folla cadde un profondo silenzio.
La Strega Bianca, regina del male, prima di spezzare la vita del leone Aslan, pronuncia la sua terribile condanna. E'l'ultima illusione del male che, togliendo di mezzo Cristo, sa che, con la sua fine, anche l'uomo è perduto. E'straordinario lo scambio di parole del testo evangelico: il Cristo sembra "non aver potuto salvare gli altri", oltre che se stesso!
-E allora? Chi ha vinto? E tu, pazzo, credi che con questo salverai quel traditore? Io ti ucciderò al posto so, come era nel nostro patto: così la Grande Magia sarà rispettata. Ma quando tu sarai morto, chi mi impedirà di uccidere anche lui? Chi lo strapperà dalle mie mani, allora? Mi hai consegnato, e per sempre, tutto il paese di Narnia. Hai perso la tua vita, ma non hai salvato quella di lui. Capiscilo finalmente e muori nella disperazione! Le due sorelline non videro il momento preciso in cui la malvagia strega vibrò il colpo. Non avrebbero mai potuto sopportare un simile spettacolo: perciò si coprirono gli occhi con le mani.
Quando tutti hanno abbandonato la scena, per precipitarsi a sconfiggere l'uomo nella grande battaglia e quando anche le bambine stanno per abbandonare il luogo della morte di Aslan, il sepolcro, ecco la meraviglia della resurrezione:
-Oh, Aslan! -esclamarono entrambe fissandolo impaurite e contente al tempo stesso. -Non eri morto, allora, caro Aslan?
-chiese Lucy.
-Non lo sono più -rispose il leone.
-Non sei... non sei un... -domandò Susan con voce tremante. Non sapeva decidersi a dire la parola "fantasma". Aslan si avvicinò, piegò un poco la testa e le diede una leccatina sulla fronte. Susan sentì il calore del suo fiato e quella specie di profumo che sembrava diffuso intorno a lui.
-Ti sembro un fantasma? -chiese Aslan.
-Oh, no! Sei vivo, sei vivo! -gridò Lucy, e tutt'e due si lanciarono verso di lui, ripresero ad abbracciarlo e accarezzarlo e coprirlo di baci.
-Ma cosa significa tutto questo? -chiese Susan quando si furono un po'calmate. Aslan rispose:
-Significa che la Strega Bianca conosce la Grande Magia, ma ce n'è un'altra, più grande ancora, che lei non conosce. Le sue nozioni risalgono all'alba dei tempi: ma se lei potesse penetrare nelle tenebre profonde e nell'assoluta immobilità che erano prima dell'alba dei tempi, vedrebbe che c'è una magia più grande, un incantesimo diverso. E saprebbe così che, quando al posto di un traditore viene immolata una vittima innocente e volontaria, la Tavola di Pietra si spezza e al sorgere del sole la morte stessa torna indietro!
-Oh, è meraviglioso! -esclamò Lucy battendo le mani e saltando dalla gioia. -E ora, come ti senti, Aslan?
-Sento che mi ritornano le forze e, bambine mie, prendetemi se vi riesce!
Aslan è realmente morto. Non si è trattato di una morte apparente. Ma la sua vita di risorto è altrettanto reale. C'è un orizzonte più grande della Grande Magia della giustizia, c'è la presenza originaria di Dio e della sua bontà e misericordia, ciò che la Strega Bianca ignora, non volendo amare e credere.
In un'altra opera, Il cristianesimo così com'è (7) , che C.S.Lewis scrisse per esporre la fede cristiana a chi non la conosce, il nostro autore si sofferma a presentare estesamente il significato della morte redentrice di Cristo, al cuore dell'esperienza cristiana della vita:
Ci viene detto che Cristo è stato ucciso per noi, che la sua morte ha redento i nostri peccati, e che morendo Egli ha reso impotente la morte stessa. Questa è la formula. Questo è il cristianesimo, ed è questo ciò che dev'essere creduto. Qualsiasi nostra teoria su come la morte di Cristo abbia operato tutto ciò è, a mio parere, affatto secondaria; è solo un disegno, uno schema da lasciare da parte se non ci aiuta, e da non confondere, anche se ci aiuta, con la cosa essenziale. Alcune di queste teorie, nondimeno, meritano di essere considerate. La più nota è (che)... abbiamo ottenuto il perdono perché Cristo si è offerto di essere punito al posto nostro. Apparentemente, è una teoria assurda. Se Dio era disposta a perdonarci, perché mai non l'ha fatto? Che senso c'era a punire, invece, un innocente? Io non ne vedo alcuno, se pensiamo a una punizione in senso giudiziario. D'altra parte, se pensiamo a un debito, è molto sensato che una persona provvista di mezzi lo paghi a nome di chi non ne ha. O ancora, se all'espressione "pagare la penale"non attribuiamo il significato di subire un castigo, ma quello più generale di "far fronte a un impegno"o di "saldare un conto", è esperienza comune che quando uno si è messo in qualche impiccio, il disturbo di tirarlo fuori tocchi di solito a un buon amico. Ebbene, in quale "impiccio"si era messo l'uomo? Aveva cercato di agire per conto proprio, di comportarsi come se appartenesse a se stesso. In altri termini, l'uomo caduto non è soltanto una creatura imperfetta che ha bisogno di migliorarsi: è un ribelle che deve deporre le armi. Deporre le armi, arrendersi, chiedere scusa, capire che ci si è messi su una strada sbagliata ed essere pronti a ricominciare la vita dalle fondamenta: è questo l'unico modo di uscire dal nostro "impiccio". Questa operazione di resa -questo fare macchina indietro a tutta forza -è ciò che il cristianesimo chiama pentimento. Ora, il pentimento non è un gioco da ragazzi. E'una cosa molto più ardua che cospargersi il capo di cenere. Vuol dire disimparare tutta la presunzione e la caparbietà cui da migliaia d'anni siamo avvezzi. Vuol dire uccidere una parte di sé, subire una specie di morte. In realtà per pentirsi occorre essere persone buone davvero. E qui viene l'intoppo. Solo una persona cattiva ha bisogno di pentirsi: e solo una persona buona può pentirsi perfettamente. Peggiori siamo, più abbiamo bisogno di pentirci, e meno ne siamo capaci. La sola persona che potrebbe farlo perfettamente sarebbe una persona perfetta -e non ne avrebbe bisogno. Badate bene: questo pentimento, questo volontario sottomettersi all'umiliazione e a una specie di morte, non è qualcosa che Dio esige da noi prima di riaccoglierci, e da cui potrebbe esimerci se volesse; è semplicemente una descrizione di ciò in cui consiste l'atto di tornare a Lui. Se chiedi a Dio di riaccoglierti senza questo atto, Gli chiedi in realtà di lasciarti tornare senza tornare. Non è possibile. Benissimo, dunque: dobbiamo compiere questo atto. Ma la stessa cattiveria che ce lo rende necessario, ci rende incapaci di compierlo. Possiamo farlo se Dio ci aiuta? Sì, ma che cosa intendiamo parlando di aiuto divino? Intendiamo che Dio mette in noi, per così dire, un poco di Sé. Dio ci presta un poco del Suo raziocinio, ed è così che noi pensiamo; mette in noi un poco del Suo amore, ed è così che ci amiamo l'un l'altro. Quando insegni a scrivere a un bambino, gli reggi la mano mentre forma le lettere: il bambino, cioè, forma le lettere perché le formi tu. Noi amiamo e ragioniamo perché Dio ama e ragiona e ci regge la mano mentre lo facciamo. Se non fossimo caduti, tutto sarebbe facile. Ma adesso, sfortunatamente, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per fare qualcosa che Dio, nella Sua natura, non fa mai: arrenderci, soffrire, sottometterci, morire. Nulla, nella natura di Dio, corrisponde a questo processo. Sicché proprio quella strada per la quale soprattutto ci è ora indispensabile la guida di Dio è una strada che Dio, nella Sua natura, non ha mai percorso. Dio può spartire soltanto ciò che ha: e questo, nella Sua natura, non c'è. Ma supponiamo che Dio diventi uomo: supponiamo che la nostra natura umana, che può soffrire e morire, si amalgami con la natura di Dio in un'unica persona: allora questa persona potrebbe aiutarci. Potrebbe rinunciare alla Sua volontà, e soffrire e morire, perché è un uomo; e potrebbe farlo perfettamente perché è Dio. Voi e io possiamo compiere questo processo soltanto se Dio lo compie in noi; ma Dio può compierlo soltanto se diventa uomo. I nostri tentativi volti a questo morire possono andare a segno soltanto se noi uomini condividiamo il morire di Dio, così come il nostro pensiero può sussistere soltanto perché è una goccia del mare della Sua intelligenza: ma noi non possiamo condividere il morire di Dio se Dio non muore: ed Egli può morire soltanto essendo uomo. E'in questo senso che Egli paga il nostro debito, e patisce per noi ciò che a Lui, in quanto Dio, non è affatto necessario patire. Ho sentito certuni obiettare che se Gesù era Dio oltre che uomo, le Sue sofferenze e la Sua morte perdono, ai loro occhi, ogni valore, "perché per Lui deve essere stato facilissimo". Altri potrà (a buon diritto) biasimare la sgarbata ingratitudine di questa obiezione; io sono stupefatto dall'incomprensione che essa rivela. In un certo senso, naturalmente, chi la fa non ha torto. Anzi, si mostra fin troppo moderato. La perfetta sottomissione, la perfetta sofferenza, la perfetta morte non solo furono più facili a Gesù perché Egli era Dio: furono possibili soltanto perché Egli era Dio. Ma questo è un motivo ben strano per non accettarle. Il maestro può tracciare le lettere per il bambino in quanto è adulto e sa scrivere. Questo, naturalmente, gli rende le cose più facili, ma è soltanto grazie a questa facilità che egli può aiutare l'allievo. Se il bambino rifiutasse il suo aiuto perché "per gli adulti è facile", e aspettasse di imparare a scrivere da un coetaneo che non sa scrivere nemmeno lui (e quindi non ha un vantaggio "sleale"), non farebbe molta strada. Se io sto annegando in un fiume vorticoso, un uomo che ha un piede sulla riva può tendermi una mano e salvarmi la vita. Dovrei gridargli (tra un rantolo e l'altro): "No, non è giusto! Hai un vantaggio... stai con un piede sulla riva"? Quel vantaggio -chiamatelo "sleale", se volete - è la sola cosa che gli permette di essermi utile. Da chi cercheremo aiuto se non da chi è più forte di noi?
S.Tommaso d'Aquino aveva parlato (8) della redenzione dell'uomo mediante la passione di Cristo come realtà consona sia alla giustizia che alla misericordia di Dio. La morte in croce di Cristo, pur non necessaria secondo una "necessità di coazione", è necessaria secondo il volere di Dio. L'Aquinate così presentava cinque aspetti di essa: il sacrificio di Cristo, dando all'uomo di conoscere quanto Dio lo ami, mostrandoci l'esempio perché "anche noi ne seguiamo le orme", redimendoci dal peccato ma anche meritandoci la grazia giustificante e la beatitudine, insinuando in noi con più forza l'esigenza di conservarci immuni dal peccato ed, infine, rispettando la nostra natura di uomini poiché l'uomo Gesù, e non solo Dio, ha vinto la morte subendola, era più "conveniente". "Conveniente"è uno straordinario termine teologico medioevale con il quale si indica ciò che è proprio dell'essere e dell'agire della Trinità, lo stile che è inconfondibilmente unico e appropriato dell'essere divino -era conveniente che fossimo liberati dalla passione di Cristo, piuttosto che dalla semplice volontà di Dio! C.S.Lewis ha avuto il coraggio di riavvicinare il suo ed il nostro tempo al grande mistero della redenzione umana avvenuta attraverso l'amore ed il dolore di Cristo stesso.
NOTE
1 Lettera del 3 giugno 1951, in C.S.Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, BUR Rizzoli, Milano, 2005, pagg.98-99.
2 Professore di Letteratura Inglese all'Università di Reading, cristiano anglicano e futuro , membro degli "Inklings", gli "Imbrattacarte"o gli "Scribacchini", noti anche come i "cristiani di Oxford", il circolo letterario che si riuniva il giovedì sera nelle stanze di Lewis al Magdalene College per discutere e leggere le novità che ognuno dei membri si trovava volta per volta a scrivere.
3 Lettera del 18 ottobre 1931, in C.S.Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, BUR Rizzoli, Milano, 2005, pagg.88-90. I neretti sono dello stesso C.S.Lewis.
4 L'avvicinarsi al cristianesimo è descritto retrospettivamente da C.S.Lewis, attraverso la crescente consapevolezza che la letteratura di ispirazione cristiana era quella che gli appariva più capace di leggere la profondità della problematica esistenziale della vita umana. Lewis così si esprimeva: "I cristiani hanno torto, ma tutti gli altri sono noiosi ", parafrasando una celebre frase della Chanson de Roland, " Paien unt tort et crestiens unt dreit ", " I pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione ". Così scrive estesamente (in C.S.Lewis, Sorpreso dalla gioia. I primi anni della mia vita, Jaca Book, Milano, 2002, pagg,155-157) descrivendo il suo approccio alla letteratura a partire dal 1922:
"Nell'estate del 1922 diedi gli ultimi esami. Poiché non c'erano cattedre di filosofia libere, o comunque nessuna che io potessi assumere, il mio paziente genitore mi offerse un quarto anno a Oxford, durante il quale studiai inglese, aggiungendo una seconda corda al mio archetto...
Ero appena entrato alla facoltà di inglese, quando presi parte al corso di discussione di George Gordon. E lì mi feci un nuovo amico. Le prime parole che pronunciò valsero a distinguerlo dagli altri dieci o dodici presenti; mi andò subito a genio,e questo, per di più, a un'età in cui le amicizie immediate della prima giovinezza andavano facendosi sempre più rare. Si chiamava Nevill Coghill. Scopersi subito con stupore che egli -senza dubbio il più intelligente e colto della classe -era cristiano e sovrannaturalista convinto...
Tutti i libri cominciavano a rivoltarmisi contro. In effetti, dovevo essere stato cieco come un pipistrello per non avere colto da un pezzo la ridicola contraddizione tra la mia teoria esistenziale e le mie reali esperienze di lettore. George MacDonald aveva fatto per me più di qualunque altro scrittore; naturalmente, era un peccato ch'egli avesse il pallino del cristianesimo. Era valido a dispetto di esso . Chesterton aveva più senso di tutti gli altri moderni messi insieme; e indipendentemente dal suo cristianesimo. Johnson era uno dei pochi autori di cui sentivo di potermi fidare ciecamente; abbastanza stranamente, aveva lo stesso pallino. Per una curiosa coincidenza, lo avevano anche Spenser e Milton. Era possibile scoprire lo stesso paradosso anche tra gli autori antichi. I più religiosi (Platone, Eschilo, Virgilio) erano senza dubbio quelli cui potevo realmente attingere. D'altro canto, gli scrittori non afflitti dalla religione e che in teoria avrebbero avuto diritto alla mia più totale simpatia -Shaw e Wells e Mill e Gibbon e Voltaire -avevano tutti un'aria un po'sparuta; quel sapore che da ragazzi chiamavamo "di latta". Non che non mi piacessero. Erano tutti (specialmente Gibbon) divertenti; ma niente di più. In essi non sembrava esserci profondità. Erano troppo semplici. Nei loro libri, la ruvidezza e la densità della vita non trasparivano. Ora che leggevo più inglesi, il paradosso andava sempre più peggiorando. Il Dream of the Rood mi commosse profondamente; Langland ancora di più; Donne (per qualche tempo) mi inebriò; Thomas Browne mi soddisfece profondamente e durevolmente. Ma il più allarmante di tutti fu George Herbert. Ecco un uomo che mi sembrava eccellesse su tutti gli altri autori nell'illustrare la vera qualità della vita come realmente la viviamo di momento in momento; ma il pover'uomo, anziché farlo direttamente, insisteva nel rimeditarla attraverso ciò ch'io avrei ancora chiamato "la mitologia cristiana". D'altro canto, la più parte degli autori che si potevano considerare precursori dell'illuminismo moderno mi sembravano robetta e mi annoiavano a morte. Di Bacon trovai che fosse (per dirla francamente) un solenne e presuntuoso somaro, della Restoration Comedy un unico immenso sbadiglio e, dopo essermi virilmente battuto per arrivare in fondo a Don Juan, scrissi sulla pagina finale: "Mai più". I soli non-cristiani che mi parve conoscessero veramente tutto furono i romantici; ed erano in buona parte minacciosamente contagiati da qualcosa che somigliava alla religione, e a volte persino dal Cristianesimo. Il succo si poteva più o meno esprimere in una corruzione del grande verso di Roland nella Chanson:
I cristiani hanno torto,
ma tutti gli altri sono noiosi.
La mossa più naturale sarebbe stata di accertarsi un po'più da vicino se i cristiani avessero, dopo tutto, torto. Ma non la feci. Pensavo di poterne dimostrare la superiorità senza quella ipotesi. Assurdamente (ma molti idealisti assoluti hanno condiviso tale assurdità) pensavo che "il mito cristiano"aprisse alle menti non filosofiche quanta verità, cioè di idealismo assoluto, fossero in grado di afferrare, e anche quanta li poneva al di sopra degli irreligiosi. Chi non riesce a elevarsi alla nozione di assoluto si accosterebbe alla verità più credendo in "un Dio"che non credendo affatto".
5 C.S.Lewis, Le cronache di Narnia, Mondadori, Milano, 2001, I volume, pagg.139-259.
6 Così Andrew Adamson, regista del film, in una intervista a Buena Vista, si è espresso intorno alla complessità del personaggio di Aslan, nella sua versione cinematografica: "Aslan è stato una sfida. È un personaggio molto importante nel libro e, naturalmente, molto complesso da riprodurre. Ma è molto difficile creare in particolare un personaggio onnipotente che sia anche accessibile. Vorresti provare compassione ed empatia quando va verso la sua morte... ma per fare questo deve essere umano e profondo e allo stesso tempo potente e feroce... come cita una frase del libro... non è un leone addomesticato. Liam Neeson possiede un grandissimo calore, ha una voce potente ed è anche capace di sprigionare una grande forza quando va in collera. Per cui è stata una grande sfida riunire tutte queste caratteristiche in un personaggio" . Purtroppo la scelta, in fase di doppiaggio della versione italiana, della voce di Omar Sharif, non ha permesso un analogo risultato.
7 C.S.Lewis, Il cristianesimo così com'è, Adelphi, Milano, 1997, pagg.83-88.
8 Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, p.III, q.46.
di Andrea Lonardo
Tratto dal sito della parrocchia di Santa Melania
Riguardo all'altro nome di Aslan, vorrei davvero che fossi tu ad indovinare. C'è mai stato qualcuno in questo nostro mondo che: 1) giunse nello stesso periodo di Babbo Natale; 2) disse di essere il figlio del Grande Imperatore; 3) per la colpa di qualcun altro diede se stesso a degli uomini cattivi che lo derisero e lo uccisero; 4) tornò in vita; 5) viene alle volte chiamato l'Agnello (vedi la conclusione del Veliero)? Davvero non sai il Suo nome in questo mondo? Pensaci su e fammi sapere la tua risposta!
Così C.S.Lewis, autore dei tre volumi de Le cronache di Narnia da un episodio dei quali è tratto il film di A.Adamson in questi giorni sugli schermi, rispondeva ad Hila, una bambina americana lettrice delle sue fiabe (1) . La decisione di dare vita ad una allegoria di Cristo, nella sua creazione di fantasia, è evidente. Il leone Aslan è figura di Cristo che vince il gelo e la morte del mondo offrendo se stesso alla morte per la salvezza di uno dei bambini protagonisti della fiaba, Edmund, colpevole di tradimento, e risorge a vita nuova, per essere con i suoi nella battaglia finale contro la Strega Bianca e le forze maligne che la accompagnano.
Meno noto è che proprio la riflessione sul significato del sacrificio di Cristo, ripresentato dalla figura di Aslan, sia all'origine della conversione al cristianesimo dell'autore inglese.
Così egli stesso racconta ad Arthur Greeves la notte decisiva della sua vita - il 19 settembre 1931 - nella quale, fino alle 4.00 del mattino, si trovò a discutere con H.Dyson (2) e con J.R.R.Tolkien, l'autore de Il Signore degli anelli, della realtà della morte in croce di Cristo, finendo per esserne conquistato (3) :
Quello che mi ha trattenuto (perlomeno durante l'anno passato, all'incirca) non è stata tanto una difficoltà a credere, ma piuttosto a sapere cosa la dottrina volesse significare : non puoi credere a una cosa mentre ignori cosa questa sia . La mia difficoltà era la Dottrina della Redenzione nella sua interezza, in che modo la vita e morte di Cristo "avessero salvato"o "spalancato la salvezza"per il mondo. Capivo come una salvezza miracolosa potesse essere necessaria: uno può vedere dall'esperienza di tutti i giorni come il peccato (per esempio nel caso di un alcolizzato) possa portare l'uomo a un punto tale che egli sia destinato a raggiungere l'Inferno (la completa degradazione e miseria) in questa vita, a meno che un qualche aiuto o sforzo non semplicemente naturale prenda l'iniziativa. E potevo bene immaginare un mondo intero nella stessa condizione, e in maniera simile la necessità di un miracolo. Quello che non riuscivo a capire era come la vita e la morte di Qualcun Altro (chiunque questi fosse) duemila anni fa potesse aiutare noi adesso -se non nella misura in cui poteva esserci utile il suo esempio. E la questione dell'esempio, sebbene tanto vera e importante, non è il cristianesimo: proprio al centro del cristianesimo, nei Vangeli e in san Paolo, trovi qualcosa di completamente diverso e misterioso, espresso in quelle frasi di cui io mi sono fatto gioco così spesso ("propiziazione", "sacrificio", "il sangue dell'Agnello"), espressioni che riuscivo a interpretare solo in modi che mi parevano o sciocchi o scandalosi.
Ora, quello che Dyson e Tolkien mi hanno mostrato era questo: che se io incontro l'idea del sacrificio in un racconto pagano questa non mi crea alcun problema: anzi, che se mi trovo davanti un dio che si sacrifica, ne sono attratto e misteriosamente commosso: ancora, che l'idea del dio che muore e risorge (Balder, Adone, Bacco) mi colpisce così tanto a condizione che io la trovi ovunque tranne che nei Vangeli. La ragione è che nei racconti pagani io sono stato preparato a percepire il mito nella sua profondità e suggestione di significati oltre ogni mia capacità di comprensione, anche se poi nella freddezza della prosa io non riesco a dire "cosa significhi". Ora la storia di Cristo è semplicemente un mito vero: un mito che agisce su di noi come gli altri, ma con la tremenda differenza che questo è davvero avvenuto . [...]
Cioè, le storie pagane sono Dio che esprime Se stesso attraverso la mente dei poeti, facendo uso delle immagini che vi ha trovato, mentre il cristianesimo è Dio che esprime Se stesso attraverso quello che chiamiamo "realtà". Perciò è vero, non essendo una "descrizione"di Dio (cosa che una mente finita non potrebbe racchiudere) ma la via attraverso cui Dio sceglie di mostrarsi alle nostre facoltà. Le "dottrine"che tiriamo fuori dal vero mito sono certamente meno vere di questo: traducono in concetti e idee quello che Dio ha già espresso in un linguaggio più adeguato, la vera incarnazione, crocifissione e resurrezione. E'sufficiente tutto questo per credere al cristianesimo? In ogni caso adesso sono certo che: A) in un certo senso, questo è il metodo con cui il cristianesimo deve essere avvicinato, così come mi accosto agli altri miti; B) fattore più importante e ricco di significato, sono quasi certo che sia tutto accaduto per davvero.
Fino a quella notte Lewis si era sì accostato al cristianesimo, trovandolo l'unica visione "non noiosa" del mondo, ma non ne aveva ancora preso in seria considerazione la possibile verità (4) .
Il testo fantastico de Le cronache di Narnia, nell'episodio Il leone, la strega e l'armadio (5) , ci presenta la legge della giustizia, stabilita dal grande Imperatore - fuor di metafora, da Dio - per la quale chi ha fatto il male (in questo caso Edmund, uno dei quattro fratelli, che più volte per ottenere piccoli vantaggi o per aver salva la vita ha tradito i suoi fratelli) è responsabile delle conseguenze di morte che ha generato:
-Tu hai un traditore qui, Aslan -cominciò a dire la strega. Naturalmente tutti sapevano che alludeva a Edmund, ma il ragazzo, dopo tutto quello che aveva passato e dopo il colloquio della mattina con Aslan, non ci pensava più: guardava il grande leone senza curarsi di quel che diceva la Strega Bianca.
-Ebbene, quel traditore non ti ha recato nessuna offesa -obiettò Aslan.
-Hai dimenticato la Grande Magia?
-Diciamo che l'ho dimenticata -rispose gravemente il leone.
-Parlamene tu.
-Devo parlartene io? -chiese la strega con voce stridula. -
-Devo ripeterti quello che è scritto là, sulla Tavola di Pietra? Devo farti ricordare che proprio su quella tavola sono scritte le stesse cose che la spada ha inciso profondamente nella roccia infuocata della Collina Segreta? E anche quello che è inciso sullo scettro dell'imperatore d'Oltremare? Sai bene qual è l'incantesimo che l'imperatore ha gettato su Narnia fin dall'inizio dei tempi. Sai bene che ogni traditore mi appartiene, è mio per legge. Ogni tradimento mi dà diritto a un'uccisione!
-Ah, capisco! -esclamò il castoro, con tono ironico. -Quella là crede di essere la regina e invece funziona da boia per conto dell'imperatore d'Oltremare. Capisco... capisco...
-Buono, buono, mio caro castoro -disse Aslan, e fece sentire un ringhio soffocato.
-Quell'essere umano mi appartiene -continuò imperterrita la strega. -Ho diritto a confiscargli la vita, a prendermi il suo sangue.
-E vieni a prendertelo, allora! -esclamò il toro con la testa d'uomo: la sa voce assomigliava a un profondo muggito.
-Imbecille! -replicò la strega con un sorriso che era quasi una smorfia crudele. -Credi dunque che il tuo padrone possa togliermi i miei diritti con l'uso della forza? Lo sa bene, lui, cosa stabilisce la Grande Magia: se non avrò il sangue di quel traditore, Narnia sarà distrutta dall'acqua e dal fuoco! Questo dice la Grande Magia!
-E'vero -mormorò Aslan. -Non posso negarlo.
-Oh, Aslan! -esclamò Susan, e poi, avvicinando le labbra all'orecchio di Aslan, sussurrò: -Non possiamo permetterlo. Voglio dire che tu non lo permetterai, vero? Non si può far nulla per rompere l'incantesimo? Voglio dire, tu non puoi fare qualcosa contro la Grande Magia?
-Qualcosa contro quello che l'imperatore ha stabilito dall'inizio dei tempi? -chiese Aslan volgendo verso la fanciulla uno sguardo lievemente accigliato.
Aslan si ritira per un incontro a tu per tu con la Strega Bianca. Al termine del loro colloquio non spiega ai fratelli ed al suo esercito radunato ciò che avverrà, ma tutti avvertono che qualcosa di grande sta per accadere:
E la discussione tra il leone e la strega continuava. Finalmente si udì la voce di Aslan che disse:
-Tranquillizzatevi, va tutto bene. Ho sistemato la faccenda. La strega rinuncia ai suoi diritti sul sangue di vostro fratello. Allora si udì uno strano suono, come se tutti, che fino a quel momento non avevano osato neanche respirare, ora tirassero insieme un gran sospiro di sollievo. La Strega Bianca se ne stava andando: aveva sul volto un'espressione di gioia feroce. A un certo punto si fermò e voltandosi disse:
-E come faccio a essere certa che manterrai la promessa?
-Raaauuug -ruggì il leone, e fece l'atto di alzarsi dal trono dove stava seduto. La Strega Bianca restò a guardarlo un attimo, sbalordita. Poi Aslan spalancò maggiormente la bocca, lei si raccolse la gonna tra le mani e fuggì a gambe levate.
Solo le due sorelline seguono il leone, nella notte, fino al luogo nel quale si rivela il segreto del colloquio fra Aslan e la Strega Bianca. Susan e Lucy, vedendo il leone che si fa legare e porre sull'altare, sulla Tavola di pietra, senza reagire, capiscono che Aslan ha offerto la sua vita in cambio di quella di Edmund. Le due bambine assistono così alla sua terribile morte, offerta in sacrificio:
Eppure, se il leone avesse voluto, una sola zampata poteva significare la morte dei suoi assalitori. Non reagì, invece, neanche quando i suoi nemici cominciarono a stringere i nodi, tirando le corde così forte che esse sembravano sul punto di segargli la pelle; poi lo trascinarono verso la Tavola di Pietra.
-Basta, ora -comandò la strega. -Dobbiamo sistemargli la criniera, prima di tutto!
Dalla folla dei suoi seguaci si levò un altro coro di risatacce volgari. Un orco si fece avanti: teneva in mano un paio di forbici e, zac-zac-zac, cominciò a tagliare ampie ciocche di peli dorati.
Quand'ebbe finito, e sul terreno si ammassava il resto della lunga criniera, l'orco si tirò da parte.
Le due ragazzine poterono allora vedere, sempre nascoste tra i cespugli, che il povero Aslan sembrava ben diverso da prima. Anche i nemici si accorsero della differenza.
-Be', dopo tutto non è che un gattone! -gridò uno.
-E noi avevamo tanta paura di quello là! -esclamò un altro. Tutti si misero a sbeffeggiarlo con frasi idiote, come: "Micio, micio... quanti topolini hai acchiappato oggi?"oppure: "Vuoi un po'di latte nel piattino, micetto?"
-Oh... come possono fare una cosa simile! -mormorò Lucy mentre le lacrime le rigavano il volto. - Sono dei bruti, delle belve! Ora che avevano superato il primo momento di sorpresa, Lucy e Susan si accorgevano che, così tosato, Aslan sembrava anche più bello, più coraggioso, più paziente che mai.
Se tutti deridono l'impotenza di Aslan che non si ribella, non così avviene per Susan e Lucy. Vedendolo morire così, le bambine comprendono di trovarsi dinanzi ad un evento che supera tutto ciò che finora hanno visto in vita (6) .
-Vigliacchi! Vigliacchi! -singhiozzava Susan. -Hanno paura di lui anche adesso! Quando questa operazione fu compiuta (e Aslan era un unico ammasso di corde!) sulla folla cadde un profondo silenzio.
La Strega Bianca, regina del male, prima di spezzare la vita del leone Aslan, pronuncia la sua terribile condanna. E'l'ultima illusione del male che, togliendo di mezzo Cristo, sa che, con la sua fine, anche l'uomo è perduto. E'straordinario lo scambio di parole del testo evangelico: il Cristo sembra "non aver potuto salvare gli altri", oltre che se stesso!
-E allora? Chi ha vinto? E tu, pazzo, credi che con questo salverai quel traditore? Io ti ucciderò al posto so, come era nel nostro patto: così la Grande Magia sarà rispettata. Ma quando tu sarai morto, chi mi impedirà di uccidere anche lui? Chi lo strapperà dalle mie mani, allora? Mi hai consegnato, e per sempre, tutto il paese di Narnia. Hai perso la tua vita, ma non hai salvato quella di lui. Capiscilo finalmente e muori nella disperazione! Le due sorelline non videro il momento preciso in cui la malvagia strega vibrò il colpo. Non avrebbero mai potuto sopportare un simile spettacolo: perciò si coprirono gli occhi con le mani.
Quando tutti hanno abbandonato la scena, per precipitarsi a sconfiggere l'uomo nella grande battaglia e quando anche le bambine stanno per abbandonare il luogo della morte di Aslan, il sepolcro, ecco la meraviglia della resurrezione:
-Oh, Aslan! -esclamarono entrambe fissandolo impaurite e contente al tempo stesso. -Non eri morto, allora, caro Aslan?
-chiese Lucy.
-Non lo sono più -rispose il leone.
-Non sei... non sei un... -domandò Susan con voce tremante. Non sapeva decidersi a dire la parola "fantasma". Aslan si avvicinò, piegò un poco la testa e le diede una leccatina sulla fronte. Susan sentì il calore del suo fiato e quella specie di profumo che sembrava diffuso intorno a lui.
-Ti sembro un fantasma? -chiese Aslan.
-Oh, no! Sei vivo, sei vivo! -gridò Lucy, e tutt'e due si lanciarono verso di lui, ripresero ad abbracciarlo e accarezzarlo e coprirlo di baci.
-Ma cosa significa tutto questo? -chiese Susan quando si furono un po'calmate. Aslan rispose:
-Significa che la Strega Bianca conosce la Grande Magia, ma ce n'è un'altra, più grande ancora, che lei non conosce. Le sue nozioni risalgono all'alba dei tempi: ma se lei potesse penetrare nelle tenebre profonde e nell'assoluta immobilità che erano prima dell'alba dei tempi, vedrebbe che c'è una magia più grande, un incantesimo diverso. E saprebbe così che, quando al posto di un traditore viene immolata una vittima innocente e volontaria, la Tavola di Pietra si spezza e al sorgere del sole la morte stessa torna indietro!
-Oh, è meraviglioso! -esclamò Lucy battendo le mani e saltando dalla gioia. -E ora, come ti senti, Aslan?
-Sento che mi ritornano le forze e, bambine mie, prendetemi se vi riesce!
Aslan è realmente morto. Non si è trattato di una morte apparente. Ma la sua vita di risorto è altrettanto reale. C'è un orizzonte più grande della Grande Magia della giustizia, c'è la presenza originaria di Dio e della sua bontà e misericordia, ciò che la Strega Bianca ignora, non volendo amare e credere.
In un'altra opera, Il cristianesimo così com'è (7) , che C.S.Lewis scrisse per esporre la fede cristiana a chi non la conosce, il nostro autore si sofferma a presentare estesamente il significato della morte redentrice di Cristo, al cuore dell'esperienza cristiana della vita:
Ci viene detto che Cristo è stato ucciso per noi, che la sua morte ha redento i nostri peccati, e che morendo Egli ha reso impotente la morte stessa. Questa è la formula. Questo è il cristianesimo, ed è questo ciò che dev'essere creduto. Qualsiasi nostra teoria su come la morte di Cristo abbia operato tutto ciò è, a mio parere, affatto secondaria; è solo un disegno, uno schema da lasciare da parte se non ci aiuta, e da non confondere, anche se ci aiuta, con la cosa essenziale. Alcune di queste teorie, nondimeno, meritano di essere considerate. La più nota è (che)... abbiamo ottenuto il perdono perché Cristo si è offerto di essere punito al posto nostro. Apparentemente, è una teoria assurda. Se Dio era disposta a perdonarci, perché mai non l'ha fatto? Che senso c'era a punire, invece, un innocente? Io non ne vedo alcuno, se pensiamo a una punizione in senso giudiziario. D'altra parte, se pensiamo a un debito, è molto sensato che una persona provvista di mezzi lo paghi a nome di chi non ne ha. O ancora, se all'espressione "pagare la penale"non attribuiamo il significato di subire un castigo, ma quello più generale di "far fronte a un impegno"o di "saldare un conto", è esperienza comune che quando uno si è messo in qualche impiccio, il disturbo di tirarlo fuori tocchi di solito a un buon amico. Ebbene, in quale "impiccio"si era messo l'uomo? Aveva cercato di agire per conto proprio, di comportarsi come se appartenesse a se stesso. In altri termini, l'uomo caduto non è soltanto una creatura imperfetta che ha bisogno di migliorarsi: è un ribelle che deve deporre le armi. Deporre le armi, arrendersi, chiedere scusa, capire che ci si è messi su una strada sbagliata ed essere pronti a ricominciare la vita dalle fondamenta: è questo l'unico modo di uscire dal nostro "impiccio". Questa operazione di resa -questo fare macchina indietro a tutta forza -è ciò che il cristianesimo chiama pentimento. Ora, il pentimento non è un gioco da ragazzi. E'una cosa molto più ardua che cospargersi il capo di cenere. Vuol dire disimparare tutta la presunzione e la caparbietà cui da migliaia d'anni siamo avvezzi. Vuol dire uccidere una parte di sé, subire una specie di morte. In realtà per pentirsi occorre essere persone buone davvero. E qui viene l'intoppo. Solo una persona cattiva ha bisogno di pentirsi: e solo una persona buona può pentirsi perfettamente. Peggiori siamo, più abbiamo bisogno di pentirci, e meno ne siamo capaci. La sola persona che potrebbe farlo perfettamente sarebbe una persona perfetta -e non ne avrebbe bisogno. Badate bene: questo pentimento, questo volontario sottomettersi all'umiliazione e a una specie di morte, non è qualcosa che Dio esige da noi prima di riaccoglierci, e da cui potrebbe esimerci se volesse; è semplicemente una descrizione di ciò in cui consiste l'atto di tornare a Lui. Se chiedi a Dio di riaccoglierti senza questo atto, Gli chiedi in realtà di lasciarti tornare senza tornare. Non è possibile. Benissimo, dunque: dobbiamo compiere questo atto. Ma la stessa cattiveria che ce lo rende necessario, ci rende incapaci di compierlo. Possiamo farlo se Dio ci aiuta? Sì, ma che cosa intendiamo parlando di aiuto divino? Intendiamo che Dio mette in noi, per così dire, un poco di Sé. Dio ci presta un poco del Suo raziocinio, ed è così che noi pensiamo; mette in noi un poco del Suo amore, ed è così che ci amiamo l'un l'altro. Quando insegni a scrivere a un bambino, gli reggi la mano mentre forma le lettere: il bambino, cioè, forma le lettere perché le formi tu. Noi amiamo e ragioniamo perché Dio ama e ragiona e ci regge la mano mentre lo facciamo. Se non fossimo caduti, tutto sarebbe facile. Ma adesso, sfortunatamente, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per fare qualcosa che Dio, nella Sua natura, non fa mai: arrenderci, soffrire, sottometterci, morire. Nulla, nella natura di Dio, corrisponde a questo processo. Sicché proprio quella strada per la quale soprattutto ci è ora indispensabile la guida di Dio è una strada che Dio, nella Sua natura, non ha mai percorso. Dio può spartire soltanto ciò che ha: e questo, nella Sua natura, non c'è. Ma supponiamo che Dio diventi uomo: supponiamo che la nostra natura umana, che può soffrire e morire, si amalgami con la natura di Dio in un'unica persona: allora questa persona potrebbe aiutarci. Potrebbe rinunciare alla Sua volontà, e soffrire e morire, perché è un uomo; e potrebbe farlo perfettamente perché è Dio. Voi e io possiamo compiere questo processo soltanto se Dio lo compie in noi; ma Dio può compierlo soltanto se diventa uomo. I nostri tentativi volti a questo morire possono andare a segno soltanto se noi uomini condividiamo il morire di Dio, così come il nostro pensiero può sussistere soltanto perché è una goccia del mare della Sua intelligenza: ma noi non possiamo condividere il morire di Dio se Dio non muore: ed Egli può morire soltanto essendo uomo. E'in questo senso che Egli paga il nostro debito, e patisce per noi ciò che a Lui, in quanto Dio, non è affatto necessario patire. Ho sentito certuni obiettare che se Gesù era Dio oltre che uomo, le Sue sofferenze e la Sua morte perdono, ai loro occhi, ogni valore, "perché per Lui deve essere stato facilissimo". Altri potrà (a buon diritto) biasimare la sgarbata ingratitudine di questa obiezione; io sono stupefatto dall'incomprensione che essa rivela. In un certo senso, naturalmente, chi la fa non ha torto. Anzi, si mostra fin troppo moderato. La perfetta sottomissione, la perfetta sofferenza, la perfetta morte non solo furono più facili a Gesù perché Egli era Dio: furono possibili soltanto perché Egli era Dio. Ma questo è un motivo ben strano per non accettarle. Il maestro può tracciare le lettere per il bambino in quanto è adulto e sa scrivere. Questo, naturalmente, gli rende le cose più facili, ma è soltanto grazie a questa facilità che egli può aiutare l'allievo. Se il bambino rifiutasse il suo aiuto perché "per gli adulti è facile", e aspettasse di imparare a scrivere da un coetaneo che non sa scrivere nemmeno lui (e quindi non ha un vantaggio "sleale"), non farebbe molta strada. Se io sto annegando in un fiume vorticoso, un uomo che ha un piede sulla riva può tendermi una mano e salvarmi la vita. Dovrei gridargli (tra un rantolo e l'altro): "No, non è giusto! Hai un vantaggio... stai con un piede sulla riva"? Quel vantaggio -chiamatelo "sleale", se volete - è la sola cosa che gli permette di essermi utile. Da chi cercheremo aiuto se non da chi è più forte di noi?
S.Tommaso d'Aquino aveva parlato (8) della redenzione dell'uomo mediante la passione di Cristo come realtà consona sia alla giustizia che alla misericordia di Dio. La morte in croce di Cristo, pur non necessaria secondo una "necessità di coazione", è necessaria secondo il volere di Dio. L'Aquinate così presentava cinque aspetti di essa: il sacrificio di Cristo, dando all'uomo di conoscere quanto Dio lo ami, mostrandoci l'esempio perché "anche noi ne seguiamo le orme", redimendoci dal peccato ma anche meritandoci la grazia giustificante e la beatitudine, insinuando in noi con più forza l'esigenza di conservarci immuni dal peccato ed, infine, rispettando la nostra natura di uomini poiché l'uomo Gesù, e non solo Dio, ha vinto la morte subendola, era più "conveniente". "Conveniente"è uno straordinario termine teologico medioevale con il quale si indica ciò che è proprio dell'essere e dell'agire della Trinità, lo stile che è inconfondibilmente unico e appropriato dell'essere divino -era conveniente che fossimo liberati dalla passione di Cristo, piuttosto che dalla semplice volontà di Dio! C.S.Lewis ha avuto il coraggio di riavvicinare il suo ed il nostro tempo al grande mistero della redenzione umana avvenuta attraverso l'amore ed il dolore di Cristo stesso.
NOTE
1 Lettera del 3 giugno 1951, in C.S.Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, BUR Rizzoli, Milano, 2005, pagg.98-99.
2 Professore di Letteratura Inglese all'Università di Reading, cristiano anglicano e futuro , membro degli "Inklings", gli "Imbrattacarte"o gli "Scribacchini", noti anche come i "cristiani di Oxford", il circolo letterario che si riuniva il giovedì sera nelle stanze di Lewis al Magdalene College per discutere e leggere le novità che ognuno dei membri si trovava volta per volta a scrivere.
3 Lettera del 18 ottobre 1931, in C.S.Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, BUR Rizzoli, Milano, 2005, pagg.88-90. I neretti sono dello stesso C.S.Lewis.
4 L'avvicinarsi al cristianesimo è descritto retrospettivamente da C.S.Lewis, attraverso la crescente consapevolezza che la letteratura di ispirazione cristiana era quella che gli appariva più capace di leggere la profondità della problematica esistenziale della vita umana. Lewis così si esprimeva: "I cristiani hanno torto, ma tutti gli altri sono noiosi ", parafrasando una celebre frase della Chanson de Roland, " Paien unt tort et crestiens unt dreit ", " I pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione ". Così scrive estesamente (in C.S.Lewis, Sorpreso dalla gioia. I primi anni della mia vita, Jaca Book, Milano, 2002, pagg,155-157) descrivendo il suo approccio alla letteratura a partire dal 1922:
"Nell'estate del 1922 diedi gli ultimi esami. Poiché non c'erano cattedre di filosofia libere, o comunque nessuna che io potessi assumere, il mio paziente genitore mi offerse un quarto anno a Oxford, durante il quale studiai inglese, aggiungendo una seconda corda al mio archetto...
Ero appena entrato alla facoltà di inglese, quando presi parte al corso di discussione di George Gordon. E lì mi feci un nuovo amico. Le prime parole che pronunciò valsero a distinguerlo dagli altri dieci o dodici presenti; mi andò subito a genio,e questo, per di più, a un'età in cui le amicizie immediate della prima giovinezza andavano facendosi sempre più rare. Si chiamava Nevill Coghill. Scopersi subito con stupore che egli -senza dubbio il più intelligente e colto della classe -era cristiano e sovrannaturalista convinto...
Tutti i libri cominciavano a rivoltarmisi contro. In effetti, dovevo essere stato cieco come un pipistrello per non avere colto da un pezzo la ridicola contraddizione tra la mia teoria esistenziale e le mie reali esperienze di lettore. George MacDonald aveva fatto per me più di qualunque altro scrittore; naturalmente, era un peccato ch'egli avesse il pallino del cristianesimo. Era valido a dispetto di esso . Chesterton aveva più senso di tutti gli altri moderni messi insieme; e indipendentemente dal suo cristianesimo. Johnson era uno dei pochi autori di cui sentivo di potermi fidare ciecamente; abbastanza stranamente, aveva lo stesso pallino. Per una curiosa coincidenza, lo avevano anche Spenser e Milton. Era possibile scoprire lo stesso paradosso anche tra gli autori antichi. I più religiosi (Platone, Eschilo, Virgilio) erano senza dubbio quelli cui potevo realmente attingere. D'altro canto, gli scrittori non afflitti dalla religione e che in teoria avrebbero avuto diritto alla mia più totale simpatia -Shaw e Wells e Mill e Gibbon e Voltaire -avevano tutti un'aria un po'sparuta; quel sapore che da ragazzi chiamavamo "di latta". Non che non mi piacessero. Erano tutti (specialmente Gibbon) divertenti; ma niente di più. In essi non sembrava esserci profondità. Erano troppo semplici. Nei loro libri, la ruvidezza e la densità della vita non trasparivano. Ora che leggevo più inglesi, il paradosso andava sempre più peggiorando. Il Dream of the Rood mi commosse profondamente; Langland ancora di più; Donne (per qualche tempo) mi inebriò; Thomas Browne mi soddisfece profondamente e durevolmente. Ma il più allarmante di tutti fu George Herbert. Ecco un uomo che mi sembrava eccellesse su tutti gli altri autori nell'illustrare la vera qualità della vita come realmente la viviamo di momento in momento; ma il pover'uomo, anziché farlo direttamente, insisteva nel rimeditarla attraverso ciò ch'io avrei ancora chiamato "la mitologia cristiana". D'altro canto, la più parte degli autori che si potevano considerare precursori dell'illuminismo moderno mi sembravano robetta e mi annoiavano a morte. Di Bacon trovai che fosse (per dirla francamente) un solenne e presuntuoso somaro, della Restoration Comedy un unico immenso sbadiglio e, dopo essermi virilmente battuto per arrivare in fondo a Don Juan, scrissi sulla pagina finale: "Mai più". I soli non-cristiani che mi parve conoscessero veramente tutto furono i romantici; ed erano in buona parte minacciosamente contagiati da qualcosa che somigliava alla religione, e a volte persino dal Cristianesimo. Il succo si poteva più o meno esprimere in una corruzione del grande verso di Roland nella Chanson:
I cristiani hanno torto,
ma tutti gli altri sono noiosi.
La mossa più naturale sarebbe stata di accertarsi un po'più da vicino se i cristiani avessero, dopo tutto, torto. Ma non la feci. Pensavo di poterne dimostrare la superiorità senza quella ipotesi. Assurdamente (ma molti idealisti assoluti hanno condiviso tale assurdità) pensavo che "il mito cristiano"aprisse alle menti non filosofiche quanta verità, cioè di idealismo assoluto, fossero in grado di afferrare, e anche quanta li poneva al di sopra degli irreligiosi. Chi non riesce a elevarsi alla nozione di assoluto si accosterebbe alla verità più credendo in "un Dio"che non credendo affatto".
5 C.S.Lewis, Le cronache di Narnia, Mondadori, Milano, 2001, I volume, pagg.139-259.
6 Così Andrew Adamson, regista del film, in una intervista a Buena Vista, si è espresso intorno alla complessità del personaggio di Aslan, nella sua versione cinematografica: "Aslan è stato una sfida. È un personaggio molto importante nel libro e, naturalmente, molto complesso da riprodurre. Ma è molto difficile creare in particolare un personaggio onnipotente che sia anche accessibile. Vorresti provare compassione ed empatia quando va verso la sua morte... ma per fare questo deve essere umano e profondo e allo stesso tempo potente e feroce... come cita una frase del libro... non è un leone addomesticato. Liam Neeson possiede un grandissimo calore, ha una voce potente ed è anche capace di sprigionare una grande forza quando va in collera. Per cui è stata una grande sfida riunire tutte queste caratteristiche in un personaggio" . Purtroppo la scelta, in fase di doppiaggio della versione italiana, della voce di Omar Sharif, non ha permesso un analogo risultato.
7 C.S.Lewis, Il cristianesimo così com'è, Adelphi, Milano, 1997, pagg.83-88.
8 Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, p.III, q.46.
venerdì 11 agosto 2006
Dizionario del buon senso: una prefazione
Dizionario del buon senso: una prefazione
Per dirla subito e chiara: sfuggo, se appena possibile, alla pratica di quel faticoso – e rischioso – genere letterario che chiamano “prefazione”.
Innanzitutto, perché richiede la lettura di un libro che spesso non hai voglia di leggere, almeno in quel momento.
Quelli della mia generazione sono stati formati – e deformati – da certe brossure tascabili, con in copertina un fascinoso acquerello, l’indice degli articoli e la testata: Selezione dal Reader’s Digest. Un capolavoro mai riuscito ad altri, almeno in quelle dimensioni planetarie. Farcela, cioè, a riempire barche di soldi, vendendo a caro prezzo fascicoli di propaganda ben confezionata ma per niente dissimulata. Se tanti si sono convinti che non ci fosse salvezza se non nell’imitare, da provinciali poveri, l’american way of life, lo si deve anche a quelle pagine. I tedeschi, durante la guerra, avevano Signal: al di là dei contenuti, un capolavoro di tecnica redazionale, di impaginazione, di stampa. Esaminare qualche numero per credere. Non per niente la collezione la si studia nelle scuole migliori di questo nostro mestiere. Ma Signal (fino a tre milioni di copie in una dozzina di lingue, per sei anni, sino alla fine), a differenza del Reader’s Digest, che pagavamo, costava una cifra al Ministerium für Propaganda di quel simpaticone di Joseph dottor Goebbels.
Sto divagando, mi capita spesso. In realtà volevo dire, semplicemente, che non ho scordato due rubriche fondanti, due pilastri di quella melensa Selezione: Una persona che non dimenticherò mai e Il più bel giorno della mia vita. Quest’ultimo, per quel che mi riguarda, fu il giorno della laurea. Sbrigatomi con l’ultimo adempimento, la discussione della tesi, me ne uscii fischiettando dal grigio palazzotto sabaudo. Era grigio anche il cielo sopra Torino, ma il cuore scampanava a festa: avevo pagato il ticket d’ingresso alla vita e, finalmente, non sarei stato più costretto a studiare quanto interessava non a me, ma a un professore, per quanto illustre. Nessuno mi avrebbe più obbligato a seguire non le mie, ma le sue letture, i suoi progetti, le sue piste di ricerca. Il sollievo era tale che mi proposi di dedicare la vita alla carta stampata – mia e di altri – senza mettere più piede in una scuola, soprattutto se universitaria. Proposito, almeno questo, mantenuto.
Ebbene: accettare di stendere una prefazione non è, in fondo, rientrare nell’incubo scolastico, costringerti a prendere in mano, addirittura a studiare, un libro propostoti da altri?
Ma poi. Se l’autore è prestigioso e l’opera importante, presentarlo rischia di farti passare per parassita, per opportunista che si mette al traino del prestigio e dell’operosità di altri. Se, al contrario, pagine e autore valgono poco, nessuno ti risparmierà il sospetto di dilapidare quel po’ di autorevolezza che potresti avere per chissà quali inciuci, nepotismi, mafie, ricatti. Ci sarà pure un motivo inconfessabile ed occulto, se ti sei ridotto a far da paraculo a un simile mediocre.
Comunque sia, eccomi qua, a conferma che la coerenza è disumana e che (come insegnavano i benemeriti probabilisti barocchi della Compagnia di Gesù) è della condizione umana non essere coerenti a propositi e princìpi. Questi vanno sempre proclamati, mai però dimenticando che caro infirma est. Dunque, comprensione e perdono para todos. Eccomi qua, dunque, a “prefare” queste pagine di Stefano Lorenzetto. Rischiando, in questo caso, di passar per parassita od opportunista che approfitta dell’eccellenza altrui. In effetti, tanto per venire subito al sodo: il libro è buono; è molto buono. E non temo sospetti di adulazione, ho una prova ineccepibile di sincerità.
Ho chiesto al collega, difatti, di aiutarmi nel compito che – contradditoriamente – mi ero assunto, inviandomi quanto di significativo fosse stato scritto su di lui. Ho ricevuto un faldone elettronico imponente, dove ho avuto conferma, tra l’altro, di premi come il Saint Vincent e l’Estense: la cupola, i Pulitzer del giornalismo nostrano. Ho letto, con sotto firme prestigiose, sentenze come la seguente: «Lorenzetto produce arte sotto forma di giornalismo» (o, in una versione preferita da un altro recensore: «In lui il giornalismo confina con l’arte»). Dappertutto, tracimava la stima. Mentre scorrevo ammirato, un soprassalto. C’ero anch’io, tra quei tanti. Ma sì, la mia firma stava sotto la seguente frasetta: «L’ottimo Lorenzetto (le sue paginate di Tipi italiani me le centèllino)».
Non ricordavo, confesso, in che occasione o su quale giornale avessi detto o scritto quelle parole. Chiarii, poi, che stavano in una lettera che, nel 2001, inviai a Il Giornale. Ma appurare la fonte non era importante, visto che quella riga non è apocrifa, mi ci riconosco ancora; e non ho da pentirmene. Anzi, posso confermarla con maggior convinzione, visto che nel frattempo si sono succeduti, implacabili, i colloqui-paginone di Lorenzetto; ed io ho continuato a centellinare.
A stornare ancor più il sospetto, si precisa che il veronese autore e l’emilian-piemontese prefatore non sono amici, nel senso che – pur se sembrerà strano – non si sono mai frequentati, non fanno parte del cerchio consueto di sodali di redazione, di ristorante, di case al mare. Non partecipano, insomma, di quella colleganza che si fa camarilla e che porta a sorreggersi professionalmente, scambiandosi complimenti, recensioni, premi, nel nome (umanissimo anche questo, sia chiaro e, dunque, non condannabile) del do ut des. Sin qui, il nostro incontro è stato sempre e solo a livello di lettura reciproca, all’insaputa l’uno dell’altro, visto che mai ci siamo scambiati pareri sul rispettivo lavoro. Dunque, niente combine, niente amici degli amici.
La mia ammirazione per l’ars intervistatoria del Lorenzetto (sembra il nome di un pittore del Cinquecento veneziano, l’articolo “il” viene spontaneo per questo pennellatore di parole) è un’ammirazione da “tecnico”. È da uomo del mestiere quale sono – non so fare niente altro; e poi, si sa, è sempre meglio che lavorare – che cerca di spiegare ai ragazzotti e alle ragazzotte con registratore, taccuino, microfono che spesso lo tormentano, che l’intervista è un punto di arrivo della professione; non può, non deve essere un punto di partenza. Incapaci, temo, di strutturare un articolo come Dio e lettore comandano, pensano – quegli sbarbati – di cavarsela sbobinando da nastri o ribattendo letteralmente dagli appunti scarabocchiati.
In realtà, ciò che conta, nell’intervista, non sono le risposte (tutti sono capaci di bofonchiare qualcosa) ma le domande: è per domandare, non per rispondere, che ci vuole talento. E che bisogna far fatica. La fatica di sapere tutto, o almeno molto, dell’interlocutore da affrontare e su questa conoscenza modulare la griglia dei quesiti. Conservando, al contempo, il dono, o l’astuzia, della sorpresa e della scoperta da comunicare al lettore. Talento, fatica, studio. E umiltà. Quella di chi sa restare strumento a servizio delle piccole o grandi cose che l’intervistato può comunicare; e a servizio di chi investe soldi e tempo per leggere quelle righe e non gli interessa – in quella sede, almeno – che ne pensino il Lorenzetto o il Messori, bensì i loro interlocutori. Le domande che superano le poche, pochissime righe sono da principiante o da dilettante; o da egocentrico, che approfitta dell’occasione per intervistare se stesso; o da pigro, che non si è documentato e va sul generico e l’universale; o da insicuro che si blinda di parole.
Ma l’intervistatore ideale è anche educato, rispetta chi ha di fronte, rifugge dall’aggressività, diffida (o ride) del giornalista citoyen, quello che si indigna, che milita, che provoca, che moraleggia. Dio ci scampi dal periodismo di denuncia: garantisce chi, come me, lavorava nelle redazioni nei cupi Settanta, quando “er collega de sinistra”, quasi sempre un cronista del defunto Paese Sera, era uno stereotipo invariabilmente presente nei film engagés. I colloqui più esplosivi, devastanti – o, almeno, interessanti – ci sono offerti da chi sa indurre alla confidenza, addirittura alla confessione; dall’intervistatore mite, comprensivo, sottotono, magari un pizzico bonario. In apparenza, naturalmente. Nella realtà, le unghie più pericolose sono quelle dei felini, che le nascondono sotto l’aspetto di innocue, simpatiche babbucce. Lo sventurato rispose... E sono in tanti, per fortuna dei lettori, ad essere cascati nel trappolone di chi si presenta come un amico comprensivo, uno che potrebbe persino spacciarsi come un veneto un po’ dialettale e polentone, con il quale si può liberamente chiacchierare.
Se queste sono le virtù dell’intervistatore verace, del giornalista che sa stare al mondo, credo si possa dire – con oggettività – che queste virtù Lorenzetto le possiede. Del resto, non lo dico io, lo dice ciò che ha fatto e che ogni giorno fa, bulinando e cesellando i resoconti dei suoi incontri. Carta canta. Non canta un’amicizia un po’ mafiosa. Chi non è convinto, analizzi la tecnica e veda la “resa” giornalistica delle innumerevoli paginate-colloquio del Nostro.
Ma, per venire finalmente al libro che il lettore ha tra le mani. Qui c’è Stefano Lorenzetto che scrive in proprio, senza nascondersi dietro a interlocutori, c’è il giornalista che legge uno sconquasso di giornali (mi dicono una quindicina, solo di quotidiani), che accende la televisione, che si guarda attorno. E che riflette, commenta, opina, proponendoci il suo “secondo me”. Quasi ogni medium ha un signore di questo tipo. La categoria degli specialisti in varia umanità, in critica di costume, in corsivi, in elzeviri è inflazionata, così come lo è quella degli intervistatori. Il rubrichista, il corsivista, il commentatore, l’opinionista è, in fondo, un cannibale, forse anche un po’ parassita: è il giornalista che al mattino mangia giornali; e la digestione consiste nel darci il suo parere il mattino dopo.
Ma, pure tra questa turba, c’è – come sempre – il grano e c’è la paglia; c’è la farina e c’è la crusca. E, anche qui, il Nostro mi sembra far parte della prima categoria. Sembro ruffiano, lo so; e invece sono, ancora una volta, oggettivo. In effetti parlo, lo ripeto, da scriba di lungo corso; da chi, ormai vecchio – di anagrafe e di tessera dell’Ordine – sa che cosa dice. So bene, dunque, per esperienza annosa, che significhi fare una serie di interviste e, da esse, trarre dei libri. Ma so anche che significhi tenere un rubrica (una, sul quotidiano cattolico, mi spinsi a pubblicarla ben tre volte la settimana, per anni), so che significhi scrivere un corsivo, uno sfogo, un ritratto, un commento, un’opinione. Ho l’occhio logoro nel soppesare chi ha fatto e fa il mio stesso lavoro.
Se qui mi confermo nel giudizio di una qualità singolare, ci sono dei buoni motivi. Innanzitutto, quell’opinionista vulgaris (nel senso latino, s’intende...) che dicevamo è di bocca buona: gli bastano le notizie che trova in pagina e – pur sapendo bene quali siano le imprecisioni, le deformazioni, magari le faziosità delle redazioni – le commenta come fossero autentiche o, almeno, precise, così come sono pubblicate. La sua indolenza, poi, si spinge spesso al punto di non dargli neanche la voglia di aprire una qualche garzantina per controllare qualcosa.
È una pigrizia, è una superficialità che non affliggono di certo il Lorenzetto. La notizia su cui vuole dire la sua è per lui un punto di partenza per scavi sorprendenti: c’è da restare ammirati dallo scialo di cifre precise, di fatti correlati, di nomi verificati. È uno che, per dire, se si propone di parlare di “ecomostri”, approfitta di un viaggio lungo la costiera adriatica per contare quanti, e dove, siano gli edifici più alti di dieci piani. Se qualcuno pubblica che un manager sadomaso ha il vizietto di legare la segretaria al computer con una cravatta, ne misura una standard, accerta che è lunga solo 148 centimetri e che, dunque, l’erotica manovra è impraticabile. Se un moralista politically correct dice il suo sprezzo per chi appare in tv, soprattutto in tempi berlusconiani, Lorenzetto si irrita ma non fa come il corsivista normale, contrapponendo parole a parole. No, il nostro va a controllare (e non so proprio come abbia fatto), si procura tabulati ed elenchi, ricostruisce un calendario e, alla fine, sciorina una lista precisa delle comparsate catodiche praticate dallo sdegnoso collega predicatore. Se vuol parlare di francobolli si fa filatelico, prima di mettersi alla tastiera si costruisce una piccola ma puntuale cultura in proposito. Vuol prendersela con gli applausi alle casse da morto? Eccolo darsi a una ricerca di archivio per stabilire dove e quando risuonarono i primi battimani a un funerale. Deve riempire un lemma in cui parla del furto e gli vien comodo tirare in ballo San Tommaso d’Aquino? Qui, stupisce anche quel piccolo specialista che dovrei essere io stesso, dopo tanti anni di frequentazione di simili temi: ecco il nostro “tuttologo” trovare le citazioni giuste nelle molte Summae dell’Aquinate e applicarle in modo preciso ad appoggio della sua tesi.
Insomma, non c’è nulla della sciatteria pigra del commentatore che non leva il sedere dalla sedia, che se la cava con un repertorio di battute, che mescola sdegno e sarcasmo, che frigge – quasi fossero leccornie – parole imprecise nell’olio di altre parole altrettanto imprecise. C’è in Lorenzetto una curiosità di approfondire, di controllare, di parlare solo su dati e fatti precisi che dovrebbe essere di ogni gazzettiere e che gli dà una serietà che manca ai tanti colleghi che si misurano con quel nulla che è, troppo spesso, la “critica di costume”.
Ma c’è anche, qui, qualcosa di insolito per un genere che è tentato sempre dal moralismo. E sappiamo bene, noialtri della corporazione, da quali pulpiti vengano le prediche e le melasse “etiche”. Il Nostro non cade nella trappola, addita senza lagne e senza cattiverie, è lontano dai veleni del dottrinario alla giacobina che (lo osservava quel Tocqueville che praticavo anche quando era ben lontano dall’essere di moda) è sempre pronto a drammatizzare la piccola contingenza socio-politica e a demonizzare chi cade sotto la sua penna. Lorenzetto è di scuola veronese: c’è, nel veneto – intriso di un cattolicesimo solido e al contempo sanamente parrocchiale, alla San Pio X – un fondo di dolcezza naturale, di comprensione, di realismo cristiano che porta alla tolleranza e al rifiuto di trasformare in veleni mortali le spezie doverose della polemica. Una scuola, la veneta, ben lontana dalla toscana e dalla piemontese e che mi ha sempre ricordato quella emiliana, in particolare parmigiana, altrettanto umana e altrettanto affollata di geni e geniacci del giornalismo.
A proposito. Forse, l’impressione è solo personale: ma mi è sembrato di auscultare qualcosa che ho amato, in certi accenti dove lo stilettare di Lorenzetto non riesce a nascondere la bonarietà di fondo, in certo suo gusto di un umorismo salace e al contempo comprensivo, non maligno. Quel “qualcosa” è il ricordo di letture che furono tra quelle che segnarono la mia adolescenza: sono lo Zibaldino, innanzitutto; e, poi, Il destino si chiama Clotilde, La scoperta di Milano. Oltre, naturalmente, alla saga di Mondo piccolo. Ma sì, Giovannino Guareschi, quel grande parmigiano che so essere caro anche a questo veronese, pronto egli pure a fuggire da Milano per guardare il mondo dal nido caldo del suo paese. Guareschiane mi sembrano anche certe idiosincrasie curiose, certi rifiuti umorali, come l’avversione per gli anelli in dita maschili o per determinati tic ed espressioni linguistiche.
Poiché bisogna pur finire, una parola sul titolo. Il “buon senso” che spicca in copertina mi sembra adeguato a indicare il contenuto di un libro scritto da un uomo pragmatico, che rifugge dalle ideologie; da un moderato che non sa che farsene degli estremismi; da un giornalista pur colto, che ride delle astrattezze di tanti intellettuali; da un credente (spero di poterlo azzardare, senza violare una doverosa intimità) che sa che dono della fede è un realismo che impedisce di cadere nelle trappole dialettiche del “mondo”.
Il “buon senso” – il common sense degli anglosassoni, del mio venerato John Henry Newman – non è che il volto umile, quotidiano, di una ragione che, se non abusata e manipolata all’uso razionalista, sa farci distinguere ancora tra bene e male, tra umano e disumano. Che è ciò di cui abbiamo più bisogno, inquinati come siamo dalla nuova inquisizione, dal dogmatismo farisaico e feroce – dietro il volto suadente – della “correttezza politica”. Per questo, questo Dizionario mi sembra un atto di resistenza di cui noi, cultori coriacei del buon senso, dovremmo essere almeno un poco grati.
Vittorio Messori
© et-et.it | 2001-2006
Per dirla subito e chiara: sfuggo, se appena possibile, alla pratica di quel faticoso – e rischioso – genere letterario che chiamano “prefazione”.
Innanzitutto, perché richiede la lettura di un libro che spesso non hai voglia di leggere, almeno in quel momento.
Quelli della mia generazione sono stati formati – e deformati – da certe brossure tascabili, con in copertina un fascinoso acquerello, l’indice degli articoli e la testata: Selezione dal Reader’s Digest. Un capolavoro mai riuscito ad altri, almeno in quelle dimensioni planetarie. Farcela, cioè, a riempire barche di soldi, vendendo a caro prezzo fascicoli di propaganda ben confezionata ma per niente dissimulata. Se tanti si sono convinti che non ci fosse salvezza se non nell’imitare, da provinciali poveri, l’american way of life, lo si deve anche a quelle pagine. I tedeschi, durante la guerra, avevano Signal: al di là dei contenuti, un capolavoro di tecnica redazionale, di impaginazione, di stampa. Esaminare qualche numero per credere. Non per niente la collezione la si studia nelle scuole migliori di questo nostro mestiere. Ma Signal (fino a tre milioni di copie in una dozzina di lingue, per sei anni, sino alla fine), a differenza del Reader’s Digest, che pagavamo, costava una cifra al Ministerium für Propaganda di quel simpaticone di Joseph dottor Goebbels.
Sto divagando, mi capita spesso. In realtà volevo dire, semplicemente, che non ho scordato due rubriche fondanti, due pilastri di quella melensa Selezione: Una persona che non dimenticherò mai e Il più bel giorno della mia vita. Quest’ultimo, per quel che mi riguarda, fu il giorno della laurea. Sbrigatomi con l’ultimo adempimento, la discussione della tesi, me ne uscii fischiettando dal grigio palazzotto sabaudo. Era grigio anche il cielo sopra Torino, ma il cuore scampanava a festa: avevo pagato il ticket d’ingresso alla vita e, finalmente, non sarei stato più costretto a studiare quanto interessava non a me, ma a un professore, per quanto illustre. Nessuno mi avrebbe più obbligato a seguire non le mie, ma le sue letture, i suoi progetti, le sue piste di ricerca. Il sollievo era tale che mi proposi di dedicare la vita alla carta stampata – mia e di altri – senza mettere più piede in una scuola, soprattutto se universitaria. Proposito, almeno questo, mantenuto.
Ebbene: accettare di stendere una prefazione non è, in fondo, rientrare nell’incubo scolastico, costringerti a prendere in mano, addirittura a studiare, un libro propostoti da altri?
Ma poi. Se l’autore è prestigioso e l’opera importante, presentarlo rischia di farti passare per parassita, per opportunista che si mette al traino del prestigio e dell’operosità di altri. Se, al contrario, pagine e autore valgono poco, nessuno ti risparmierà il sospetto di dilapidare quel po’ di autorevolezza che potresti avere per chissà quali inciuci, nepotismi, mafie, ricatti. Ci sarà pure un motivo inconfessabile ed occulto, se ti sei ridotto a far da paraculo a un simile mediocre.
Comunque sia, eccomi qua, a conferma che la coerenza è disumana e che (come insegnavano i benemeriti probabilisti barocchi della Compagnia di Gesù) è della condizione umana non essere coerenti a propositi e princìpi. Questi vanno sempre proclamati, mai però dimenticando che caro infirma est. Dunque, comprensione e perdono para todos. Eccomi qua, dunque, a “prefare” queste pagine di Stefano Lorenzetto. Rischiando, in questo caso, di passar per parassita od opportunista che approfitta dell’eccellenza altrui. In effetti, tanto per venire subito al sodo: il libro è buono; è molto buono. E non temo sospetti di adulazione, ho una prova ineccepibile di sincerità.
Ho chiesto al collega, difatti, di aiutarmi nel compito che – contradditoriamente – mi ero assunto, inviandomi quanto di significativo fosse stato scritto su di lui. Ho ricevuto un faldone elettronico imponente, dove ho avuto conferma, tra l’altro, di premi come il Saint Vincent e l’Estense: la cupola, i Pulitzer del giornalismo nostrano. Ho letto, con sotto firme prestigiose, sentenze come la seguente: «Lorenzetto produce arte sotto forma di giornalismo» (o, in una versione preferita da un altro recensore: «In lui il giornalismo confina con l’arte»). Dappertutto, tracimava la stima. Mentre scorrevo ammirato, un soprassalto. C’ero anch’io, tra quei tanti. Ma sì, la mia firma stava sotto la seguente frasetta: «L’ottimo Lorenzetto (le sue paginate di Tipi italiani me le centèllino)».
Non ricordavo, confesso, in che occasione o su quale giornale avessi detto o scritto quelle parole. Chiarii, poi, che stavano in una lettera che, nel 2001, inviai a Il Giornale. Ma appurare la fonte non era importante, visto che quella riga non è apocrifa, mi ci riconosco ancora; e non ho da pentirmene. Anzi, posso confermarla con maggior convinzione, visto che nel frattempo si sono succeduti, implacabili, i colloqui-paginone di Lorenzetto; ed io ho continuato a centellinare.
A stornare ancor più il sospetto, si precisa che il veronese autore e l’emilian-piemontese prefatore non sono amici, nel senso che – pur se sembrerà strano – non si sono mai frequentati, non fanno parte del cerchio consueto di sodali di redazione, di ristorante, di case al mare. Non partecipano, insomma, di quella colleganza che si fa camarilla e che porta a sorreggersi professionalmente, scambiandosi complimenti, recensioni, premi, nel nome (umanissimo anche questo, sia chiaro e, dunque, non condannabile) del do ut des. Sin qui, il nostro incontro è stato sempre e solo a livello di lettura reciproca, all’insaputa l’uno dell’altro, visto che mai ci siamo scambiati pareri sul rispettivo lavoro. Dunque, niente combine, niente amici degli amici.
La mia ammirazione per l’ars intervistatoria del Lorenzetto (sembra il nome di un pittore del Cinquecento veneziano, l’articolo “il” viene spontaneo per questo pennellatore di parole) è un’ammirazione da “tecnico”. È da uomo del mestiere quale sono – non so fare niente altro; e poi, si sa, è sempre meglio che lavorare – che cerca di spiegare ai ragazzotti e alle ragazzotte con registratore, taccuino, microfono che spesso lo tormentano, che l’intervista è un punto di arrivo della professione; non può, non deve essere un punto di partenza. Incapaci, temo, di strutturare un articolo come Dio e lettore comandano, pensano – quegli sbarbati – di cavarsela sbobinando da nastri o ribattendo letteralmente dagli appunti scarabocchiati.
In realtà, ciò che conta, nell’intervista, non sono le risposte (tutti sono capaci di bofonchiare qualcosa) ma le domande: è per domandare, non per rispondere, che ci vuole talento. E che bisogna far fatica. La fatica di sapere tutto, o almeno molto, dell’interlocutore da affrontare e su questa conoscenza modulare la griglia dei quesiti. Conservando, al contempo, il dono, o l’astuzia, della sorpresa e della scoperta da comunicare al lettore. Talento, fatica, studio. E umiltà. Quella di chi sa restare strumento a servizio delle piccole o grandi cose che l’intervistato può comunicare; e a servizio di chi investe soldi e tempo per leggere quelle righe e non gli interessa – in quella sede, almeno – che ne pensino il Lorenzetto o il Messori, bensì i loro interlocutori. Le domande che superano le poche, pochissime righe sono da principiante o da dilettante; o da egocentrico, che approfitta dell’occasione per intervistare se stesso; o da pigro, che non si è documentato e va sul generico e l’universale; o da insicuro che si blinda di parole.
Ma l’intervistatore ideale è anche educato, rispetta chi ha di fronte, rifugge dall’aggressività, diffida (o ride) del giornalista citoyen, quello che si indigna, che milita, che provoca, che moraleggia. Dio ci scampi dal periodismo di denuncia: garantisce chi, come me, lavorava nelle redazioni nei cupi Settanta, quando “er collega de sinistra”, quasi sempre un cronista del defunto Paese Sera, era uno stereotipo invariabilmente presente nei film engagés. I colloqui più esplosivi, devastanti – o, almeno, interessanti – ci sono offerti da chi sa indurre alla confidenza, addirittura alla confessione; dall’intervistatore mite, comprensivo, sottotono, magari un pizzico bonario. In apparenza, naturalmente. Nella realtà, le unghie più pericolose sono quelle dei felini, che le nascondono sotto l’aspetto di innocue, simpatiche babbucce. Lo sventurato rispose... E sono in tanti, per fortuna dei lettori, ad essere cascati nel trappolone di chi si presenta come un amico comprensivo, uno che potrebbe persino spacciarsi come un veneto un po’ dialettale e polentone, con il quale si può liberamente chiacchierare.
Se queste sono le virtù dell’intervistatore verace, del giornalista che sa stare al mondo, credo si possa dire – con oggettività – che queste virtù Lorenzetto le possiede. Del resto, non lo dico io, lo dice ciò che ha fatto e che ogni giorno fa, bulinando e cesellando i resoconti dei suoi incontri. Carta canta. Non canta un’amicizia un po’ mafiosa. Chi non è convinto, analizzi la tecnica e veda la “resa” giornalistica delle innumerevoli paginate-colloquio del Nostro.
Ma, per venire finalmente al libro che il lettore ha tra le mani. Qui c’è Stefano Lorenzetto che scrive in proprio, senza nascondersi dietro a interlocutori, c’è il giornalista che legge uno sconquasso di giornali (mi dicono una quindicina, solo di quotidiani), che accende la televisione, che si guarda attorno. E che riflette, commenta, opina, proponendoci il suo “secondo me”. Quasi ogni medium ha un signore di questo tipo. La categoria degli specialisti in varia umanità, in critica di costume, in corsivi, in elzeviri è inflazionata, così come lo è quella degli intervistatori. Il rubrichista, il corsivista, il commentatore, l’opinionista è, in fondo, un cannibale, forse anche un po’ parassita: è il giornalista che al mattino mangia giornali; e la digestione consiste nel darci il suo parere il mattino dopo.
Ma, pure tra questa turba, c’è – come sempre – il grano e c’è la paglia; c’è la farina e c’è la crusca. E, anche qui, il Nostro mi sembra far parte della prima categoria. Sembro ruffiano, lo so; e invece sono, ancora una volta, oggettivo. In effetti parlo, lo ripeto, da scriba di lungo corso; da chi, ormai vecchio – di anagrafe e di tessera dell’Ordine – sa che cosa dice. So bene, dunque, per esperienza annosa, che significhi fare una serie di interviste e, da esse, trarre dei libri. Ma so anche che significhi tenere un rubrica (una, sul quotidiano cattolico, mi spinsi a pubblicarla ben tre volte la settimana, per anni), so che significhi scrivere un corsivo, uno sfogo, un ritratto, un commento, un’opinione. Ho l’occhio logoro nel soppesare chi ha fatto e fa il mio stesso lavoro.
Se qui mi confermo nel giudizio di una qualità singolare, ci sono dei buoni motivi. Innanzitutto, quell’opinionista vulgaris (nel senso latino, s’intende...) che dicevamo è di bocca buona: gli bastano le notizie che trova in pagina e – pur sapendo bene quali siano le imprecisioni, le deformazioni, magari le faziosità delle redazioni – le commenta come fossero autentiche o, almeno, precise, così come sono pubblicate. La sua indolenza, poi, si spinge spesso al punto di non dargli neanche la voglia di aprire una qualche garzantina per controllare qualcosa.
È una pigrizia, è una superficialità che non affliggono di certo il Lorenzetto. La notizia su cui vuole dire la sua è per lui un punto di partenza per scavi sorprendenti: c’è da restare ammirati dallo scialo di cifre precise, di fatti correlati, di nomi verificati. È uno che, per dire, se si propone di parlare di “ecomostri”, approfitta di un viaggio lungo la costiera adriatica per contare quanti, e dove, siano gli edifici più alti di dieci piani. Se qualcuno pubblica che un manager sadomaso ha il vizietto di legare la segretaria al computer con una cravatta, ne misura una standard, accerta che è lunga solo 148 centimetri e che, dunque, l’erotica manovra è impraticabile. Se un moralista politically correct dice il suo sprezzo per chi appare in tv, soprattutto in tempi berlusconiani, Lorenzetto si irrita ma non fa come il corsivista normale, contrapponendo parole a parole. No, il nostro va a controllare (e non so proprio come abbia fatto), si procura tabulati ed elenchi, ricostruisce un calendario e, alla fine, sciorina una lista precisa delle comparsate catodiche praticate dallo sdegnoso collega predicatore. Se vuol parlare di francobolli si fa filatelico, prima di mettersi alla tastiera si costruisce una piccola ma puntuale cultura in proposito. Vuol prendersela con gli applausi alle casse da morto? Eccolo darsi a una ricerca di archivio per stabilire dove e quando risuonarono i primi battimani a un funerale. Deve riempire un lemma in cui parla del furto e gli vien comodo tirare in ballo San Tommaso d’Aquino? Qui, stupisce anche quel piccolo specialista che dovrei essere io stesso, dopo tanti anni di frequentazione di simili temi: ecco il nostro “tuttologo” trovare le citazioni giuste nelle molte Summae dell’Aquinate e applicarle in modo preciso ad appoggio della sua tesi.
Insomma, non c’è nulla della sciatteria pigra del commentatore che non leva il sedere dalla sedia, che se la cava con un repertorio di battute, che mescola sdegno e sarcasmo, che frigge – quasi fossero leccornie – parole imprecise nell’olio di altre parole altrettanto imprecise. C’è in Lorenzetto una curiosità di approfondire, di controllare, di parlare solo su dati e fatti precisi che dovrebbe essere di ogni gazzettiere e che gli dà una serietà che manca ai tanti colleghi che si misurano con quel nulla che è, troppo spesso, la “critica di costume”.
Ma c’è anche, qui, qualcosa di insolito per un genere che è tentato sempre dal moralismo. E sappiamo bene, noialtri della corporazione, da quali pulpiti vengano le prediche e le melasse “etiche”. Il Nostro non cade nella trappola, addita senza lagne e senza cattiverie, è lontano dai veleni del dottrinario alla giacobina che (lo osservava quel Tocqueville che praticavo anche quando era ben lontano dall’essere di moda) è sempre pronto a drammatizzare la piccola contingenza socio-politica e a demonizzare chi cade sotto la sua penna. Lorenzetto è di scuola veronese: c’è, nel veneto – intriso di un cattolicesimo solido e al contempo sanamente parrocchiale, alla San Pio X – un fondo di dolcezza naturale, di comprensione, di realismo cristiano che porta alla tolleranza e al rifiuto di trasformare in veleni mortali le spezie doverose della polemica. Una scuola, la veneta, ben lontana dalla toscana e dalla piemontese e che mi ha sempre ricordato quella emiliana, in particolare parmigiana, altrettanto umana e altrettanto affollata di geni e geniacci del giornalismo.
A proposito. Forse, l’impressione è solo personale: ma mi è sembrato di auscultare qualcosa che ho amato, in certi accenti dove lo stilettare di Lorenzetto non riesce a nascondere la bonarietà di fondo, in certo suo gusto di un umorismo salace e al contempo comprensivo, non maligno. Quel “qualcosa” è il ricordo di letture che furono tra quelle che segnarono la mia adolescenza: sono lo Zibaldino, innanzitutto; e, poi, Il destino si chiama Clotilde, La scoperta di Milano. Oltre, naturalmente, alla saga di Mondo piccolo. Ma sì, Giovannino Guareschi, quel grande parmigiano che so essere caro anche a questo veronese, pronto egli pure a fuggire da Milano per guardare il mondo dal nido caldo del suo paese. Guareschiane mi sembrano anche certe idiosincrasie curiose, certi rifiuti umorali, come l’avversione per gli anelli in dita maschili o per determinati tic ed espressioni linguistiche.
Poiché bisogna pur finire, una parola sul titolo. Il “buon senso” che spicca in copertina mi sembra adeguato a indicare il contenuto di un libro scritto da un uomo pragmatico, che rifugge dalle ideologie; da un moderato che non sa che farsene degli estremismi; da un giornalista pur colto, che ride delle astrattezze di tanti intellettuali; da un credente (spero di poterlo azzardare, senza violare una doverosa intimità) che sa che dono della fede è un realismo che impedisce di cadere nelle trappole dialettiche del “mondo”.
Il “buon senso” – il common sense degli anglosassoni, del mio venerato John Henry Newman – non è che il volto umile, quotidiano, di una ragione che, se non abusata e manipolata all’uso razionalista, sa farci distinguere ancora tra bene e male, tra umano e disumano. Che è ciò di cui abbiamo più bisogno, inquinati come siamo dalla nuova inquisizione, dal dogmatismo farisaico e feroce – dietro il volto suadente – della “correttezza politica”. Per questo, questo Dizionario mi sembra un atto di resistenza di cui noi, cultori coriacei del buon senso, dovremmo essere almeno un poco grati.
Vittorio Messori
© et-et.it | 2001-2006
Dizionario del buon senso: una prefazione
Dizionario del buon senso: una prefazione
Per dirla subito e chiara: sfuggo, se appena possibile, alla pratica di quel faticoso – e rischioso – genere letterario che chiamano “prefazione”.
Innanzitutto, perché richiede la lettura di un libro che spesso non hai voglia di leggere, almeno in quel momento.
Quelli della mia generazione sono stati formati – e deformati – da certe brossure tascabili, con in copertina un fascinoso acquerello, l’indice degli articoli e la testata: Selezione dal Reader’s Digest. Un capolavoro mai riuscito ad altri, almeno in quelle dimensioni planetarie. Farcela, cioè, a riempire barche di soldi, vendendo a caro prezzo fascicoli di propaganda ben confezionata ma per niente dissimulata. Se tanti si sono convinti che non ci fosse salvezza se non nell’imitare, da provinciali poveri, l’american way of life, lo si deve anche a quelle pagine. I tedeschi, durante la guerra, avevano Signal: al di là dei contenuti, un capolavoro di tecnica redazionale, di impaginazione, di stampa. Esaminare qualche numero per credere. Non per niente la collezione la si studia nelle scuole migliori di questo nostro mestiere. Ma Signal (fino a tre milioni di copie in una dozzina di lingue, per sei anni, sino alla fine), a differenza del Reader’s Digest, che pagavamo, costava una cifra al Ministerium für Propaganda di quel simpaticone di Joseph dottor Goebbels.
Sto divagando, mi capita spesso. In realtà volevo dire, semplicemente, che non ho scordato due rubriche fondanti, due pilastri di quella melensa Selezione: Una persona che non dimenticherò mai e Il più bel giorno della mia vita. Quest’ultimo, per quel che mi riguarda, fu il giorno della laurea. Sbrigatomi con l’ultimo adempimento, la discussione della tesi, me ne uscii fischiettando dal grigio palazzotto sabaudo. Era grigio anche il cielo sopra Torino, ma il cuore scampanava a festa: avevo pagato il ticket d’ingresso alla vita e, finalmente, non sarei stato più costretto a studiare quanto interessava non a me, ma a un professore, per quanto illustre. Nessuno mi avrebbe più obbligato a seguire non le mie, ma le sue letture, i suoi progetti, le sue piste di ricerca. Il sollievo era tale che mi proposi di dedicare la vita alla carta stampata – mia e di altri – senza mettere più piede in una scuola, soprattutto se universitaria. Proposito, almeno questo, mantenuto.
Ebbene: accettare di stendere una prefazione non è, in fondo, rientrare nell’incubo scolastico, costringerti a prendere in mano, addirittura a studiare, un libro propostoti da altri?
Ma poi. Se l’autore è prestigioso e l’opera importante, presentarlo rischia di farti passare per parassita, per opportunista che si mette al traino del prestigio e dell’operosità di altri. Se, al contrario, pagine e autore valgono poco, nessuno ti risparmierà il sospetto di dilapidare quel po’ di autorevolezza che potresti avere per chissà quali inciuci, nepotismi, mafie, ricatti. Ci sarà pure un motivo inconfessabile ed occulto, se ti sei ridotto a far da paraculo a un simile mediocre.
Comunque sia, eccomi qua, a conferma che la coerenza è disumana e che (come insegnavano i benemeriti probabilisti barocchi della Compagnia di Gesù) è della condizione umana non essere coerenti a propositi e princìpi. Questi vanno sempre proclamati, mai però dimenticando che caro infirma est. Dunque, comprensione e perdono para todos. Eccomi qua, dunque, a “prefare” queste pagine di Stefano Lorenzetto. Rischiando, in questo caso, di passar per parassita od opportunista che approfitta dell’eccellenza altrui. In effetti, tanto per venire subito al sodo: il libro è buono; è molto buono. E non temo sospetti di adulazione, ho una prova ineccepibile di sincerità.
Ho chiesto al collega, difatti, di aiutarmi nel compito che – contradditoriamente – mi ero assunto, inviandomi quanto di significativo fosse stato scritto su di lui. Ho ricevuto un faldone elettronico imponente, dove ho avuto conferma, tra l’altro, di premi come il Saint Vincent e l’Estense: la cupola, i Pulitzer del giornalismo nostrano. Ho letto, con sotto firme prestigiose, sentenze come la seguente: «Lorenzetto produce arte sotto forma di giornalismo» (o, in una versione preferita da un altro recensore: «In lui il giornalismo confina con l’arte»). Dappertutto, tracimava la stima. Mentre scorrevo ammirato, un soprassalto. C’ero anch’io, tra quei tanti. Ma sì, la mia firma stava sotto la seguente frasetta: «L’ottimo Lorenzetto (le sue paginate di Tipi italiani me le centèllino)».
Non ricordavo, confesso, in che occasione o su quale giornale avessi detto o scritto quelle parole. Chiarii, poi, che stavano in una lettera che, nel 2001, inviai a Il Giornale. Ma appurare la fonte non era importante, visto che quella riga non è apocrifa, mi ci riconosco ancora; e non ho da pentirmene. Anzi, posso confermarla con maggior convinzione, visto che nel frattempo si sono succeduti, implacabili, i colloqui-paginone di Lorenzetto; ed io ho continuato a centellinare.
A stornare ancor più il sospetto, si precisa che il veronese autore e l’emilian-piemontese prefatore non sono amici, nel senso che – pur se sembrerà strano – non si sono mai frequentati, non fanno parte del cerchio consueto di sodali di redazione, di ristorante, di case al mare. Non partecipano, insomma, di quella colleganza che si fa camarilla e che porta a sorreggersi professionalmente, scambiandosi complimenti, recensioni, premi, nel nome (umanissimo anche questo, sia chiaro e, dunque, non condannabile) del do ut des. Sin qui, il nostro incontro è stato sempre e solo a livello di lettura reciproca, all’insaputa l’uno dell’altro, visto che mai ci siamo scambiati pareri sul rispettivo lavoro. Dunque, niente combine, niente amici degli amici.
La mia ammirazione per l’ars intervistatoria del Lorenzetto (sembra il nome di un pittore del Cinquecento veneziano, l’articolo “il” viene spontaneo per questo pennellatore di parole) è un’ammirazione da “tecnico”. È da uomo del mestiere quale sono – non so fare niente altro; e poi, si sa, è sempre meglio che lavorare – che cerca di spiegare ai ragazzotti e alle ragazzotte con registratore, taccuino, microfono che spesso lo tormentano, che l’intervista è un punto di arrivo della professione; non può, non deve essere un punto di partenza. Incapaci, temo, di strutturare un articolo come Dio e lettore comandano, pensano – quegli sbarbati – di cavarsela sbobinando da nastri o ribattendo letteralmente dagli appunti scarabocchiati.
In realtà, ciò che conta, nell’intervista, non sono le risposte (tutti sono capaci di bofonchiare qualcosa) ma le domande: è per domandare, non per rispondere, che ci vuole talento. E che bisogna far fatica. La fatica di sapere tutto, o almeno molto, dell’interlocutore da affrontare e su questa conoscenza modulare la griglia dei quesiti. Conservando, al contempo, il dono, o l’astuzia, della sorpresa e della scoperta da comunicare al lettore. Talento, fatica, studio. E umiltà. Quella di chi sa restare strumento a servizio delle piccole o grandi cose che l’intervistato può comunicare; e a servizio di chi investe soldi e tempo per leggere quelle righe e non gli interessa – in quella sede, almeno – che ne pensino il Lorenzetto o il Messori, bensì i loro interlocutori. Le domande che superano le poche, pochissime righe sono da principiante o da dilettante; o da egocentrico, che approfitta dell’occasione per intervistare se stesso; o da pigro, che non si è documentato e va sul generico e l’universale; o da insicuro che si blinda di parole.
Ma l’intervistatore ideale è anche educato, rispetta chi ha di fronte, rifugge dall’aggressività, diffida (o ride) del giornalista citoyen, quello che si indigna, che milita, che provoca, che moraleggia. Dio ci scampi dal periodismo di denuncia: garantisce chi, come me, lavorava nelle redazioni nei cupi Settanta, quando “er collega de sinistra”, quasi sempre un cronista del defunto Paese Sera, era uno stereotipo invariabilmente presente nei film engagés. I colloqui più esplosivi, devastanti – o, almeno, interessanti – ci sono offerti da chi sa indurre alla confidenza, addirittura alla confessione; dall’intervistatore mite, comprensivo, sottotono, magari un pizzico bonario. In apparenza, naturalmente. Nella realtà, le unghie più pericolose sono quelle dei felini, che le nascondono sotto l’aspetto di innocue, simpatiche babbucce. Lo sventurato rispose... E sono in tanti, per fortuna dei lettori, ad essere cascati nel trappolone di chi si presenta come un amico comprensivo, uno che potrebbe persino spacciarsi come un veneto un po’ dialettale e polentone, con il quale si può liberamente chiacchierare.
Se queste sono le virtù dell’intervistatore verace, del giornalista che sa stare al mondo, credo si possa dire – con oggettività – che queste virtù Lorenzetto le possiede. Del resto, non lo dico io, lo dice ciò che ha fatto e che ogni giorno fa, bulinando e cesellando i resoconti dei suoi incontri. Carta canta. Non canta un’amicizia un po’ mafiosa. Chi non è convinto, analizzi la tecnica e veda la “resa” giornalistica delle innumerevoli paginate-colloquio del Nostro.
Ma, per venire finalmente al libro che il lettore ha tra le mani. Qui c’è Stefano Lorenzetto che scrive in proprio, senza nascondersi dietro a interlocutori, c’è il giornalista che legge uno sconquasso di giornali (mi dicono una quindicina, solo di quotidiani), che accende la televisione, che si guarda attorno. E che riflette, commenta, opina, proponendoci il suo “secondo me”. Quasi ogni medium ha un signore di questo tipo. La categoria degli specialisti in varia umanità, in critica di costume, in corsivi, in elzeviri è inflazionata, così come lo è quella degli intervistatori. Il rubrichista, il corsivista, il commentatore, l’opinionista è, in fondo, un cannibale, forse anche un po’ parassita: è il giornalista che al mattino mangia giornali; e la digestione consiste nel darci il suo parere il mattino dopo.
Ma, pure tra questa turba, c’è – come sempre – il grano e c’è la paglia; c’è la farina e c’è la crusca. E, anche qui, il Nostro mi sembra far parte della prima categoria. Sembro ruffiano, lo so; e invece sono, ancora una volta, oggettivo. In effetti parlo, lo ripeto, da scriba di lungo corso; da chi, ormai vecchio – di anagrafe e di tessera dell’Ordine – sa che cosa dice. So bene, dunque, per esperienza annosa, che significhi fare una serie di interviste e, da esse, trarre dei libri. Ma so anche che significhi tenere un rubrica (una, sul quotidiano cattolico, mi spinsi a pubblicarla ben tre volte la settimana, per anni), so che significhi scrivere un corsivo, uno sfogo, un ritratto, un commento, un’opinione. Ho l’occhio logoro nel soppesare chi ha fatto e fa il mio stesso lavoro.
Se qui mi confermo nel giudizio di una qualità singolare, ci sono dei buoni motivi. Innanzitutto, quell’opinionista vulgaris (nel senso latino, s’intende...) che dicevamo è di bocca buona: gli bastano le notizie che trova in pagina e – pur sapendo bene quali siano le imprecisioni, le deformazioni, magari le faziosità delle redazioni – le commenta come fossero autentiche o, almeno, precise, così come sono pubblicate. La sua indolenza, poi, si spinge spesso al punto di non dargli neanche la voglia di aprire una qualche garzantina per controllare qualcosa.
È una pigrizia, è una superficialità che non affliggono di certo il Lorenzetto. La notizia su cui vuole dire la sua è per lui un punto di partenza per scavi sorprendenti: c’è da restare ammirati dallo scialo di cifre precise, di fatti correlati, di nomi verificati. È uno che, per dire, se si propone di parlare di “ecomostri”, approfitta di un viaggio lungo la costiera adriatica per contare quanti, e dove, siano gli edifici più alti di dieci piani. Se qualcuno pubblica che un manager sadomaso ha il vizietto di legare la segretaria al computer con una cravatta, ne misura una standard, accerta che è lunga solo 148 centimetri e che, dunque, l’erotica manovra è impraticabile. Se un moralista politically correct dice il suo sprezzo per chi appare in tv, soprattutto in tempi berlusconiani, Lorenzetto si irrita ma non fa come il corsivista normale, contrapponendo parole a parole. No, il nostro va a controllare (e non so proprio come abbia fatto), si procura tabulati ed elenchi, ricostruisce un calendario e, alla fine, sciorina una lista precisa delle comparsate catodiche praticate dallo sdegnoso collega predicatore. Se vuol parlare di francobolli si fa filatelico, prima di mettersi alla tastiera si costruisce una piccola ma puntuale cultura in proposito. Vuol prendersela con gli applausi alle casse da morto? Eccolo darsi a una ricerca di archivio per stabilire dove e quando risuonarono i primi battimani a un funerale. Deve riempire un lemma in cui parla del furto e gli vien comodo tirare in ballo San Tommaso d’Aquino? Qui, stupisce anche quel piccolo specialista che dovrei essere io stesso, dopo tanti anni di frequentazione di simili temi: ecco il nostro “tuttologo” trovare le citazioni giuste nelle molte Summae dell’Aquinate e applicarle in modo preciso ad appoggio della sua tesi.
Insomma, non c’è nulla della sciatteria pigra del commentatore che non leva il sedere dalla sedia, che se la cava con un repertorio di battute, che mescola sdegno e sarcasmo, che frigge – quasi fossero leccornie – parole imprecise nell’olio di altre parole altrettanto imprecise. C’è in Lorenzetto una curiosità di approfondire, di controllare, di parlare solo su dati e fatti precisi che dovrebbe essere di ogni gazzettiere e che gli dà una serietà che manca ai tanti colleghi che si misurano con quel nulla che è, troppo spesso, la “critica di costume”.
Ma c’è anche, qui, qualcosa di insolito per un genere che è tentato sempre dal moralismo. E sappiamo bene, noialtri della corporazione, da quali pulpiti vengano le prediche e le melasse “etiche”. Il Nostro non cade nella trappola, addita senza lagne e senza cattiverie, è lontano dai veleni del dottrinario alla giacobina che (lo osservava quel Tocqueville che praticavo anche quando era ben lontano dall’essere di moda) è sempre pronto a drammatizzare la piccola contingenza socio-politica e a demonizzare chi cade sotto la sua penna. Lorenzetto è di scuola veronese: c’è, nel veneto – intriso di un cattolicesimo solido e al contempo sanamente parrocchiale, alla San Pio X – un fondo di dolcezza naturale, di comprensione, di realismo cristiano che porta alla tolleranza e al rifiuto di trasformare in veleni mortali le spezie doverose della polemica. Una scuola, la veneta, ben lontana dalla toscana e dalla piemontese e che mi ha sempre ricordato quella emiliana, in particolare parmigiana, altrettanto umana e altrettanto affollata di geni e geniacci del giornalismo.
A proposito. Forse, l’impressione è solo personale: ma mi è sembrato di auscultare qualcosa che ho amato, in certi accenti dove lo stilettare di Lorenzetto non riesce a nascondere la bonarietà di fondo, in certo suo gusto di un umorismo salace e al contempo comprensivo, non maligno. Quel “qualcosa” è il ricordo di letture che furono tra quelle che segnarono la mia adolescenza: sono lo Zibaldino, innanzitutto; e, poi, Il destino si chiama Clotilde, La scoperta di Milano. Oltre, naturalmente, alla saga di Mondo piccolo. Ma sì, Giovannino Guareschi, quel grande parmigiano che so essere caro anche a questo veronese, pronto egli pure a fuggire da Milano per guardare il mondo dal nido caldo del suo paese. Guareschiane mi sembrano anche certe idiosincrasie curiose, certi rifiuti umorali, come l’avversione per gli anelli in dita maschili o per determinati tic ed espressioni linguistiche.
Poiché bisogna pur finire, una parola sul titolo. Il “buon senso” che spicca in copertina mi sembra adeguato a indicare il contenuto di un libro scritto da un uomo pragmatico, che rifugge dalle ideologie; da un moderato che non sa che farsene degli estremismi; da un giornalista pur colto, che ride delle astrattezze di tanti intellettuali; da un credente (spero di poterlo azzardare, senza violare una doverosa intimità) che sa che dono della fede è un realismo che impedisce di cadere nelle trappole dialettiche del “mondo”.
Il “buon senso” – il common sense degli anglosassoni, del mio venerato John Henry Newman – non è che il volto umile, quotidiano, di una ragione che, se non abusata e manipolata all’uso razionalista, sa farci distinguere ancora tra bene e male, tra umano e disumano. Che è ciò di cui abbiamo più bisogno, inquinati come siamo dalla nuova inquisizione, dal dogmatismo farisaico e feroce – dietro il volto suadente – della “correttezza politica”. Per questo, questo Dizionario mi sembra un atto di resistenza di cui noi, cultori coriacei del buon senso, dovremmo essere almeno un poco grati.
Vittorio Messori
© et-et.it | 2001-2006
Per dirla subito e chiara: sfuggo, se appena possibile, alla pratica di quel faticoso – e rischioso – genere letterario che chiamano “prefazione”.
Innanzitutto, perché richiede la lettura di un libro che spesso non hai voglia di leggere, almeno in quel momento.
Quelli della mia generazione sono stati formati – e deformati – da certe brossure tascabili, con in copertina un fascinoso acquerello, l’indice degli articoli e la testata: Selezione dal Reader’s Digest. Un capolavoro mai riuscito ad altri, almeno in quelle dimensioni planetarie. Farcela, cioè, a riempire barche di soldi, vendendo a caro prezzo fascicoli di propaganda ben confezionata ma per niente dissimulata. Se tanti si sono convinti che non ci fosse salvezza se non nell’imitare, da provinciali poveri, l’american way of life, lo si deve anche a quelle pagine. I tedeschi, durante la guerra, avevano Signal: al di là dei contenuti, un capolavoro di tecnica redazionale, di impaginazione, di stampa. Esaminare qualche numero per credere. Non per niente la collezione la si studia nelle scuole migliori di questo nostro mestiere. Ma Signal (fino a tre milioni di copie in una dozzina di lingue, per sei anni, sino alla fine), a differenza del Reader’s Digest, che pagavamo, costava una cifra al Ministerium für Propaganda di quel simpaticone di Joseph dottor Goebbels.
Sto divagando, mi capita spesso. In realtà volevo dire, semplicemente, che non ho scordato due rubriche fondanti, due pilastri di quella melensa Selezione: Una persona che non dimenticherò mai e Il più bel giorno della mia vita. Quest’ultimo, per quel che mi riguarda, fu il giorno della laurea. Sbrigatomi con l’ultimo adempimento, la discussione della tesi, me ne uscii fischiettando dal grigio palazzotto sabaudo. Era grigio anche il cielo sopra Torino, ma il cuore scampanava a festa: avevo pagato il ticket d’ingresso alla vita e, finalmente, non sarei stato più costretto a studiare quanto interessava non a me, ma a un professore, per quanto illustre. Nessuno mi avrebbe più obbligato a seguire non le mie, ma le sue letture, i suoi progetti, le sue piste di ricerca. Il sollievo era tale che mi proposi di dedicare la vita alla carta stampata – mia e di altri – senza mettere più piede in una scuola, soprattutto se universitaria. Proposito, almeno questo, mantenuto.
Ebbene: accettare di stendere una prefazione non è, in fondo, rientrare nell’incubo scolastico, costringerti a prendere in mano, addirittura a studiare, un libro propostoti da altri?
Ma poi. Se l’autore è prestigioso e l’opera importante, presentarlo rischia di farti passare per parassita, per opportunista che si mette al traino del prestigio e dell’operosità di altri. Se, al contrario, pagine e autore valgono poco, nessuno ti risparmierà il sospetto di dilapidare quel po’ di autorevolezza che potresti avere per chissà quali inciuci, nepotismi, mafie, ricatti. Ci sarà pure un motivo inconfessabile ed occulto, se ti sei ridotto a far da paraculo a un simile mediocre.
Comunque sia, eccomi qua, a conferma che la coerenza è disumana e che (come insegnavano i benemeriti probabilisti barocchi della Compagnia di Gesù) è della condizione umana non essere coerenti a propositi e princìpi. Questi vanno sempre proclamati, mai però dimenticando che caro infirma est. Dunque, comprensione e perdono para todos. Eccomi qua, dunque, a “prefare” queste pagine di Stefano Lorenzetto. Rischiando, in questo caso, di passar per parassita od opportunista che approfitta dell’eccellenza altrui. In effetti, tanto per venire subito al sodo: il libro è buono; è molto buono. E non temo sospetti di adulazione, ho una prova ineccepibile di sincerità.
Ho chiesto al collega, difatti, di aiutarmi nel compito che – contradditoriamente – mi ero assunto, inviandomi quanto di significativo fosse stato scritto su di lui. Ho ricevuto un faldone elettronico imponente, dove ho avuto conferma, tra l’altro, di premi come il Saint Vincent e l’Estense: la cupola, i Pulitzer del giornalismo nostrano. Ho letto, con sotto firme prestigiose, sentenze come la seguente: «Lorenzetto produce arte sotto forma di giornalismo» (o, in una versione preferita da un altro recensore: «In lui il giornalismo confina con l’arte»). Dappertutto, tracimava la stima. Mentre scorrevo ammirato, un soprassalto. C’ero anch’io, tra quei tanti. Ma sì, la mia firma stava sotto la seguente frasetta: «L’ottimo Lorenzetto (le sue paginate di Tipi italiani me le centèllino)».
Non ricordavo, confesso, in che occasione o su quale giornale avessi detto o scritto quelle parole. Chiarii, poi, che stavano in una lettera che, nel 2001, inviai a Il Giornale. Ma appurare la fonte non era importante, visto che quella riga non è apocrifa, mi ci riconosco ancora; e non ho da pentirmene. Anzi, posso confermarla con maggior convinzione, visto che nel frattempo si sono succeduti, implacabili, i colloqui-paginone di Lorenzetto; ed io ho continuato a centellinare.
A stornare ancor più il sospetto, si precisa che il veronese autore e l’emilian-piemontese prefatore non sono amici, nel senso che – pur se sembrerà strano – non si sono mai frequentati, non fanno parte del cerchio consueto di sodali di redazione, di ristorante, di case al mare. Non partecipano, insomma, di quella colleganza che si fa camarilla e che porta a sorreggersi professionalmente, scambiandosi complimenti, recensioni, premi, nel nome (umanissimo anche questo, sia chiaro e, dunque, non condannabile) del do ut des. Sin qui, il nostro incontro è stato sempre e solo a livello di lettura reciproca, all’insaputa l’uno dell’altro, visto che mai ci siamo scambiati pareri sul rispettivo lavoro. Dunque, niente combine, niente amici degli amici.
La mia ammirazione per l’ars intervistatoria del Lorenzetto (sembra il nome di un pittore del Cinquecento veneziano, l’articolo “il” viene spontaneo per questo pennellatore di parole) è un’ammirazione da “tecnico”. È da uomo del mestiere quale sono – non so fare niente altro; e poi, si sa, è sempre meglio che lavorare – che cerca di spiegare ai ragazzotti e alle ragazzotte con registratore, taccuino, microfono che spesso lo tormentano, che l’intervista è un punto di arrivo della professione; non può, non deve essere un punto di partenza. Incapaci, temo, di strutturare un articolo come Dio e lettore comandano, pensano – quegli sbarbati – di cavarsela sbobinando da nastri o ribattendo letteralmente dagli appunti scarabocchiati.
In realtà, ciò che conta, nell’intervista, non sono le risposte (tutti sono capaci di bofonchiare qualcosa) ma le domande: è per domandare, non per rispondere, che ci vuole talento. E che bisogna far fatica. La fatica di sapere tutto, o almeno molto, dell’interlocutore da affrontare e su questa conoscenza modulare la griglia dei quesiti. Conservando, al contempo, il dono, o l’astuzia, della sorpresa e della scoperta da comunicare al lettore. Talento, fatica, studio. E umiltà. Quella di chi sa restare strumento a servizio delle piccole o grandi cose che l’intervistato può comunicare; e a servizio di chi investe soldi e tempo per leggere quelle righe e non gli interessa – in quella sede, almeno – che ne pensino il Lorenzetto o il Messori, bensì i loro interlocutori. Le domande che superano le poche, pochissime righe sono da principiante o da dilettante; o da egocentrico, che approfitta dell’occasione per intervistare se stesso; o da pigro, che non si è documentato e va sul generico e l’universale; o da insicuro che si blinda di parole.
Ma l’intervistatore ideale è anche educato, rispetta chi ha di fronte, rifugge dall’aggressività, diffida (o ride) del giornalista citoyen, quello che si indigna, che milita, che provoca, che moraleggia. Dio ci scampi dal periodismo di denuncia: garantisce chi, come me, lavorava nelle redazioni nei cupi Settanta, quando “er collega de sinistra”, quasi sempre un cronista del defunto Paese Sera, era uno stereotipo invariabilmente presente nei film engagés. I colloqui più esplosivi, devastanti – o, almeno, interessanti – ci sono offerti da chi sa indurre alla confidenza, addirittura alla confessione; dall’intervistatore mite, comprensivo, sottotono, magari un pizzico bonario. In apparenza, naturalmente. Nella realtà, le unghie più pericolose sono quelle dei felini, che le nascondono sotto l’aspetto di innocue, simpatiche babbucce. Lo sventurato rispose... E sono in tanti, per fortuna dei lettori, ad essere cascati nel trappolone di chi si presenta come un amico comprensivo, uno che potrebbe persino spacciarsi come un veneto un po’ dialettale e polentone, con il quale si può liberamente chiacchierare.
Se queste sono le virtù dell’intervistatore verace, del giornalista che sa stare al mondo, credo si possa dire – con oggettività – che queste virtù Lorenzetto le possiede. Del resto, non lo dico io, lo dice ciò che ha fatto e che ogni giorno fa, bulinando e cesellando i resoconti dei suoi incontri. Carta canta. Non canta un’amicizia un po’ mafiosa. Chi non è convinto, analizzi la tecnica e veda la “resa” giornalistica delle innumerevoli paginate-colloquio del Nostro.
Ma, per venire finalmente al libro che il lettore ha tra le mani. Qui c’è Stefano Lorenzetto che scrive in proprio, senza nascondersi dietro a interlocutori, c’è il giornalista che legge uno sconquasso di giornali (mi dicono una quindicina, solo di quotidiani), che accende la televisione, che si guarda attorno. E che riflette, commenta, opina, proponendoci il suo “secondo me”. Quasi ogni medium ha un signore di questo tipo. La categoria degli specialisti in varia umanità, in critica di costume, in corsivi, in elzeviri è inflazionata, così come lo è quella degli intervistatori. Il rubrichista, il corsivista, il commentatore, l’opinionista è, in fondo, un cannibale, forse anche un po’ parassita: è il giornalista che al mattino mangia giornali; e la digestione consiste nel darci il suo parere il mattino dopo.
Ma, pure tra questa turba, c’è – come sempre – il grano e c’è la paglia; c’è la farina e c’è la crusca. E, anche qui, il Nostro mi sembra far parte della prima categoria. Sembro ruffiano, lo so; e invece sono, ancora una volta, oggettivo. In effetti parlo, lo ripeto, da scriba di lungo corso; da chi, ormai vecchio – di anagrafe e di tessera dell’Ordine – sa che cosa dice. So bene, dunque, per esperienza annosa, che significhi fare una serie di interviste e, da esse, trarre dei libri. Ma so anche che significhi tenere un rubrica (una, sul quotidiano cattolico, mi spinsi a pubblicarla ben tre volte la settimana, per anni), so che significhi scrivere un corsivo, uno sfogo, un ritratto, un commento, un’opinione. Ho l’occhio logoro nel soppesare chi ha fatto e fa il mio stesso lavoro.
Se qui mi confermo nel giudizio di una qualità singolare, ci sono dei buoni motivi. Innanzitutto, quell’opinionista vulgaris (nel senso latino, s’intende...) che dicevamo è di bocca buona: gli bastano le notizie che trova in pagina e – pur sapendo bene quali siano le imprecisioni, le deformazioni, magari le faziosità delle redazioni – le commenta come fossero autentiche o, almeno, precise, così come sono pubblicate. La sua indolenza, poi, si spinge spesso al punto di non dargli neanche la voglia di aprire una qualche garzantina per controllare qualcosa.
È una pigrizia, è una superficialità che non affliggono di certo il Lorenzetto. La notizia su cui vuole dire la sua è per lui un punto di partenza per scavi sorprendenti: c’è da restare ammirati dallo scialo di cifre precise, di fatti correlati, di nomi verificati. È uno che, per dire, se si propone di parlare di “ecomostri”, approfitta di un viaggio lungo la costiera adriatica per contare quanti, e dove, siano gli edifici più alti di dieci piani. Se qualcuno pubblica che un manager sadomaso ha il vizietto di legare la segretaria al computer con una cravatta, ne misura una standard, accerta che è lunga solo 148 centimetri e che, dunque, l’erotica manovra è impraticabile. Se un moralista politically correct dice il suo sprezzo per chi appare in tv, soprattutto in tempi berlusconiani, Lorenzetto si irrita ma non fa come il corsivista normale, contrapponendo parole a parole. No, il nostro va a controllare (e non so proprio come abbia fatto), si procura tabulati ed elenchi, ricostruisce un calendario e, alla fine, sciorina una lista precisa delle comparsate catodiche praticate dallo sdegnoso collega predicatore. Se vuol parlare di francobolli si fa filatelico, prima di mettersi alla tastiera si costruisce una piccola ma puntuale cultura in proposito. Vuol prendersela con gli applausi alle casse da morto? Eccolo darsi a una ricerca di archivio per stabilire dove e quando risuonarono i primi battimani a un funerale. Deve riempire un lemma in cui parla del furto e gli vien comodo tirare in ballo San Tommaso d’Aquino? Qui, stupisce anche quel piccolo specialista che dovrei essere io stesso, dopo tanti anni di frequentazione di simili temi: ecco il nostro “tuttologo” trovare le citazioni giuste nelle molte Summae dell’Aquinate e applicarle in modo preciso ad appoggio della sua tesi.
Insomma, non c’è nulla della sciatteria pigra del commentatore che non leva il sedere dalla sedia, che se la cava con un repertorio di battute, che mescola sdegno e sarcasmo, che frigge – quasi fossero leccornie – parole imprecise nell’olio di altre parole altrettanto imprecise. C’è in Lorenzetto una curiosità di approfondire, di controllare, di parlare solo su dati e fatti precisi che dovrebbe essere di ogni gazzettiere e che gli dà una serietà che manca ai tanti colleghi che si misurano con quel nulla che è, troppo spesso, la “critica di costume”.
Ma c’è anche, qui, qualcosa di insolito per un genere che è tentato sempre dal moralismo. E sappiamo bene, noialtri della corporazione, da quali pulpiti vengano le prediche e le melasse “etiche”. Il Nostro non cade nella trappola, addita senza lagne e senza cattiverie, è lontano dai veleni del dottrinario alla giacobina che (lo osservava quel Tocqueville che praticavo anche quando era ben lontano dall’essere di moda) è sempre pronto a drammatizzare la piccola contingenza socio-politica e a demonizzare chi cade sotto la sua penna. Lorenzetto è di scuola veronese: c’è, nel veneto – intriso di un cattolicesimo solido e al contempo sanamente parrocchiale, alla San Pio X – un fondo di dolcezza naturale, di comprensione, di realismo cristiano che porta alla tolleranza e al rifiuto di trasformare in veleni mortali le spezie doverose della polemica. Una scuola, la veneta, ben lontana dalla toscana e dalla piemontese e che mi ha sempre ricordato quella emiliana, in particolare parmigiana, altrettanto umana e altrettanto affollata di geni e geniacci del giornalismo.
A proposito. Forse, l’impressione è solo personale: ma mi è sembrato di auscultare qualcosa che ho amato, in certi accenti dove lo stilettare di Lorenzetto non riesce a nascondere la bonarietà di fondo, in certo suo gusto di un umorismo salace e al contempo comprensivo, non maligno. Quel “qualcosa” è il ricordo di letture che furono tra quelle che segnarono la mia adolescenza: sono lo Zibaldino, innanzitutto; e, poi, Il destino si chiama Clotilde, La scoperta di Milano. Oltre, naturalmente, alla saga di Mondo piccolo. Ma sì, Giovannino Guareschi, quel grande parmigiano che so essere caro anche a questo veronese, pronto egli pure a fuggire da Milano per guardare il mondo dal nido caldo del suo paese. Guareschiane mi sembrano anche certe idiosincrasie curiose, certi rifiuti umorali, come l’avversione per gli anelli in dita maschili o per determinati tic ed espressioni linguistiche.
Poiché bisogna pur finire, una parola sul titolo. Il “buon senso” che spicca in copertina mi sembra adeguato a indicare il contenuto di un libro scritto da un uomo pragmatico, che rifugge dalle ideologie; da un moderato che non sa che farsene degli estremismi; da un giornalista pur colto, che ride delle astrattezze di tanti intellettuali; da un credente (spero di poterlo azzardare, senza violare una doverosa intimità) che sa che dono della fede è un realismo che impedisce di cadere nelle trappole dialettiche del “mondo”.
Il “buon senso” – il common sense degli anglosassoni, del mio venerato John Henry Newman – non è che il volto umile, quotidiano, di una ragione che, se non abusata e manipolata all’uso razionalista, sa farci distinguere ancora tra bene e male, tra umano e disumano. Che è ciò di cui abbiamo più bisogno, inquinati come siamo dalla nuova inquisizione, dal dogmatismo farisaico e feroce – dietro il volto suadente – della “correttezza politica”. Per questo, questo Dizionario mi sembra un atto di resistenza di cui noi, cultori coriacei del buon senso, dovremmo essere almeno un poco grati.
Vittorio Messori
© et-et.it | 2001-2006
Si, il dialogo può ricominciare da Maria
Corriere della Sera, 15 giugno 2006.
Si, il dialogo può ricominciare da Maria
di Vittorio Messori
L’attuale cultura “ufficiale“ sembra incapace –malgrado l’impegno e la buona volontà- di instaurare non si dice un dialogo, ma anche solo una convivenza meno conflittuale con il mondo musulmano. Questo mondo per il quale la religione non è, come in Occidente, una scelta personale (per giunta, sempre meno praticata) ma è la base che regge e dà forma non solo alla vita del singolo ma a quella di tutta la comunità. L’approccio “laico“ di europei ed americani, il loro rifarsi a categorie politiche, economiche o anche solo meramente “culturali“, non provoca accettazione ma rifiuto in un blocco islamico per il quale tutto deve rifarsi a una prospettiva teologica. Per la Umma, la comunità dei credenti, Dio “si è fatto carta“, la carta di al Quràn, che raccoglie il codice immutabile dettato a Muhammad e al quale ogni secolo e popolo deve obbedienza.
Per questo mi sembrano davvero preziose le parole di Magdi Allam ai 60mila partecipanti del pellegrinaggio notturno da Macerata a Loreto . Sono parole fuori dal coro degli auspici impotenti di agnostici, atei, “laici“ in genere, convinti che la religione sia un hobby privato se non una sovrastruttura ormai in disgregazione. L’egiziano che, per rifarsi al titolo del suo libro, “ama l’Italia“ forse più di molti italiani, ha addirittura lanciato un appello scandaloso o, almeno, incomprensibile per una certa intellighenzia: “Musulmani italiani, fratelli miei, facciamo del culto di Maria un momento unificante con i cristiani e del pellegrinaggio a Loreto e in ogni altro santuario dedicato a Lei un momento di condivisione e di fratellanza tra le persone di buona volontà“.
Allam ha ricordato ciò che molti cristiani hanno ormai dimenticato e che, in ogni caso, lascia indifferente la loro cecità a ciò che muove davvero le masse. Il Corano dedica alla Madre di Gesù un’intera Sura, ne fa il nome venerato per quaranta volte, l’innalza sino al fianco di Fatima, la figlia prediletta del Profeta, le affida un ruolo di maternità misericordiosa, ne difende l’onore contro gli ebrei che la diffamano (la “calunnia mostruosa“ sulla sua verginità che provocherà “il castigo di Dio“ e “l’ira dei credenti“ contro Israele, dice il Testo sacro). Tutta la Tradizione islamica successiva non ha fatto che esaltare la “Signora Maria“, come la chiamano. Chi, in ambiente cristiano, la bestemmi è considerato, al massimo, un maleducato. Chi osasse farlo tra musulmani, chi ne mettesse in dubbio la purezza perpetua, rischierebbe il linciaggio sul posto da parte della folla inferocita.
Il vicedirettore di questo giornale ha ricordato ciò che tanti nostri “esperti“ ignorano o non sanno valutare: proprio i santuari mariani sono, in terra d’Islam, i luoghi d’incontro tra cristiani e musulmani. Gesù è venerato ma solo come penultimo dei profeti, come annunciatore di quello definitivo, Muhammad. Al rispetto per il Nazareno si accompagna non solo la venerazione ma anche l’amore appassionato per la Madre. A partire dalla Pasqua del 1968 una Donna biancovestita apparve sulla cupola della chiesa copta di Zeitoun, un sobborgo del Cairo. Furono operai musulmani che la scorsero per primi. Accorsero subito le folle a recitare, prostrate, i versetti coranici che esaltano Maria e ad acclamare la Sempre Vergine che –secondo la tradizione– proprio a Zeitoun si era riposata, fuggendo in Egitto con il Figlio e con Giuseppe. Per molte notti la Signora si mostrò, luminosa e circondata di colombe bianche, alle masse che giungevano ormai da tutto il Paese, guidate dai loro imam. Se il Patriarca copto –in accordo con quello cattolico– dichiarò ufficialmente che era proprio la Madonna ad apparire fu anche per la pressione entusiasta dei musulmani che già da sempre frequentavano santuari come quello del monte Al Tir, altro luogo di sosta per la Sacra Famiglia.
Magdi Allam ha ricordato un aspetto importante, eppure per molti insospettabile: tra i modi per cercare di evitare il disastroso “scontro di civiltà“ c’è la riscoperta di questo “luogo d’incontro“ che è la persona della Vergine. E’ anche questa, forse, una delle ironie della storia: certi laicissimi politologi, certi autorevoli commentatori, certi onniscienti analisti dovranno far posto, nelle loro biblioteche, a testi di sinora irrisa devozione mariana e dovranno pellegrinare per santuari dove croce e mezzaluna pacificamente s’incrociano.
Si, il dialogo può ricominciare da Maria
di Vittorio Messori
L’attuale cultura “ufficiale“ sembra incapace –malgrado l’impegno e la buona volontà- di instaurare non si dice un dialogo, ma anche solo una convivenza meno conflittuale con il mondo musulmano. Questo mondo per il quale la religione non è, come in Occidente, una scelta personale (per giunta, sempre meno praticata) ma è la base che regge e dà forma non solo alla vita del singolo ma a quella di tutta la comunità. L’approccio “laico“ di europei ed americani, il loro rifarsi a categorie politiche, economiche o anche solo meramente “culturali“, non provoca accettazione ma rifiuto in un blocco islamico per il quale tutto deve rifarsi a una prospettiva teologica. Per la Umma, la comunità dei credenti, Dio “si è fatto carta“, la carta di al Quràn, che raccoglie il codice immutabile dettato a Muhammad e al quale ogni secolo e popolo deve obbedienza.
Per questo mi sembrano davvero preziose le parole di Magdi Allam ai 60mila partecipanti del pellegrinaggio notturno da Macerata a Loreto . Sono parole fuori dal coro degli auspici impotenti di agnostici, atei, “laici“ in genere, convinti che la religione sia un hobby privato se non una sovrastruttura ormai in disgregazione. L’egiziano che, per rifarsi al titolo del suo libro, “ama l’Italia“ forse più di molti italiani, ha addirittura lanciato un appello scandaloso o, almeno, incomprensibile per una certa intellighenzia: “Musulmani italiani, fratelli miei, facciamo del culto di Maria un momento unificante con i cristiani e del pellegrinaggio a Loreto e in ogni altro santuario dedicato a Lei un momento di condivisione e di fratellanza tra le persone di buona volontà“.
Allam ha ricordato ciò che molti cristiani hanno ormai dimenticato e che, in ogni caso, lascia indifferente la loro cecità a ciò che muove davvero le masse. Il Corano dedica alla Madre di Gesù un’intera Sura, ne fa il nome venerato per quaranta volte, l’innalza sino al fianco di Fatima, la figlia prediletta del Profeta, le affida un ruolo di maternità misericordiosa, ne difende l’onore contro gli ebrei che la diffamano (la “calunnia mostruosa“ sulla sua verginità che provocherà “il castigo di Dio“ e “l’ira dei credenti“ contro Israele, dice il Testo sacro). Tutta la Tradizione islamica successiva non ha fatto che esaltare la “Signora Maria“, come la chiamano. Chi, in ambiente cristiano, la bestemmi è considerato, al massimo, un maleducato. Chi osasse farlo tra musulmani, chi ne mettesse in dubbio la purezza perpetua, rischierebbe il linciaggio sul posto da parte della folla inferocita.
Il vicedirettore di questo giornale ha ricordato ciò che tanti nostri “esperti“ ignorano o non sanno valutare: proprio i santuari mariani sono, in terra d’Islam, i luoghi d’incontro tra cristiani e musulmani. Gesù è venerato ma solo come penultimo dei profeti, come annunciatore di quello definitivo, Muhammad. Al rispetto per il Nazareno si accompagna non solo la venerazione ma anche l’amore appassionato per la Madre. A partire dalla Pasqua del 1968 una Donna biancovestita apparve sulla cupola della chiesa copta di Zeitoun, un sobborgo del Cairo. Furono operai musulmani che la scorsero per primi. Accorsero subito le folle a recitare, prostrate, i versetti coranici che esaltano Maria e ad acclamare la Sempre Vergine che –secondo la tradizione– proprio a Zeitoun si era riposata, fuggendo in Egitto con il Figlio e con Giuseppe. Per molte notti la Signora si mostrò, luminosa e circondata di colombe bianche, alle masse che giungevano ormai da tutto il Paese, guidate dai loro imam. Se il Patriarca copto –in accordo con quello cattolico– dichiarò ufficialmente che era proprio la Madonna ad apparire fu anche per la pressione entusiasta dei musulmani che già da sempre frequentavano santuari come quello del monte Al Tir, altro luogo di sosta per la Sacra Famiglia.
Magdi Allam ha ricordato un aspetto importante, eppure per molti insospettabile: tra i modi per cercare di evitare il disastroso “scontro di civiltà“ c’è la riscoperta di questo “luogo d’incontro“ che è la persona della Vergine. E’ anche questa, forse, una delle ironie della storia: certi laicissimi politologi, certi autorevoli commentatori, certi onniscienti analisti dovranno far posto, nelle loro biblioteche, a testi di sinora irrisa devozione mariana e dovranno pellegrinare per santuari dove croce e mezzaluna pacificamente s’incrociano.
giovedì 10 agosto 2006
Ahmadinejad vuole l'apocalisse
Dal FOGLIO del 9 agosto 2006, un articolo di Bernard Lewis ripreso da MILANO FINANZA e sal Wall Street Journal.
Ecco il testo:
Durante la Guerra fredda, entrambi gli schieramenti possedevano armi di distruzione di massa, ma nessuno dei due le ha usate, perché trattenuti da ciò che si definiva il Mad (“mutual assured destruction”), la sicurezza della reciproca distruzione. La stessa cosa ha senza dubbio impedito il loro utilizzo nel conflitto tra India e Pakistan. Oggi sembra incombere un nuovo scontro tra un Iran dotato di armi nucleari e i suoi grandi nemici, definiti dal defunto ayatollah Khomeini il “Grande Satana” e il “Piccolo Satana”, ossia gli Stati Uniti e Israele. Contro gli Stati Uniti, un attacco nucleare potrebbe essere compiuto con un’azione terroristica, metodo che ha il vantaggio di mantenere nascosta l’identità del mandante. Contro Israele, l’obiettivo è sufficientemente piccolo e vicino da consentire il tentativo di una distruzione totale con un bombardamento diretto. Appare sempre più probabile che gli iraniani hanno o avranno molto presto a disposizione armi nucleari, grazie ai loro programmi di ricerca iniziati circa quindici anni fa, all’aiuto di alcuni vicini compiacenti e a quello dei dittatori della Corea del nord. Il linguaggio impiegato dal presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, sembra dimostrare la realtà e l’imminenza di questa minaccia. Il timore della reciproca distruzione riuscirà a trattenere l’Iran dall’usare le proprie armi nucleari contro gli Stati Uniti o contro Israele? C’è una differenza sostanziale tra la Repubblica islamica dell’Iran e altri paesi che possiedono armi nucleari: la concezione apocalittica che caratterizza la visione del mondo degli attuali governanti dell’Iran. Questa concezione, espressa in discorsi, articoli e persino manuali scolastici, influenza le posizioni e le politiche di Ahmadinejad e dei suoi seguaci. Già in passato è apparso chiaro come i terroristi che proclamano di agire in nome dell’islam non si facciano alcuno scrupolo a massacrare altri musulmani. Un esempio illuminante è offerto dall’attentato contro le ambasciate americane in Africa orientale nel 1998, nel quale sono morti pochi diplomatici americani ma un elevato numero di passanti innocenti, molti dei quali musulmani. Nei numerosi attentati terroristici compiuti negli ultimi 15 anni sono morti moltissimi musulmani. La frase “Allah riconoscerà i suoi” è generalmente usata per spiegare questo apparentemente crudele atteggiamento. Significa che, mentre gli infedeli ossia i non musulmani) finiranno giustamente all’inferno, i musulmani saranno spediti direttamente in paradiso. La ricompensa senza la fatica del martirio Secondo questa concezione, gli attentatori stanno in realtà facendo un favore alle loro vittime musulmane, facendo prendere loro una scorciatoia per il paradiso e le sue delizie: la ricompensa senza la fatica del martirio. I manuali scolastici iraniani insegnano ai giovani studenti a essere pronti per uno scontro finale globale contro un malvagio nemico, gli Stati Uniti, e di prepararsi ai privilegi del martirio. Un attacco diretto contro l’America, sebbene possibile, è meno probabile nell’immediato futuro. Israele è un obiettivo più vicino e più facile, e Ahmadinejad ha già dimostrato di vederla proprio in questo modo. Gli osservatori occidentali penserebbero immediatamente a due possibili forme di deterrenza. La prima è il fatto che un attacco che spazzasse via Israele distruggerebbe anche i palestinesi. La seconda è che un tale attacco scatenerebbe una devastante rappresaglia da parte di Israele, poiché si può ritenere certo che gli israeliani abbiano già preso tutte le misure necessarie per poter contrattaccare anche nel caso di un olocausto nucleare in Israele. La prima di queste due forme di deterrenza potrebbe avere effetto con i palestinesi, ma non con i loro fanatici sostenitori del governo iraniano. La seconda, ossia la minaccia di una rappresaglia diretta contro l’Iran, è neutralizzata dall’ideologia del suicidio e del martirio che domina oggi in alcune parti del mondo islamico: un fenomeno che non ha paralleli nelle altre religioni e nemmeno nel passato islamico. Oggi questa ideologia è diventata ancora più forte perché si è legata a una visione apocalittica. Nella religione islamica, come anche nel giudaismo e nel cristianesimo, ci sono alcune credenze che riguardano il conflitto cosmico che si aprirà alla fine dei tempi: Gog e Magog, l’anticristo, Armageddon (per musulmani sciiti, il ritorno dell’imam nascosto); questo conflitto si concluderà con la vittoria delle forze del bene sulle forze del male. Ahmadinejad e i suoi seguaci sono convinti che il momento del conflitto finale sia arrivato, anzi che lo stesso conflitto sia già iniziato. Forse possiamo persino sapere la data, suggerita da numerosi riferimenti fatti dal presidente iraniano a proposito della risposta finale che darà il 22 agosto sullo sviluppo del programma nucleare iraniano. Quale significato ha la data del 22 agosto? Quest’anno, il 22 agosto corrisponde nel calendario islamico al ventisettesimo giorno del mese di Rajab dell’anno 1427. Questa, secondo la tradizione, è la notte in cui i musulmani commemorano il volo notturno del profeta Maometto sulle ali del cavallo Buraq, prima alla “moschea più lontana” (normalmente identificata con Gerusalemme) e poi al paradiso (cfr. Corano XVII, 1). Questa potrebbe essere considerata la data più appropriata per la fine apocalittica di Israele e se necessario del mondo intero. Non è affatto certo che il presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, abbia in mente di scatenare un simile cataclisma proprio il 22 agosto. Ma sarebbe saggio tenere presente questa possibilità. Una frase dell’ayatollah Khomeini, citata sui manuali delle scuole superiori iraniane, è rivelatrice: “Annuncio a tutto il mondo che se i divoratori del mondo (cioè le potenze infedeli, nda) intendono ostacolare la nostra religione, noi ci schiereremo contro tutto il mondo e non ci fermeremo fino a quando non l’avremo distrutto. O diventiamo tutti liberi, oppure procederemo verso la più grande libertà che è offerta dal martirio. In entrambi i casi, la vittoria e il successo sono assicurati”. In un simile contesto, il deterrente che ha funzionato così bene durante la guerra fredda, quello della distruzione reciproca, non servirebbe a niente. Alla fine dei tempi, ci sarà in ogni caso la distruzione generale. Ciò che contà sarà la destinazione: l’inferno per gli infedeli e il paradiso per i credenti. Per chi ha una simile visione del mondo, la sicurezza della reciproca distruzione non è un deterrente. Anzi, è uno stimolo. Come si può affrontare un tale nemico, con una simile concezione della vita e della morte? Alcune precauzioni immediate sono ovviamente possibili e necessarie. Nel lungo termine, sembrerebbe che la migliore e forse la unica speranza rimasta sia quella di fare leva su tutti i musulmani, iraniani, arabi e di altri paesi che non condividono questa visione apocalittica; che piuttosto si sentono minacciati, almeno e probabilmente, ancora più di noi stessi. Ce ne devono essere molti nelle terre dell’islam, anzi forse sono la maggioranza. Per loro è giunto il momento di salvare il proprio paese, la propria società e la propria religione da questa follia. Bernard Lewis © Wall Street Journal per gentile concessione di Milano Finanza
Di seguito, un agenzia Ansa del 25 luglio 2006, su una possibile via di soluzione del terribile problema rappresentato dalla minaccia iraniana:
ANSA- Roma, 25 luglio- Un cambiamento democratico in Iran rappresenterebbe un passaggio importante per la soluzione della crisi Mediorientale e, allo stesso tempo, scongiurerebbe il rischio di un rovinoso confronto militare tra le potenze occidentali e il regime di Teheran. E' quanto emerge dalla conferenza "Iran: un anno dopo l'insediamento di Ahmadinejad, il programma atomico, la crisi regionale", alla quale hanno partecipato oggi parlamentari italiani dissidenti in esilio del Consiglio Nazionale per la Resistenza Iraniana( CNRI ).
Ecco il testo:
Durante la Guerra fredda, entrambi gli schieramenti possedevano armi di distruzione di massa, ma nessuno dei due le ha usate, perché trattenuti da ciò che si definiva il Mad (“mutual assured destruction”), la sicurezza della reciproca distruzione. La stessa cosa ha senza dubbio impedito il loro utilizzo nel conflitto tra India e Pakistan. Oggi sembra incombere un nuovo scontro tra un Iran dotato di armi nucleari e i suoi grandi nemici, definiti dal defunto ayatollah Khomeini il “Grande Satana” e il “Piccolo Satana”, ossia gli Stati Uniti e Israele. Contro gli Stati Uniti, un attacco nucleare potrebbe essere compiuto con un’azione terroristica, metodo che ha il vantaggio di mantenere nascosta l’identità del mandante. Contro Israele, l’obiettivo è sufficientemente piccolo e vicino da consentire il tentativo di una distruzione totale con un bombardamento diretto. Appare sempre più probabile che gli iraniani hanno o avranno molto presto a disposizione armi nucleari, grazie ai loro programmi di ricerca iniziati circa quindici anni fa, all’aiuto di alcuni vicini compiacenti e a quello dei dittatori della Corea del nord. Il linguaggio impiegato dal presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, sembra dimostrare la realtà e l’imminenza di questa minaccia. Il timore della reciproca distruzione riuscirà a trattenere l’Iran dall’usare le proprie armi nucleari contro gli Stati Uniti o contro Israele? C’è una differenza sostanziale tra la Repubblica islamica dell’Iran e altri paesi che possiedono armi nucleari: la concezione apocalittica che caratterizza la visione del mondo degli attuali governanti dell’Iran. Questa concezione, espressa in discorsi, articoli e persino manuali scolastici, influenza le posizioni e le politiche di Ahmadinejad e dei suoi seguaci. Già in passato è apparso chiaro come i terroristi che proclamano di agire in nome dell’islam non si facciano alcuno scrupolo a massacrare altri musulmani. Un esempio illuminante è offerto dall’attentato contro le ambasciate americane in Africa orientale nel 1998, nel quale sono morti pochi diplomatici americani ma un elevato numero di passanti innocenti, molti dei quali musulmani. Nei numerosi attentati terroristici compiuti negli ultimi 15 anni sono morti moltissimi musulmani. La frase “Allah riconoscerà i suoi” è generalmente usata per spiegare questo apparentemente crudele atteggiamento. Significa che, mentre gli infedeli ossia i non musulmani) finiranno giustamente all’inferno, i musulmani saranno spediti direttamente in paradiso. La ricompensa senza la fatica del martirio Secondo questa concezione, gli attentatori stanno in realtà facendo un favore alle loro vittime musulmane, facendo prendere loro una scorciatoia per il paradiso e le sue delizie: la ricompensa senza la fatica del martirio. I manuali scolastici iraniani insegnano ai giovani studenti a essere pronti per uno scontro finale globale contro un malvagio nemico, gli Stati Uniti, e di prepararsi ai privilegi del martirio. Un attacco diretto contro l’America, sebbene possibile, è meno probabile nell’immediato futuro. Israele è un obiettivo più vicino e più facile, e Ahmadinejad ha già dimostrato di vederla proprio in questo modo. Gli osservatori occidentali penserebbero immediatamente a due possibili forme di deterrenza. La prima è il fatto che un attacco che spazzasse via Israele distruggerebbe anche i palestinesi. La seconda è che un tale attacco scatenerebbe una devastante rappresaglia da parte di Israele, poiché si può ritenere certo che gli israeliani abbiano già preso tutte le misure necessarie per poter contrattaccare anche nel caso di un olocausto nucleare in Israele. La prima di queste due forme di deterrenza potrebbe avere effetto con i palestinesi, ma non con i loro fanatici sostenitori del governo iraniano. La seconda, ossia la minaccia di una rappresaglia diretta contro l’Iran, è neutralizzata dall’ideologia del suicidio e del martirio che domina oggi in alcune parti del mondo islamico: un fenomeno che non ha paralleli nelle altre religioni e nemmeno nel passato islamico. Oggi questa ideologia è diventata ancora più forte perché si è legata a una visione apocalittica. Nella religione islamica, come anche nel giudaismo e nel cristianesimo, ci sono alcune credenze che riguardano il conflitto cosmico che si aprirà alla fine dei tempi: Gog e Magog, l’anticristo, Armageddon (per musulmani sciiti, il ritorno dell’imam nascosto); questo conflitto si concluderà con la vittoria delle forze del bene sulle forze del male. Ahmadinejad e i suoi seguaci sono convinti che il momento del conflitto finale sia arrivato, anzi che lo stesso conflitto sia già iniziato. Forse possiamo persino sapere la data, suggerita da numerosi riferimenti fatti dal presidente iraniano a proposito della risposta finale che darà il 22 agosto sullo sviluppo del programma nucleare iraniano. Quale significato ha la data del 22 agosto? Quest’anno, il 22 agosto corrisponde nel calendario islamico al ventisettesimo giorno del mese di Rajab dell’anno 1427. Questa, secondo la tradizione, è la notte in cui i musulmani commemorano il volo notturno del profeta Maometto sulle ali del cavallo Buraq, prima alla “moschea più lontana” (normalmente identificata con Gerusalemme) e poi al paradiso (cfr. Corano XVII, 1). Questa potrebbe essere considerata la data più appropriata per la fine apocalittica di Israele e se necessario del mondo intero. Non è affatto certo che il presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, abbia in mente di scatenare un simile cataclisma proprio il 22 agosto. Ma sarebbe saggio tenere presente questa possibilità. Una frase dell’ayatollah Khomeini, citata sui manuali delle scuole superiori iraniane, è rivelatrice: “Annuncio a tutto il mondo che se i divoratori del mondo (cioè le potenze infedeli, nda) intendono ostacolare la nostra religione, noi ci schiereremo contro tutto il mondo e non ci fermeremo fino a quando non l’avremo distrutto. O diventiamo tutti liberi, oppure procederemo verso la più grande libertà che è offerta dal martirio. In entrambi i casi, la vittoria e il successo sono assicurati”. In un simile contesto, il deterrente che ha funzionato così bene durante la guerra fredda, quello della distruzione reciproca, non servirebbe a niente. Alla fine dei tempi, ci sarà in ogni caso la distruzione generale. Ciò che contà sarà la destinazione: l’inferno per gli infedeli e il paradiso per i credenti. Per chi ha una simile visione del mondo, la sicurezza della reciproca distruzione non è un deterrente. Anzi, è uno stimolo. Come si può affrontare un tale nemico, con una simile concezione della vita e della morte? Alcune precauzioni immediate sono ovviamente possibili e necessarie. Nel lungo termine, sembrerebbe che la migliore e forse la unica speranza rimasta sia quella di fare leva su tutti i musulmani, iraniani, arabi e di altri paesi che non condividono questa visione apocalittica; che piuttosto si sentono minacciati, almeno e probabilmente, ancora più di noi stessi. Ce ne devono essere molti nelle terre dell’islam, anzi forse sono la maggioranza. Per loro è giunto il momento di salvare il proprio paese, la propria società e la propria religione da questa follia. Bernard Lewis © Wall Street Journal per gentile concessione di Milano Finanza
Di seguito, un agenzia Ansa del 25 luglio 2006, su una possibile via di soluzione del terribile problema rappresentato dalla minaccia iraniana:
ANSA- Roma, 25 luglio- Un cambiamento democratico in Iran rappresenterebbe un passaggio importante per la soluzione della crisi Mediorientale e, allo stesso tempo, scongiurerebbe il rischio di un rovinoso confronto militare tra le potenze occidentali e il regime di Teheran. E' quanto emerge dalla conferenza "Iran: un anno dopo l'insediamento di Ahmadinejad, il programma atomico, la crisi regionale", alla quale hanno partecipato oggi parlamentari italiani dissidenti in esilio del Consiglio Nazionale per la Resistenza Iraniana( CNRI ).
Il mistero dell'esistenza umana
Il Vangelo e la vita sociale degli uomini
La voce del Vescovo
di mons. Girolamo Grillo, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia
Agosto 2006
Tratto dal sito della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia
Una delle tante questioni solitamente dibattute in molte rubriche televisive ed anche in altri strumenti di comunicazione di massa è la ricerca della felicità.
Alla domanda: “ma perché mai tanta gente si parte da lontano continuamente durante i cosiddetti “ponti settimanali” e nei vari periodi di ferie (corte o lunghe)? “in cerca di che cosa?” “E perché mai, pur non avendo a disposizione adeguate disponibilità finanziaria, quasi tutta programmano vacanze all’estero e, magari, nelle isole più lontane dei mari tropicali”? La risposta è quasi sempre identica: “si va in cerca di un po’ di felicità”.
Ovviamente c’è anche chi, invece della ricerca della felicità, parla di un po’ di riposo o di ricreazione a motivo della stanchezza causata dal lavoro. Sembra, però, che ad usare questo linguaggio siano, piuttosto, ben pochi.
Felicità è un nome magico, come una specie di “araba fenice”: “che vi sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa”. Ed allora, è soltanto un tentativo di evasione?
Probabilmente, la ragione di questa ricerca spasmodica della felicità, sempre insita, d’altronde, nel cuore dell’uomo ed anche, forse, incosciamente a motivo del “paradiso perduto”, va cercata nell’angoscia e nella paura causata dalle tante scene di morte propinate dai massmedia, le quali contraddicono il desiderio insopprimibile di vita che c’è dentro di noi.
Non sono poche le motivazioni di tal genere: i fratellini scoparsi a Gravina di Puglia, le sorelline violentate e uccise in Belgio, i numerosi casi di bambini e bambine scomparsi nel nulla, le cui immagini occupano quotidianamente lo specchio televisivo.
Mettiamo, poi, le tante disgrazie che si susseguono dappertutto, i crimini più efferati che, dalla mattina alla sera, ci vengono sbattuti sotto il muso: i figli che uccidono i genitori e viceversa, le creaturine abbandonate a marcire nei cassonetti della spazzatura, gli stupri a dismisura e sotto gli occhi di tutti, o i riti satanici e dell’orrore, le truffe dei maghi e delle maghette, le ragazze che fanno a gara per concedere le loro grazie e così via.
Chi potrà mai dimenticare l’episodio sconcertante delle tre ragazze che, per gioco, hanno ucciso a coltellate una suora? Per non parlare delle vittime del terrorismo, che aumentano di giorno in giorno.
Eppure, quanti hanno il coraggio di fermarsi qualche istante per riflettere sulle vere motivazioni di questi orrendi delitti e degli altri disordini morali?
Al più, quando tali ricordi si ripresentano alla nostra fantasia, si tende a rimuoverli psichicamente o a cambiare canale, se si ha in mano il telecomando.
E poi? E poi, ci si tuffa nella evasione: si cerca la felicità. Ma dove? In famiglia? Sotto il tetto coniugale secondo i canoni di un amore autentico? Neppure per sogno! Ci si allontana alla ricerca di avventure apparentemente piacevoli ed affascinanti. Poco importa il risultato che, alla fine dei conti, sfocia, quasi sempre, nel diletto effimero di qualche notte di mezza estate.
La visione che spesso ci si para davanti non è bella affatto. E’ veramente triste pensare che gran parte del mondo occidentale sia sulla scia del declino ed avviata verso una morte senza speranza.
Perché mai tutto questo? Si è convinti che, nonostante gli arzigogoli di alcuni intellettuali non credenti, l’affermazione di Dostojeewsckj: “Se Dio non c’è, allora tutto è possibile”, valga ancora e come.
L’uomo potrà anche illudersi di poter trovare la felicità girovagando per le strade più contorte, ma, con il rifiuto di Dio, ci si inebetisce unicamente rimanendo vittima delle più tremende delusioni.
Purtroppo, non è facile comprenderlo (sono pienamente d’accordo), ma è così!
La voce del Vescovo
di mons. Girolamo Grillo, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia
Agosto 2006
Tratto dal sito della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia
Una delle tante questioni solitamente dibattute in molte rubriche televisive ed anche in altri strumenti di comunicazione di massa è la ricerca della felicità.
Alla domanda: “ma perché mai tanta gente si parte da lontano continuamente durante i cosiddetti “ponti settimanali” e nei vari periodi di ferie (corte o lunghe)? “in cerca di che cosa?” “E perché mai, pur non avendo a disposizione adeguate disponibilità finanziaria, quasi tutta programmano vacanze all’estero e, magari, nelle isole più lontane dei mari tropicali”? La risposta è quasi sempre identica: “si va in cerca di un po’ di felicità”.
Ovviamente c’è anche chi, invece della ricerca della felicità, parla di un po’ di riposo o di ricreazione a motivo della stanchezza causata dal lavoro. Sembra, però, che ad usare questo linguaggio siano, piuttosto, ben pochi.
Felicità è un nome magico, come una specie di “araba fenice”: “che vi sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa”. Ed allora, è soltanto un tentativo di evasione?
Probabilmente, la ragione di questa ricerca spasmodica della felicità, sempre insita, d’altronde, nel cuore dell’uomo ed anche, forse, incosciamente a motivo del “paradiso perduto”, va cercata nell’angoscia e nella paura causata dalle tante scene di morte propinate dai massmedia, le quali contraddicono il desiderio insopprimibile di vita che c’è dentro di noi.
Non sono poche le motivazioni di tal genere: i fratellini scoparsi a Gravina di Puglia, le sorelline violentate e uccise in Belgio, i numerosi casi di bambini e bambine scomparsi nel nulla, le cui immagini occupano quotidianamente lo specchio televisivo.
Mettiamo, poi, le tante disgrazie che si susseguono dappertutto, i crimini più efferati che, dalla mattina alla sera, ci vengono sbattuti sotto il muso: i figli che uccidono i genitori e viceversa, le creaturine abbandonate a marcire nei cassonetti della spazzatura, gli stupri a dismisura e sotto gli occhi di tutti, o i riti satanici e dell’orrore, le truffe dei maghi e delle maghette, le ragazze che fanno a gara per concedere le loro grazie e così via.
Chi potrà mai dimenticare l’episodio sconcertante delle tre ragazze che, per gioco, hanno ucciso a coltellate una suora? Per non parlare delle vittime del terrorismo, che aumentano di giorno in giorno.
Eppure, quanti hanno il coraggio di fermarsi qualche istante per riflettere sulle vere motivazioni di questi orrendi delitti e degli altri disordini morali?
Al più, quando tali ricordi si ripresentano alla nostra fantasia, si tende a rimuoverli psichicamente o a cambiare canale, se si ha in mano il telecomando.
E poi? E poi, ci si tuffa nella evasione: si cerca la felicità. Ma dove? In famiglia? Sotto il tetto coniugale secondo i canoni di un amore autentico? Neppure per sogno! Ci si allontana alla ricerca di avventure apparentemente piacevoli ed affascinanti. Poco importa il risultato che, alla fine dei conti, sfocia, quasi sempre, nel diletto effimero di qualche notte di mezza estate.
La visione che spesso ci si para davanti non è bella affatto. E’ veramente triste pensare che gran parte del mondo occidentale sia sulla scia del declino ed avviata verso una morte senza speranza.
Perché mai tutto questo? Si è convinti che, nonostante gli arzigogoli di alcuni intellettuali non credenti, l’affermazione di Dostojeewsckj: “Se Dio non c’è, allora tutto è possibile”, valga ancora e come.
L’uomo potrà anche illudersi di poter trovare la felicità girovagando per le strade più contorte, ma, con il rifiuto di Dio, ci si inebetisce unicamente rimanendo vittima delle più tremende delusioni.
Purtroppo, non è facile comprenderlo (sono pienamente d’accordo), ma è così!
mercoledì 9 agosto 2006
Weigel spiega perché nel catechismo cattolico il sesso è preso più sul serio che su Playboy
Weigel spiega perché nel catechismo cattolico il sesso è preso più sul serio che su Playboy
di Giulio Meotti
Tratto da Il Foglio del 24 giugno 2006
E’ il racconto di un elezione pontificia che si trasforma, pagina dopo pagina, nel canovaccio letterario del pensiero di Benedetto XVI. L’ultimo libro di George Weigel, “God’s Choice” (che sarà tradotto anche in Italia) parla la lingua di un declino autentico e ha il dono di una stanchezza che annotta nella plasticità di un ratzingerismo aulico, patristico. Se il fanatismo, come diceva Emile Cioran, è la tara capitale che dà all’uomo il gusto dell’efficacia, della profezia e del terrore, Weigel brandisce una teologia del nitore antifanatico dallo spessore confortante e con una dignità figurativa innestata nella riflessione come la colonna vertebrale in un corpo, mantenendola dritta. Il suo humour senza brio, unito a una solitaria predilezione per la libertà, ricorda molto l’ansia visionaria di George Bernanos, che nel 1927 scrisse che “la nostra specie sarà lentamente corrosa come una trave da quei funghi invisibili che in poche settimane riducono un ceppo di quercia in una materia spugnosa che si sfalda sotto la pressione di un dito”. Leggendo Weigel si ha la stessa identica idea di sbriciolamento.
Direttore dell’Ethics and Public Policy Center, biografo acclamato di Karol Wojtyla e considerato il teologo più influente e ascoltato degli Stati Uniti, Weigel racconta al Foglio “l’anno di Benedetto”, il cui pensiero si traduce nell’idea che l’uomo non è un essere che progredisce, quanto l’essere che non è messo al sicuro da nessun progresso, ma che deve sempre, di continuo, scegliere fra bene e male. “In occidente è in corso una lotta per una domanda fondamentale: può la civiltà emersa dall’interazione di Gerusalemme, Atene e Roma sopravvivere a una prosperità, salute, longevità fisica, libertà e sicurezza senza precedenti? Ancora, può l’occidente mantenere in vita il proprio esperimento di autogoverno se diventa ciò che Zbigniew Brzezinski ha chiamato ‘la cornucopia permissiva’? L’abbondanza ha prodotto egotismo e prosperità, egoismo verso il futuro e incapacità di trarre le più elementari conclusioni morali sull’imperativo di resistere al male. Il cardinale Lehmann ha detto che ‘gli esseri umani non possono vivere nel silenzio’. Invece oggi gli uomini e le donne cercano di vivere ‘nel silenzio’, dimenticano come andare al di là di se stessi. Per questo, suggerisce Lehmann, l’Europa si sta spopolando”.
Per questo, aggiunge Weigel, la prima enciclica di Ratzinger, “Deus caritas est”, arriva “come un drink rinfrescante. Quando il salmista ci chiede di contare i nostri giorni, ci sta insegnando una grande verità. Nella grammatica di Ratzinger l’eros è un ‘esodo’. L’emozione oggi ha invece sostituito la ragione come arbitro del giudizio. Il nuovo Benedetto è un uomo convinto che le idee abbiano davvero conseguenze sul mondo e che le società umane non possano costruire le proprie fondamenta su falsi dèi. Il filosofo Charles Taylor ha coniato il termine ‘umanesimo esclusivistico’. Sono le tentazioni moderne del totalitarismo, di un paganesimo sposato alla tecnologia. Un Nuovo Medioevo sta per sorgere in quei laboratori dove la procreazione umana è trasformata in produzione umana”.
Medioevo tristemente illuminato dai successi seriali di una tecnoscienza che vive di quello che Ratzinger ha chiamato riduzionismo biologico. “Un fenomeno che è stato reso evidente da nazisti e comunisti, dai loro esperimenti medici sugli esseri umani, la ‘vita indegna di essere vissuta’. E’ la fabbrica di una società giusta. Fortunatamente sia la ragione sia la scienza sono dalla nostra parte nella difesa della vita dal concepimento alla morte. I manuali onesti di embriologia ci insegnano che il prodotto della creazione umana è un essere umano, non qualcosa che ‘diventerà’ un essere umano. La ragione poi ci spiega che niente che non è umano sarà umano e che niente di ciò che è umano sarà mai qualcos’altro. La domanda politica è se riconosceremo l’umanità dell’innegabile creatura e le offriremo protezione con le leggi. E se non lo faremo, cosa ci impedirà di dichiarare altre classi umane al di fuori della comunità degna di legalità? Gli handicappati? Le ‘bucce umane’? E’ genuina quella democrazia in cui i ‘sani’ hanno il ‘diritto’ di disporre dei ‘malati’?”. Una domanda talmente attuale che il professor Len Doyal dell’Università di Londra ha appena affermato che i medici dovrebbero poter “terminare” le vite anche di quei malati che non ne hanno fatto esplicita richiesta e che non possono più “decidere”.
“Henri de Lubac negli anni Quaranta aveva compreso che l’adorazione umanistica porta alla distruzione umana. E’ la manifattura biotecnica dell’humanum. Ho letto il ‘Nuovo Mondo’ di Aldous Huxley al liceo. Poi l’ho ripreso due estati fa. E’ pazzesco nel suo essere talmente attuale. Quando la manifattura sostituisce la generazione dei figli, la tentazione di una produzione di esseri umani diverrà irresistibile, la creazione di esseri umani inferiori. Siamo in grado già oggi di creare ‘bambini su misura’, che però non significherà mai un essere umano indipendente, ma la copia di un ‘io’, di un desiderio. Se siamo la sola misura di noi stessi, ‘io’ sono la sola misura di ‘me’. Ma il ‘me’ che mi rende una persona unica è più di un fagotto di neuroni. I falsi umanesimi hanno creato montagne di corpi e oceani di sangue, Auschwitz e il Gulag, aborti e manifattura in vitro. Questo è l’auto-cannibalismo della libertà. Un utilitarismo rinforzato da false nozioni di compassione e di hubrys scientifica”.
Il Papa ha parlato di coloro che “tratti in inganno dall’ateismo, ritengono e cercano di dimostrare che è scientifico pensare che tutto sia privo di guida e di ordine, come in balìa del caso”. “E’ pazzesco che così tante persone intelligenti, ammaliate dalla nozione che la fede religiosa sia intellettualmente soffocante, abbiano una convinzione fideistica per cui la complessità straordinaria del mondo naturale sia un caso fortunato, il prodotto di processi chimici cosmici. Questo mi colpisce sempre come qualcosa di incredibile. Sappiamo che la terra è tonda, ma viviamo spesso come se il mondo fosse piatto”.
Weigel ha un debito nei confronti del filosofo americano Alasdair MacIntyre, che più di vent’anni fa denunciò l’“emotivismo morale”. “L’emotivismo conduce a quello che Ratzinger chiama ‘la dittatura del relativismo’, relativismo imposto dal potere coercitivo della legge. MacIntyre aveva ragione nello scrivere che ‘se la tradizione della virtù è stata in grado di sopravvivere agli orrori dell’ultima età oscura, non siamo del tutto privi di fondamenti per la speranza. Questa volta, però, i barbari non aspettano di là dalle frontiere: ci hanno già governato per parecchio tempo’”.
La chiesa cattolica è coperta da una coltre di fumo ideologico che trasforma un divieto in capricco di magistero, anziché in quel principio di ragione non negoziabile basato su una radicale affermazione della capacità umana. “Il no cattolico alla concezione del matrimonio come transazione fra ‘adulti consenzienti’ è basato su un sì vecchio cinquemila anni. Il no alle tecnologie riproduttive è fondato sul sì alla dignità della persona umana e sul dramma di essere umani ridotti a oggetti commerciali. Uomo e donna, padre e madre sono letteralmente icone. E’ iconografico anche il prendere i voti del prete, è il linguaggio del corpo su cui è costruito. Un genio pirotecnico del moderno mondo cattolico, Hans Urs von Balthasar, ha detto che la chiesa è creata a immagine delle grandi figure del Nuovo Testamento. La chiesa dell’evangelizzazione a immagine di san Paolo, l’apostolo dei Gentili. La chiesa della contemplazione a immagine dell’apostolo Giovanni; quella dell’autorità a immagine di Pietro, al quale Cristo ha dato il potere delle chiavi. La divinizzazione dell’uomo è stata possibile grazie a quella che il cardinale Christoph Schönborn chiama l’umanizzazione di Dio. Oggi invece un orribile gnosticismo copre la società di una nebbia soffocante. Siamo finestre affacciate su verità profonde e la vita non è materia plastica, manipolabile e biodegradabile. L’obiettivo del nuovo gnosticismo è creare una società in cui, per la prima volta nella storia umana, ogni possibile rapporto sessuale diventa materia privata senza conseguenze per cultura, natura, legge, società. Un tempo la chiamavamo ‘decadenza’. Oggi si parla di ‘liberazione’. Ma il nuovo vocabolario non muta la sostanza delle cose. La chiesa insegna che l’amore nei confini del matrimonio è icona della vita interiore di Dio. Chi prende il sesso più seriamente? Chi prende le persone più sul serio? Playboy o il catechismo cattolico?”.
Qual è il significato di quella che ha chiamato “la verità del Sessantotto”? “La rivoluzione sessuale ha polverizzato la persona umana. La libertà genuina, la libertà che dispone di se stessa per donarsi, è l’unico contesto per un’etica sessuale umana. Contro la deprecazione manichea della sessualità. I dieci comandamenti sono un scuola elementare di libertà, della libertà vissuta nel bene e nella felicità e in accordo con leggi che ci liberano. Nella pietra del Korean War Memorial c’è scritto che ‘la libertà non è mai libera’. I comandamenti non sono capricci e ingiunzioni, ma fondamenta morali emerse dal desiderio umano per la felicità. La libertà per eccellenza è la libertà che soddisfa i profondi legami del cuore umano. Così la chiesa sostiene che l’aborto non è questione di morale sessuale ma di giustizia pubblica, di quinto comandamento. Per questo la controversia sull’iconoclastia è stata dunque decisiva. Il cattolicesimo è realismo. I difensori delle icone erano nel giusto perché in gioco non c’era altro che la richiesta cristiana di ‘toccare la verità della nostra salvezza’. La cristianità non è solo una questione di idee, seppur vere. E’ materia di verità incarnate, di un Dio che diventa uomo”.
Il tema della bellezza secondo Weigel si intreccia alla nuova offensiva dualistica e gnostica. “Lo gnosticismo si presenta oggi sotto molte vesti. Ma ci sono delle costanti inossidabili: la negazione della bontà del mondo naturale, una concezione dualistica di Dio e una teoria della salvezza in cui si fornisce all’uomo il biglietto per uscire dal corrotto mondo materiale. Il femminismo e il sessismo sono fenomeni gnostici. La chiesa ha sempre combattuto lo gnosticismo perché insegna una falsa visione di Dio, una concezione dannata della creazione e della natura e una falsa teoria della salvezza: la cristianità insegna che tutti gli uomini possono essere salvati e che Dio vuole salvare tutti gli uomini, non solo una élite gnostica. Virilità e femminilità sono realtà iconografiche, terrestri e visibili attraverso le quali impariamo a conoscere il divino, come nella Cappella Sistina. Uomo e donna sono radicalmente uguali di fronte a Dio, ma non sono icone intercambiabili alla sua presenza nella creazione. La chiesa cattolica così prende molto più seriamente ‘uomo’ e ‘donna’ di quanto non facciano gli gnostici che li riducono a costruzioni culturali, sotto il ‘gas del nichilismo’ di cui parlava Flannery O’Connor. Il mondo dei nichilisti è in bianco e nero, a due dimensioni, c’è solo il me, solo piaceri transeunti su cui indulgere. L’immaginazione cattolica ci insegna a vedere il mondo in technicolor, a vivere in tre dimensioni. Pensiamo alle deliranti forme di femminismo in cui la biologia è puro niente o alla riduzione freudiana della condizione umana a sola psiche. Lo gnosticismo dunque è pericoloso per la società, prendiamo le frontiere del biotech. Questi uomini e donne sono sofisticati, intelligentissimi, per loro il nulla è un autentico dono. Dopo il secondo e terzo drink della serata, questi scienziati ti dicono che sono coinvolti in un affare immortale: rendere gli esseri umani immortali, fino alla nausea. L’umanità sarebbe infinitamente plastica, rimaneggiabile, fino allo sfinimento. E questo è ciò che vogliono fare: rifare la condizione umana producendo esseri umani. Idee disperate sulla persona umana, sposate alla tecnologia moderna, hanno già fatto del XX secolo una camera della morte”.
Il nichilismo di Zapatero, l’eugenetica anglosassone, la pianificazione familiare per Weigel sono capitoli di un’offensiva culturale non negoziabile. “Sono tutte forme di negazione della Genesi e della realtà stessa. Ma alla lunga non reggeranno perché gnosticismo e democrazia sono incompatibili. Il cristianesimo invece è bellezza, bellezza nemica del nichilismo. Può il Nulla aver prodotto la cattedrale di Chartres, pietra e vetro in cui è stata riversata l’obbedienza della fede? O i dipinti di Beato Angelico? O Mozart? O le sculture del Bernini? O la poesia di Dante e i sonetti di Shakespeare? Se solo potessimo convertire i cinici e i nichilisti alla bellezza, al bellissimo, allora potremmo farlo anche con il bene e il vero. La bellezza è qualcosa che anche i più moderni scettici possono conoscere. Come Agostino, tutti noi bruciamo per l’abbraccio della bellezza che è sempre la stessa e sempre nuova. La pietà ha ancora una possibilità, deve averla. Sono da poco diventato nonno e solo ora so che la pietà è l’unico sentimento dell’autogoverno delle persone, di coloro che consultano gli antenati e la progenie nell’assumere certe decisioni. Dall’inizio della storia umana, la creazione degli esseri umani come persone, come maschio e femmina, pienamente umani ma differenti, è una realtà sacramentale. Il nostro prendere vita come uomini e donne è come rendere visibile l’invisibile. E’ la voce degli angeli, altro segno del trascendente. Nella Genesi non c’è che il lato straordinario dell’ordinario”.
Perché Adamo ed Eva provano vergogna per la propria nudità? “Non provano pudore quando vivono nel donarsi a vicenda. Il peccato originale che produce vergogna è nel concepirsi come ‘qualcosa’. Non è peccato perché Dio lo ha definito tale, ma perché viola la verità della nostra umanità inscritta nell’uomo e nella donna. Eros e agape, l’amore sessuale è icona di questa grande verità. Il matrimonio non è un’istituzione che lo stato può ridefinire. ‘Scelta’ è la parola magica che ti evita di decidere sulla questione centrale. L’Homo Voluntatis non può spiegare perché alcune cose che ‘possono’ essere fatte non ‘devono’ essere fatte”.
Questa drammaturgia di Weigel si conclude sulle pagine di Aldous Huxley. “Il suo mondo non è oppressivo come ‘1984’ di Orwell. Quella di Huxley è un’antiutopia felice. Ma è un’umanità rachitica, mondo di anime senza passione, sacrificio, sofferenza, sorpresa, desiderio, in una parola, un mondo senza amore. Non c’è più significato nella discesa nel mondo fisico, un mondo in cui l’immediata gratificazione fisica e psichica era sempre a disposizione nella forma di un sostituto della voce degli angeli”. Era così già dall’antichità. “Nell’Iliade e nell’Odissea gli immortali sono stupidi e frivoli; i mortali di Omero sono pieni di coraggio e passione. Il nostro morire vivendo è di ogni giorno, è parte di una preghiera. Ciò che Huxley prevedeva come una possibilità scientifica oggi è un fatto. La Human Fertilisation and Embryology Authority ricorda il Conditioning Center di Huxley. Viviamo nell’anticamera del Nuovo Mondo. La domanda ‘cosa diventeremo?’ ha sempre perseguitato il genere umano. Grazie a Watson e Crick, ora siamo a un bivio nella strada della civiltà. La morte sarà scelta come soluzione alla noia terminale. Possiamo scegliere di abbandonare la nostra libertà e porre fede in una felicità mondana. Ma possiamo anche vedere, nel Nuovo Mondo, dove ci porta tutto questo. Il cattolicesimo ci dice non solo che siamo capaci di grandezza, ma che la grandezza è da noi richiesta. Il nuovo mondo è un mondo di auto-indulgenza organizzata razionalmente. Il mondo dei santi è invece un mondo di carità stravagante e radicale. Il nuovo mondo è piatto, senza dolore, gratuito. Il mondo dei santi è scosceso e qualche volta doloroso. Qual è un mondo più umano? Qual è il mondo liberato? Qual è il mondo in cui vuoi vivere la tua vita?”.
di Giulio Meotti
Tratto da Il Foglio del 24 giugno 2006
E’ il racconto di un elezione pontificia che si trasforma, pagina dopo pagina, nel canovaccio letterario del pensiero di Benedetto XVI. L’ultimo libro di George Weigel, “God’s Choice” (che sarà tradotto anche in Italia) parla la lingua di un declino autentico e ha il dono di una stanchezza che annotta nella plasticità di un ratzingerismo aulico, patristico. Se il fanatismo, come diceva Emile Cioran, è la tara capitale che dà all’uomo il gusto dell’efficacia, della profezia e del terrore, Weigel brandisce una teologia del nitore antifanatico dallo spessore confortante e con una dignità figurativa innestata nella riflessione come la colonna vertebrale in un corpo, mantenendola dritta. Il suo humour senza brio, unito a una solitaria predilezione per la libertà, ricorda molto l’ansia visionaria di George Bernanos, che nel 1927 scrisse che “la nostra specie sarà lentamente corrosa come una trave da quei funghi invisibili che in poche settimane riducono un ceppo di quercia in una materia spugnosa che si sfalda sotto la pressione di un dito”. Leggendo Weigel si ha la stessa identica idea di sbriciolamento.
Direttore dell’Ethics and Public Policy Center, biografo acclamato di Karol Wojtyla e considerato il teologo più influente e ascoltato degli Stati Uniti, Weigel racconta al Foglio “l’anno di Benedetto”, il cui pensiero si traduce nell’idea che l’uomo non è un essere che progredisce, quanto l’essere che non è messo al sicuro da nessun progresso, ma che deve sempre, di continuo, scegliere fra bene e male. “In occidente è in corso una lotta per una domanda fondamentale: può la civiltà emersa dall’interazione di Gerusalemme, Atene e Roma sopravvivere a una prosperità, salute, longevità fisica, libertà e sicurezza senza precedenti? Ancora, può l’occidente mantenere in vita il proprio esperimento di autogoverno se diventa ciò che Zbigniew Brzezinski ha chiamato ‘la cornucopia permissiva’? L’abbondanza ha prodotto egotismo e prosperità, egoismo verso il futuro e incapacità di trarre le più elementari conclusioni morali sull’imperativo di resistere al male. Il cardinale Lehmann ha detto che ‘gli esseri umani non possono vivere nel silenzio’. Invece oggi gli uomini e le donne cercano di vivere ‘nel silenzio’, dimenticano come andare al di là di se stessi. Per questo, suggerisce Lehmann, l’Europa si sta spopolando”.
Per questo, aggiunge Weigel, la prima enciclica di Ratzinger, “Deus caritas est”, arriva “come un drink rinfrescante. Quando il salmista ci chiede di contare i nostri giorni, ci sta insegnando una grande verità. Nella grammatica di Ratzinger l’eros è un ‘esodo’. L’emozione oggi ha invece sostituito la ragione come arbitro del giudizio. Il nuovo Benedetto è un uomo convinto che le idee abbiano davvero conseguenze sul mondo e che le società umane non possano costruire le proprie fondamenta su falsi dèi. Il filosofo Charles Taylor ha coniato il termine ‘umanesimo esclusivistico’. Sono le tentazioni moderne del totalitarismo, di un paganesimo sposato alla tecnologia. Un Nuovo Medioevo sta per sorgere in quei laboratori dove la procreazione umana è trasformata in produzione umana”.
Medioevo tristemente illuminato dai successi seriali di una tecnoscienza che vive di quello che Ratzinger ha chiamato riduzionismo biologico. “Un fenomeno che è stato reso evidente da nazisti e comunisti, dai loro esperimenti medici sugli esseri umani, la ‘vita indegna di essere vissuta’. E’ la fabbrica di una società giusta. Fortunatamente sia la ragione sia la scienza sono dalla nostra parte nella difesa della vita dal concepimento alla morte. I manuali onesti di embriologia ci insegnano che il prodotto della creazione umana è un essere umano, non qualcosa che ‘diventerà’ un essere umano. La ragione poi ci spiega che niente che non è umano sarà umano e che niente di ciò che è umano sarà mai qualcos’altro. La domanda politica è se riconosceremo l’umanità dell’innegabile creatura e le offriremo protezione con le leggi. E se non lo faremo, cosa ci impedirà di dichiarare altre classi umane al di fuori della comunità degna di legalità? Gli handicappati? Le ‘bucce umane’? E’ genuina quella democrazia in cui i ‘sani’ hanno il ‘diritto’ di disporre dei ‘malati’?”. Una domanda talmente attuale che il professor Len Doyal dell’Università di Londra ha appena affermato che i medici dovrebbero poter “terminare” le vite anche di quei malati che non ne hanno fatto esplicita richiesta e che non possono più “decidere”.
“Henri de Lubac negli anni Quaranta aveva compreso che l’adorazione umanistica porta alla distruzione umana. E’ la manifattura biotecnica dell’humanum. Ho letto il ‘Nuovo Mondo’ di Aldous Huxley al liceo. Poi l’ho ripreso due estati fa. E’ pazzesco nel suo essere talmente attuale. Quando la manifattura sostituisce la generazione dei figli, la tentazione di una produzione di esseri umani diverrà irresistibile, la creazione di esseri umani inferiori. Siamo in grado già oggi di creare ‘bambini su misura’, che però non significherà mai un essere umano indipendente, ma la copia di un ‘io’, di un desiderio. Se siamo la sola misura di noi stessi, ‘io’ sono la sola misura di ‘me’. Ma il ‘me’ che mi rende una persona unica è più di un fagotto di neuroni. I falsi umanesimi hanno creato montagne di corpi e oceani di sangue, Auschwitz e il Gulag, aborti e manifattura in vitro. Questo è l’auto-cannibalismo della libertà. Un utilitarismo rinforzato da false nozioni di compassione e di hubrys scientifica”.
Il Papa ha parlato di coloro che “tratti in inganno dall’ateismo, ritengono e cercano di dimostrare che è scientifico pensare che tutto sia privo di guida e di ordine, come in balìa del caso”. “E’ pazzesco che così tante persone intelligenti, ammaliate dalla nozione che la fede religiosa sia intellettualmente soffocante, abbiano una convinzione fideistica per cui la complessità straordinaria del mondo naturale sia un caso fortunato, il prodotto di processi chimici cosmici. Questo mi colpisce sempre come qualcosa di incredibile. Sappiamo che la terra è tonda, ma viviamo spesso come se il mondo fosse piatto”.
Weigel ha un debito nei confronti del filosofo americano Alasdair MacIntyre, che più di vent’anni fa denunciò l’“emotivismo morale”. “L’emotivismo conduce a quello che Ratzinger chiama ‘la dittatura del relativismo’, relativismo imposto dal potere coercitivo della legge. MacIntyre aveva ragione nello scrivere che ‘se la tradizione della virtù è stata in grado di sopravvivere agli orrori dell’ultima età oscura, non siamo del tutto privi di fondamenti per la speranza. Questa volta, però, i barbari non aspettano di là dalle frontiere: ci hanno già governato per parecchio tempo’”.
La chiesa cattolica è coperta da una coltre di fumo ideologico che trasforma un divieto in capricco di magistero, anziché in quel principio di ragione non negoziabile basato su una radicale affermazione della capacità umana. “Il no cattolico alla concezione del matrimonio come transazione fra ‘adulti consenzienti’ è basato su un sì vecchio cinquemila anni. Il no alle tecnologie riproduttive è fondato sul sì alla dignità della persona umana e sul dramma di essere umani ridotti a oggetti commerciali. Uomo e donna, padre e madre sono letteralmente icone. E’ iconografico anche il prendere i voti del prete, è il linguaggio del corpo su cui è costruito. Un genio pirotecnico del moderno mondo cattolico, Hans Urs von Balthasar, ha detto che la chiesa è creata a immagine delle grandi figure del Nuovo Testamento. La chiesa dell’evangelizzazione a immagine di san Paolo, l’apostolo dei Gentili. La chiesa della contemplazione a immagine dell’apostolo Giovanni; quella dell’autorità a immagine di Pietro, al quale Cristo ha dato il potere delle chiavi. La divinizzazione dell’uomo è stata possibile grazie a quella che il cardinale Christoph Schönborn chiama l’umanizzazione di Dio. Oggi invece un orribile gnosticismo copre la società di una nebbia soffocante. Siamo finestre affacciate su verità profonde e la vita non è materia plastica, manipolabile e biodegradabile. L’obiettivo del nuovo gnosticismo è creare una società in cui, per la prima volta nella storia umana, ogni possibile rapporto sessuale diventa materia privata senza conseguenze per cultura, natura, legge, società. Un tempo la chiamavamo ‘decadenza’. Oggi si parla di ‘liberazione’. Ma il nuovo vocabolario non muta la sostanza delle cose. La chiesa insegna che l’amore nei confini del matrimonio è icona della vita interiore di Dio. Chi prende il sesso più seriamente? Chi prende le persone più sul serio? Playboy o il catechismo cattolico?”.
Qual è il significato di quella che ha chiamato “la verità del Sessantotto”? “La rivoluzione sessuale ha polverizzato la persona umana. La libertà genuina, la libertà che dispone di se stessa per donarsi, è l’unico contesto per un’etica sessuale umana. Contro la deprecazione manichea della sessualità. I dieci comandamenti sono un scuola elementare di libertà, della libertà vissuta nel bene e nella felicità e in accordo con leggi che ci liberano. Nella pietra del Korean War Memorial c’è scritto che ‘la libertà non è mai libera’. I comandamenti non sono capricci e ingiunzioni, ma fondamenta morali emerse dal desiderio umano per la felicità. La libertà per eccellenza è la libertà che soddisfa i profondi legami del cuore umano. Così la chiesa sostiene che l’aborto non è questione di morale sessuale ma di giustizia pubblica, di quinto comandamento. Per questo la controversia sull’iconoclastia è stata dunque decisiva. Il cattolicesimo è realismo. I difensori delle icone erano nel giusto perché in gioco non c’era altro che la richiesta cristiana di ‘toccare la verità della nostra salvezza’. La cristianità non è solo una questione di idee, seppur vere. E’ materia di verità incarnate, di un Dio che diventa uomo”.
Il tema della bellezza secondo Weigel si intreccia alla nuova offensiva dualistica e gnostica. “Lo gnosticismo si presenta oggi sotto molte vesti. Ma ci sono delle costanti inossidabili: la negazione della bontà del mondo naturale, una concezione dualistica di Dio e una teoria della salvezza in cui si fornisce all’uomo il biglietto per uscire dal corrotto mondo materiale. Il femminismo e il sessismo sono fenomeni gnostici. La chiesa ha sempre combattuto lo gnosticismo perché insegna una falsa visione di Dio, una concezione dannata della creazione e della natura e una falsa teoria della salvezza: la cristianità insegna che tutti gli uomini possono essere salvati e che Dio vuole salvare tutti gli uomini, non solo una élite gnostica. Virilità e femminilità sono realtà iconografiche, terrestri e visibili attraverso le quali impariamo a conoscere il divino, come nella Cappella Sistina. Uomo e donna sono radicalmente uguali di fronte a Dio, ma non sono icone intercambiabili alla sua presenza nella creazione. La chiesa cattolica così prende molto più seriamente ‘uomo’ e ‘donna’ di quanto non facciano gli gnostici che li riducono a costruzioni culturali, sotto il ‘gas del nichilismo’ di cui parlava Flannery O’Connor. Il mondo dei nichilisti è in bianco e nero, a due dimensioni, c’è solo il me, solo piaceri transeunti su cui indulgere. L’immaginazione cattolica ci insegna a vedere il mondo in technicolor, a vivere in tre dimensioni. Pensiamo alle deliranti forme di femminismo in cui la biologia è puro niente o alla riduzione freudiana della condizione umana a sola psiche. Lo gnosticismo dunque è pericoloso per la società, prendiamo le frontiere del biotech. Questi uomini e donne sono sofisticati, intelligentissimi, per loro il nulla è un autentico dono. Dopo il secondo e terzo drink della serata, questi scienziati ti dicono che sono coinvolti in un affare immortale: rendere gli esseri umani immortali, fino alla nausea. L’umanità sarebbe infinitamente plastica, rimaneggiabile, fino allo sfinimento. E questo è ciò che vogliono fare: rifare la condizione umana producendo esseri umani. Idee disperate sulla persona umana, sposate alla tecnologia moderna, hanno già fatto del XX secolo una camera della morte”.
Il nichilismo di Zapatero, l’eugenetica anglosassone, la pianificazione familiare per Weigel sono capitoli di un’offensiva culturale non negoziabile. “Sono tutte forme di negazione della Genesi e della realtà stessa. Ma alla lunga non reggeranno perché gnosticismo e democrazia sono incompatibili. Il cristianesimo invece è bellezza, bellezza nemica del nichilismo. Può il Nulla aver prodotto la cattedrale di Chartres, pietra e vetro in cui è stata riversata l’obbedienza della fede? O i dipinti di Beato Angelico? O Mozart? O le sculture del Bernini? O la poesia di Dante e i sonetti di Shakespeare? Se solo potessimo convertire i cinici e i nichilisti alla bellezza, al bellissimo, allora potremmo farlo anche con il bene e il vero. La bellezza è qualcosa che anche i più moderni scettici possono conoscere. Come Agostino, tutti noi bruciamo per l’abbraccio della bellezza che è sempre la stessa e sempre nuova. La pietà ha ancora una possibilità, deve averla. Sono da poco diventato nonno e solo ora so che la pietà è l’unico sentimento dell’autogoverno delle persone, di coloro che consultano gli antenati e la progenie nell’assumere certe decisioni. Dall’inizio della storia umana, la creazione degli esseri umani come persone, come maschio e femmina, pienamente umani ma differenti, è una realtà sacramentale. Il nostro prendere vita come uomini e donne è come rendere visibile l’invisibile. E’ la voce degli angeli, altro segno del trascendente. Nella Genesi non c’è che il lato straordinario dell’ordinario”.
Perché Adamo ed Eva provano vergogna per la propria nudità? “Non provano pudore quando vivono nel donarsi a vicenda. Il peccato originale che produce vergogna è nel concepirsi come ‘qualcosa’. Non è peccato perché Dio lo ha definito tale, ma perché viola la verità della nostra umanità inscritta nell’uomo e nella donna. Eros e agape, l’amore sessuale è icona di questa grande verità. Il matrimonio non è un’istituzione che lo stato può ridefinire. ‘Scelta’ è la parola magica che ti evita di decidere sulla questione centrale. L’Homo Voluntatis non può spiegare perché alcune cose che ‘possono’ essere fatte non ‘devono’ essere fatte”.
Questa drammaturgia di Weigel si conclude sulle pagine di Aldous Huxley. “Il suo mondo non è oppressivo come ‘1984’ di Orwell. Quella di Huxley è un’antiutopia felice. Ma è un’umanità rachitica, mondo di anime senza passione, sacrificio, sofferenza, sorpresa, desiderio, in una parola, un mondo senza amore. Non c’è più significato nella discesa nel mondo fisico, un mondo in cui l’immediata gratificazione fisica e psichica era sempre a disposizione nella forma di un sostituto della voce degli angeli”. Era così già dall’antichità. “Nell’Iliade e nell’Odissea gli immortali sono stupidi e frivoli; i mortali di Omero sono pieni di coraggio e passione. Il nostro morire vivendo è di ogni giorno, è parte di una preghiera. Ciò che Huxley prevedeva come una possibilità scientifica oggi è un fatto. La Human Fertilisation and Embryology Authority ricorda il Conditioning Center di Huxley. Viviamo nell’anticamera del Nuovo Mondo. La domanda ‘cosa diventeremo?’ ha sempre perseguitato il genere umano. Grazie a Watson e Crick, ora siamo a un bivio nella strada della civiltà. La morte sarà scelta come soluzione alla noia terminale. Possiamo scegliere di abbandonare la nostra libertà e porre fede in una felicità mondana. Ma possiamo anche vedere, nel Nuovo Mondo, dove ci porta tutto questo. Il cattolicesimo ci dice non solo che siamo capaci di grandezza, ma che la grandezza è da noi richiesta. Il nuovo mondo è un mondo di auto-indulgenza organizzata razionalmente. Il mondo dei santi è invece un mondo di carità stravagante e radicale. Il nuovo mondo è piatto, senza dolore, gratuito. Il mondo dei santi è scosceso e qualche volta doloroso. Qual è un mondo più umano? Qual è il mondo liberato? Qual è il mondo in cui vuoi vivere la tua vita?”.
«C’è un orecchio che non sente là dove sono le solitarie ragioni d’Israele»
7 Agosto 2006
«C’è un orecchio che non sente là dove sono le solitarie ragioni d’Israele»
Ancora un ringhio dal buio. Ahmadinejad. L’altro giorno l’orco con la giacchetta ha detto che la soluzione è la distruzione di Israele. E’ lui il nostro partner per la pace. Ringhia – e molti non sentono. Allora siamo qui a parlare di sordità. C’è una costante disparità di udito verso la Storia ebraica, non sentita quella, sentita quella di chiunque altro. E risuona forte la sproporzione della condanna ecumenica della violenza e questo inudito, continuo ringhio nell’aria. Tutti potremmo sentirlo. Eppure molti orecchi non sentono la limpidezza malefica, questa cristallina purezza alla rovescia: “L’unica soluzione è la distruzione d’Israele”. Il male ha l’astuzia per regnare. C’è un orecchio che non funziona, là dove risuonano le solitarie ragioni d’Israele. Allora mi ricordo. Quasi nessuno degli amici di un tempo, ragazzi con me nella sinistra dei primi anni 70, al Manifesto, ai concerti jazz che organizzavamo, con Don Cherry e Antony Braxton, ragazzi con cui inventavamo i locali underground e la satira ruggente – nessuno di loro chiede, o ha mai chiesto, notizie dei miei fratelli e dei miei nipoti, dei miei vecchi quando ancora c’erano, a Haifa e a Gerusalemme. C’è questo orecchio che non sente il rumore degli scoppi in Israele – un problema di sentire, che è anche dei sentimenti. Eppure i ragazzi del rock, del Manifesto, dell’underground, della satira stavano in ascolto atterrito ai racconti su mio padre in fuga dal fascismo, su mio padre che dai partigiani riceve il messaggio della madre deportata, scritto su pezzo di tela con un chiodo intinto nel sangue e lanciato sulla ferrovia da un vagone bestiame. “Figlio mio, addio. Mamma”. Una volta, complice Firenze ai nostri piedi, e l’infilata di ponti sull’Arno, ebbi il coraggio di dire tutto lo strazio a quelli del rock e della sinistra. Piangemmo insieme. Ma c’era l’orecchio che anche allora non voleva sentire. Quello situato proprio dalla parte dove si trova Gerusalemme. Mio padre e mia madre, i miei fratelli, se n’erano appena andati in Israele, e nessuno di loro mi chiedeva del presente: d’Israele. C’erano solo domande sulla Seconda guerra mondiale. I fascisti, i partigiani e i tedeschi, e che la mia famiglia abitasse in Israele era tra le pieghe dei fatti, o forse sotto a pieghe che io stesso provvedevo a piegare, una sull’altra. Per coprire questa enorme, indecorosa ingiustizia che la mia famiglia era andata “là”. E quando a volte la parola veniva detta, Israele, voleva dire che c’era stata una momentanea uscita dalla sordità per loro, e da una quotidiana solitudine per me. Dicevano Israele ed era come se qualcuno a un tratto alzasse il coperchio della botola in fondo alla quale io abitavo, in qualche profondità ventrale della terra, dove era ricoverata la vergogna sionista. Assurdi Ebrei, in piedi in una propria patria. La botola si apriva e mi raggiungeva una ventata d’aria buona, la normale luce del giorno. Come se anche io potessi approdare, per un breve sollievo concesso, alle possibilità della vita. Succedeva che anche io avevo un presente, e non solo il passato. Non solo la Shoah, ma addirittura Israele. Esisteva la mia famiglia, i miei fratelli, e questo padre dipinto dagli amici comunisti come un dentista tiranno che era andato a Haifa. E per un momento, complice qualche bicchiere di vino e una panchina su Firenze, si scioglievano le lingue. Una specie di risolino nervoso affiorava sulle loro labbra e i miei amici, e davvero eravamo amici, e poi davvero di sinistra, mi chiedevano turbati di questa nazione dall’altra parte del mare. Volevano sapere perché la mia famiglia viveva in Israele. E per una sera non sordi, mi chiedevano: “Ma com’è, lì?”. Non dicevano Israele, dicevano “lì”. Pareva di essere interrogato su come fosse possibile violare la legge di gravità e abitare in un pianeta sospeso sul niente e venuto dal niente. “Lì”, uno stato senza nome, a volte chiamato con malizia Palestina. Come se non fossimo nel ’75, ma nell’anno 20 d. C. e per un puro caso non conversassimo in latino. “Si dice Israele”, dissi una volta. “Via – mi fu risposto – Palestina, Israele, è la stessa”. Israele era un posto dalla incongrua esistenza storica. Nessuno di questi miei amici, ognuno colmo di Marx, di Gramsci e di Marcuse, sapeva ricollegare Israele alla Shoah e a venti secoli di antigiudaismo – proprio come accade ora. E negli anni 70, questi amici, questi giovani già sordi, insegnanti, bibliotecari, artisti, mi dicevano: “Ma che lingua parlano, lì?”. “In ebraico”, rispondevo. Loro scuotevano la testa. “L’ebraico”, come se gli avessi detto che a Tel Aviv si lavavano i denti con la sabbia. Poi la botola si richiudeva e io tornavo al buio. Così avveniva la mia scoperta, progressiva e sempre meno decente, che noi, gli Ebrei, fossimo spendibili come vittime della guerra, come uomini in fuga dal fascismo, come specchio dell’orrore nazista; ma non come uomini e donne d’Israele, del presente, non come parte della rinascita ebraica, dopo la Catastrofe. E così, mentre gli ex fascisti ed ex avanguardisti dovevano ancora fare i conti con l’olio di ricino, le bastonature agli oppositori, e lo schifo allucinato delle leggi razziali, dalla parte opposta gli ex antifascisti dovevano ancora fare i conti con l’esistenza dello stato d’Israele. E anche ora succede che nessuno senta il suono di ciò che proviene da “lì”; che voglia riconoscere il presente ebraico. Da quale lunga via dolorosa questo presente nasca. L’altro giorno mi scrive mio nipote Moshe, sulla rete. E’ a Petach Tikva coi kabbalisti di Baal Asulam. Ogni notte alle tre si alzano e studiano col rav. Laitman sino alle sei del mattino e la lezione va in onda in tutto il mondo, tradotta in inglese, spagnolo, italiano, tedesco. Ci parliamo che è “tishà beav”, il nono giorno del mese di av, data molteplice della catastrofe ebraica lungo la Storia. Giorno di lutto e di digiuno. Il 9 di av del 586 a. C., i Babilonesi distrussero il Tempio di Salomone. Ci fu una diaspora di 400 anni e quando gli Ebrei tornarono a Gerusalemme, per prima cosa lessero la Torah e la gente piangeva e singhiozzava e i capi del popolo dicevano: non fate così. Il 9 di av dell’anno 70, i romani distrussero il secondo Tempio, e ci fu una diaspora di duemila anni. Il 9 di av del 1492 gli ebrei furono cacciati dalla Spagna, convertiti a forza, messi al rogo, perseguitati dall’Inquisizione e cominciarono a pregare in ebraico sottovoce, di nascosto. L’altra notte a Petach Tikva quelli di Baal Asulam erano seduti per terra, col rabbino, scalzi e a digiuno. C’era la lezione sulla distruzione del Tempio. Leggo le parole di Moshe e bevo questo lutto, nel lutto della guerra. Ahmadinejad dice che Israele deve essere distrutta. Se Israele non ci fosse più, chi racconterebbe la Storia? Chi parlerebbe dei vasi infranti, chi ripeterebbe le lezioni del rav. Ashlag, maestro del maestro Laitman? Poi mi telefona un amico, da ragazzi andavamo a vedere la Fiorentina. Chiede notizie dei miei, a Haifa. Racconta di un suo conoscente, una persona mite. Parlano della situazione in Libano. L’amico lo guarda e fa: “Sono duemila anni che loro rompono”. Siamo a questo punto della notte.
Alessandro Schwed
fonte Il Foglio del 6.8.2006
«C’è un orecchio che non sente là dove sono le solitarie ragioni d’Israele»
Ancora un ringhio dal buio. Ahmadinejad. L’altro giorno l’orco con la giacchetta ha detto che la soluzione è la distruzione di Israele. E’ lui il nostro partner per la pace. Ringhia – e molti non sentono. Allora siamo qui a parlare di sordità. C’è una costante disparità di udito verso la Storia ebraica, non sentita quella, sentita quella di chiunque altro. E risuona forte la sproporzione della condanna ecumenica della violenza e questo inudito, continuo ringhio nell’aria. Tutti potremmo sentirlo. Eppure molti orecchi non sentono la limpidezza malefica, questa cristallina purezza alla rovescia: “L’unica soluzione è la distruzione d’Israele”. Il male ha l’astuzia per regnare. C’è un orecchio che non funziona, là dove risuonano le solitarie ragioni d’Israele. Allora mi ricordo. Quasi nessuno degli amici di un tempo, ragazzi con me nella sinistra dei primi anni 70, al Manifesto, ai concerti jazz che organizzavamo, con Don Cherry e Antony Braxton, ragazzi con cui inventavamo i locali underground e la satira ruggente – nessuno di loro chiede, o ha mai chiesto, notizie dei miei fratelli e dei miei nipoti, dei miei vecchi quando ancora c’erano, a Haifa e a Gerusalemme. C’è questo orecchio che non sente il rumore degli scoppi in Israele – un problema di sentire, che è anche dei sentimenti. Eppure i ragazzi del rock, del Manifesto, dell’underground, della satira stavano in ascolto atterrito ai racconti su mio padre in fuga dal fascismo, su mio padre che dai partigiani riceve il messaggio della madre deportata, scritto su pezzo di tela con un chiodo intinto nel sangue e lanciato sulla ferrovia da un vagone bestiame. “Figlio mio, addio. Mamma”. Una volta, complice Firenze ai nostri piedi, e l’infilata di ponti sull’Arno, ebbi il coraggio di dire tutto lo strazio a quelli del rock e della sinistra. Piangemmo insieme. Ma c’era l’orecchio che anche allora non voleva sentire. Quello situato proprio dalla parte dove si trova Gerusalemme. Mio padre e mia madre, i miei fratelli, se n’erano appena andati in Israele, e nessuno di loro mi chiedeva del presente: d’Israele. C’erano solo domande sulla Seconda guerra mondiale. I fascisti, i partigiani e i tedeschi, e che la mia famiglia abitasse in Israele era tra le pieghe dei fatti, o forse sotto a pieghe che io stesso provvedevo a piegare, una sull’altra. Per coprire questa enorme, indecorosa ingiustizia che la mia famiglia era andata “là”. E quando a volte la parola veniva detta, Israele, voleva dire che c’era stata una momentanea uscita dalla sordità per loro, e da una quotidiana solitudine per me. Dicevano Israele ed era come se qualcuno a un tratto alzasse il coperchio della botola in fondo alla quale io abitavo, in qualche profondità ventrale della terra, dove era ricoverata la vergogna sionista. Assurdi Ebrei, in piedi in una propria patria. La botola si apriva e mi raggiungeva una ventata d’aria buona, la normale luce del giorno. Come se anche io potessi approdare, per un breve sollievo concesso, alle possibilità della vita. Succedeva che anche io avevo un presente, e non solo il passato. Non solo la Shoah, ma addirittura Israele. Esisteva la mia famiglia, i miei fratelli, e questo padre dipinto dagli amici comunisti come un dentista tiranno che era andato a Haifa. E per un momento, complice qualche bicchiere di vino e una panchina su Firenze, si scioglievano le lingue. Una specie di risolino nervoso affiorava sulle loro labbra e i miei amici, e davvero eravamo amici, e poi davvero di sinistra, mi chiedevano turbati di questa nazione dall’altra parte del mare. Volevano sapere perché la mia famiglia viveva in Israele. E per una sera non sordi, mi chiedevano: “Ma com’è, lì?”. Non dicevano Israele, dicevano “lì”. Pareva di essere interrogato su come fosse possibile violare la legge di gravità e abitare in un pianeta sospeso sul niente e venuto dal niente. “Lì”, uno stato senza nome, a volte chiamato con malizia Palestina. Come se non fossimo nel ’75, ma nell’anno 20 d. C. e per un puro caso non conversassimo in latino. “Si dice Israele”, dissi una volta. “Via – mi fu risposto – Palestina, Israele, è la stessa”. Israele era un posto dalla incongrua esistenza storica. Nessuno di questi miei amici, ognuno colmo di Marx, di Gramsci e di Marcuse, sapeva ricollegare Israele alla Shoah e a venti secoli di antigiudaismo – proprio come accade ora. E negli anni 70, questi amici, questi giovani già sordi, insegnanti, bibliotecari, artisti, mi dicevano: “Ma che lingua parlano, lì?”. “In ebraico”, rispondevo. Loro scuotevano la testa. “L’ebraico”, come se gli avessi detto che a Tel Aviv si lavavano i denti con la sabbia. Poi la botola si richiudeva e io tornavo al buio. Così avveniva la mia scoperta, progressiva e sempre meno decente, che noi, gli Ebrei, fossimo spendibili come vittime della guerra, come uomini in fuga dal fascismo, come specchio dell’orrore nazista; ma non come uomini e donne d’Israele, del presente, non come parte della rinascita ebraica, dopo la Catastrofe. E così, mentre gli ex fascisti ed ex avanguardisti dovevano ancora fare i conti con l’olio di ricino, le bastonature agli oppositori, e lo schifo allucinato delle leggi razziali, dalla parte opposta gli ex antifascisti dovevano ancora fare i conti con l’esistenza dello stato d’Israele. E anche ora succede che nessuno senta il suono di ciò che proviene da “lì”; che voglia riconoscere il presente ebraico. Da quale lunga via dolorosa questo presente nasca. L’altro giorno mi scrive mio nipote Moshe, sulla rete. E’ a Petach Tikva coi kabbalisti di Baal Asulam. Ogni notte alle tre si alzano e studiano col rav. Laitman sino alle sei del mattino e la lezione va in onda in tutto il mondo, tradotta in inglese, spagnolo, italiano, tedesco. Ci parliamo che è “tishà beav”, il nono giorno del mese di av, data molteplice della catastrofe ebraica lungo la Storia. Giorno di lutto e di digiuno. Il 9 di av del 586 a. C., i Babilonesi distrussero il Tempio di Salomone. Ci fu una diaspora di 400 anni e quando gli Ebrei tornarono a Gerusalemme, per prima cosa lessero la Torah e la gente piangeva e singhiozzava e i capi del popolo dicevano: non fate così. Il 9 di av dell’anno 70, i romani distrussero il secondo Tempio, e ci fu una diaspora di duemila anni. Il 9 di av del 1492 gli ebrei furono cacciati dalla Spagna, convertiti a forza, messi al rogo, perseguitati dall’Inquisizione e cominciarono a pregare in ebraico sottovoce, di nascosto. L’altra notte a Petach Tikva quelli di Baal Asulam erano seduti per terra, col rabbino, scalzi e a digiuno. C’era la lezione sulla distruzione del Tempio. Leggo le parole di Moshe e bevo questo lutto, nel lutto della guerra. Ahmadinejad dice che Israele deve essere distrutta. Se Israele non ci fosse più, chi racconterebbe la Storia? Chi parlerebbe dei vasi infranti, chi ripeterebbe le lezioni del rav. Ashlag, maestro del maestro Laitman? Poi mi telefona un amico, da ragazzi andavamo a vedere la Fiorentina. Chiede notizie dei miei, a Haifa. Racconta di un suo conoscente, una persona mite. Parlano della situazione in Libano. L’amico lo guarda e fa: “Sono duemila anni che loro rompono”. Siamo a questo punto della notte.
Alessandro Schwed
fonte Il Foglio del 6.8.2006
Iscriviti a:
Post (Atom)

-
La Sapienza e la cristofobia di certi intellettuali italiani 13 gennaio 2008 Attenzione, preparano l’agguato al Papa L’ignoranza domina tra ...
-
Totus tuus network - Content : "Benedetto XVI: La cultura sociale dominante non vi aiuta a vivere la Parola di Gesù Osate decisioni def...
-
“Gli approfondimenti” 14 OTTOBRE 2009: NON PASSA LA LEGGE SULL’OMOFOBIA ED EMERGE L’INCOMPATIBILITA’ FRA IL PD E I CATTOLICI Dopo Lettonia...